18 Ottobre 2024
A Cutro un surplus di umanità, parla il regista Mimmo Calopresti (laragione.eu)
di Raffaela Mercurio
Con il film documentario “Cutro Calabria Italia”, il regista Mimmo Calopresti ha voluto trovare un senso a quella tragedia facendo la sola cosa da fare: raccontare

Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 il caicco “Summer Love”, partito da Izmir (in Turchia) con oltre 180 persone a bordo, si schiantò contro una secca durante una tempesta e naufragò davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro: persero la vita 94 migranti, tra cui 34 minori.
Imprecisato il numero dei dispersi. Con il film documentario “Cutro Calabria Italia”, il regista Mimmo Calopresti ha voluto trovare un senso a quella tragedia facendo la sola cosa da fare: raccontare. Finanziata dalla Fondazione Calabria Film Commission e prodotta da Silvia Innocenzi e Giovanni Saulini per Alfa Multimedia, l’opera sarà presentata domani alla IV edizione del Festival dell’Accoglienza di Torino.
«C’è solo un modo di gestire il fenomeno migratorio: l’umanità. C’è qualcosa che è più potente delle leggi e della politica ed è il rapporto fra le persone» ha detto il regista.
Già autore di documentari di successo come “La parola amore esiste” (vincitore del Nastro d’Argento come miglior soggetto originale), “L’abbuffata” o “Aspromonte, la terra degli ultimi”, Calopresti ci racconta com’è scattata la scintilla emotiva alla notizia di Cutro: «Come tutti, sono stato colpito dalla portata della tragedia. Mi sono soffermato sui numeri domandandomi però cosa ci fosse alle spalle, di umano, che meritava di non essere dimenticato. E così ho ascoltato tante testimonianze: dai parenti delle vittime che arrivavano raccontando i sogni di quelle povere persone scomparse in mare, all’incredibile solidarietà del popolo calabrese».
«Un surplus di umanità» come lo definisce Calopresti, che sembra insito nell’animo della popolazione calabrese di fronte a tragedie di questo tipo: «Ho notato un bisogno di esprimere umanità: parliamo di persone che vivono in uno dei luoghi più poveri d’Italia e che si sono riversati tutti su quella spiaggia per aiutare, sostenere, fare qualcosa. A testimonianza che, al di là di ogni espressione politica, è l’umanità che conta».
Un luogo santo e dannato, quello di Cutro, che come ricorda il regista era stato già scelto in passato per raccontare un altro tipo di storia: quella del “Vangelo secondo Matteo” diretto da Pier Paolo Pasolini. «Una parte del film è stata girata proprio in quei luoghi. Mi ha fatto ricordare una poesia: l’idea pasoliniana degli ultimi, sempre costretti a muoversi e sradicarsi per sopravvivere. Un po’ come i calabresi, grande popolo di migranti» sottolinea Calopresti.
Ed è quella poesia, “Profezia”, che forse può chiudere il cerchio: «Alì dagli Occhi Azzurri uno dei tanti figli di figli, scenderà da Algeri, su navi a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri sulle barche varate nei Regni della Fame. Porteranno con sé i bambini, e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del Lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini, sulle triremi rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni, vestiti di stracci asiatici, e di camicie americane. Subito i Calabresi diranno, come malandrini a malandrini: “Ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e formaggio!” Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli, e da lì a Barcellona, a Salonicco e a Marsiglia, nelle Città della Malavita (…)».
Luzi: «Una legge di cittadinanza per gli stranieri nati in Italia» (corriere.it)
di Goffredo Buccini
Il comandante dell’arma
«Gli stranieri nati in Italia sono italiani».
Alla guida dei carabinieri da metà gennaio 2021, Teo Luzi lascia, a novembre, con la stessa attenzione al sociale che l’ha distinto in quasi quattro anni da comandante generale dell’Arma. «La legge del ’92 — spiega — è obsoleta».
Una legge sulla cittadinanza «non più aderente al cambiamento che c’è stato» e, dunque, da ripensare ex novo nel senso dell’integrazione. Periferie dove non basta la risposta securitaria, «perché servono scuole, decoro urbano, qualità di vita dei quartieri». Un Paese stressato da Covid e guerre, «due macigni».
Arrivato alla guida dei carabinieri a metà gennaio 2021, Teo Luzi è prossimo al passo d’addio (andrà via a novembre). E lascia con la stessa attenzione al sociale che l’ha accompagnato in quasi quattro anni da comandante generale dell’Arma.
Com’è l’Italia oggi?
«Dovessi indicarle il sentimento prevalente tra i nostri compatrioti, direi: la preoccupazione. Che sfocia in tensioni, litigiosità… nei condomini, tra i banchi, sul lavoro. Nelle nostre sale operative si riversano episodi talvolta inspiegabili».
Parlando l’altro giorno ai suoi cadetti dell’Accademia di Modena ha proposto loro un antidoto: l’altruismo. Parola desueta.
«Questo è un mondo sempre più egoista, è vero. Ma ai ragazzi ho parlato di assistenza reciproca, anche nelle piccole difficoltà quotidiane. La capacità di ascolto dei carabinieri è una forma di altruismo».
Ed è uno strumento di lavoro per non perdere di vista uno snodo decisivo della nostra convivenza democratica: le periferie. I problemi di sistema in Germania e Francia lo dimostrano. È così anche per l’Italia?
«Assolutamente sì. Le periferie sono un vulnus nell’equilibrio sociale delle democrazie occidentali, bisogna garantire a chi ci vive la stessa qualità di vita di chi abita altrove. Sono aree che in Italia richiedono molta attenzione. Ma in Francia ne richiedono ancor di più: da noi non esistono banlieue dove le forze di polizia non possono entrare. Tanto è stato fatto. Ma molto ancora c’è da fare per rimuovere ostacoli che danno l’idea di vivere in serie B».
Quali ostacoli ad esempio?
«Penso alla qualità dell’istruzione. Alle strutture sportive. Alle strade e alle piazze. Penso a Caivano…».
Ci sarei arrivato. Sia sincero: è tutta realtà o anche spot?
«Sono stati fatti passi importanti, a 360 gradi. E non è solo un problema di polizia ma di socialità complessiva. L’Arma si è impegnata prima che arrivasse l’attenzione mediatica su Caivano. La Compagnia lì è nata nel 2021, voluta dall’allora ministro Lamorgese. Si è lavorato sulle scuole, anche in sinergia con noi. Non è un’isola felice, certo. Ma la qualità di vita è assimilabile al resto del territorio nazionale. E il modello Caivano va esportato in altre aree».
Quali sono quelle che vi preoccupano di più e su cui state intervenendo?
«A mente, Palermo, lo Zen: dove siamo riusciti a far accettare la stazione dei carabinieri nel quartiere, cosa non banale. I nostri lì fanno attività sociale: un tempo io allo Zen non potevo entrare. Bari, San Paolo. Librino a Catania. A Nord, Genova, il quartiere di Diamante. Pilastro a Bologna. Poi Cagliari Sant’Elia. Tor Bella Monaca a Roma. Lì abbiamo lavorato molto sulle occupazioni abusive. È un tema fondamentale».
La casa contesa tra ultimi e penultimi.
«Parliamo di migliaia di case occupate abusivamente, lo Stato non mette abbastanza attenzione al tema. Dietro un’occupazione c’è chi gestisce, si alimenta la criminalità territoriale. Serve una politica più concreta».
Però ora il governo ha sterzato, si colpiscono più duramente le occupazioni.
«E io sono assolutamente d’accordo. Poi capisco che servono anche soluzioni, ma quando questa soluzione è abusiva è il peggio: alimenta il distacco della percezione pubblica rispetto allo Stato».
A Casal di Principe, terra che davamo per bonificata, ci sono state due «stese» a poche ore dalle elezioni di giugno: rischiamo di tornare indietro in territori che pensavamo recuperati allo Stato?
«Io sono un po’ più ottimista. Ora lo Stato ha il controllo. Resta latente una forma, diciamo, culturale della criminalità, le “stese” sono messaggi criminali. Non siamo però agli anni Ottanta. E comunque quando lei parla di condizionamenti, bisogna pensare anche al Nord».
È, per dirla con Sciascia, la risalita della linea della palma?
«Beh, la criminalità organizzata rispetto alla politica locale si sente, hanno sciolto Comuni per infiltrazioni mafiose anche al Nord. Lì lavorano con un profilo economico-politico».
E allora da dove viene l’ottimismo?
«Abbiamo un quadro normativo avanzato. Una grande sensibilità della magistratura. Pochi Paesi al mondo, oggi, possono affrontare la criminalità organizzata come possiamo fare noi. L’arma del sequestro preventivo è fondamentale».
Non è il massimo del garantismo.
«Beh, se i beni provengono dal crimine e lo si dimostra con le indagini…».
La questione migratoria e la questione sociale delle periferie quanto si sovrappongono?
«Tanto. Le tensioni nelle periferie non sono risolte. Ci sono aspetti culturali, criminalità etnica. La nostra interposizione abbassa la conflittualità che però rimane latente. E c’è un altro tema…».
Dica.
«Quello degli italiani con genitori stranieri, le seconde generazioni. È emerso specie al Nord, in maniera non virulenta come in Francia: ma è una questione su cui bisogna aprire una riflessione».
Cioè?
«Bisogna favorire quanto più possibile l’integrazione. Sono italiani».
Favorirla con la cittadinanza?
«Sono italiani. Nelle periferie l’integrazione deve essere la regola. Non la fanno le forze di polizia. Si fa con la scuola, l’avviamento al lavoro».
Semplificando: se sono nato in Italia, faccio un certo numero di anni di scuola, devo averla o no la cittadinanza?
«Tutti i maggiori Paesi in Europa hanno un meccanismo di integrazione e anche l’Italia deve averlo. Quale sia, lo decida la politica. Ma il meccanismo di integrazione, con equilibrio politico, va trovato: si guardi alla Germania, alla Francia, all’Inghilterra».
Ma qui non c’è.
«Non c’è la legge. Ci vuole una legge. Tocca al Parlamento sovrano».
Per dirla chiara: la legge che oggi c’è, quella del 1992, è obsoleta?
«Non rispecchia più il cambiamento che c’è stato. Poi come debba essere la nuova, per tutelare la cultura italiana, tocca alla politica dirlo. La contrapposizione non porta da nessuna parte. Io personalmente sono molto aperto: occorre una normativa più moderna».
Quest’Italia è travagliata anche da gravi rigurgiti di antisemitismo. È una questione di sicurezza nazionale?
«Lo è. Si batte su un piano culturale. E non lasciando sole le comunità ebraiche. Un nostro generale, Angelosanto, è commissario del governo contro questo fenomeno».
I nostri anziani sono l’anello più debole della società.
«Sì, sono molto più vulnerabili, più soli. E quindi sono il bersaglio dei truffatori. Per l’anziano essere truffato è un trauma vero, dà un senso di vergogna, di fine. Così abbiamo messo su col Viminale una campagna d’informazione. Alla messa domenicale, nelle scuole per arrivare ai nonni, sui media. Anche Lino Banfi ci ha aiutato. Lui è per tutti il nonno d’Italia».

Come pensare l’educazione civica? (doppiozero.com)
Come pensare e progettare l’educazione civica in un contesto così complesso e difficile di crisi economica, sociale, politica e culturale?
Ci sono due possibilità: o arrancarsi sul conservare – anzi recuperare – quello che si ha paura di perdere, o, come dice Luciano Floridi in Il Verde e il Blu, cercare “buone idee per una strategia politica di governo che valorizzi e promuova le potenzialità al meglio, non solo come società postindustriale, ma come società matura dell’informazione”.
Si tratta di porre al centro la qualità delle relazioni e dei processi, chiedendoci – con responsabilità nei confronti dei bambini e dei ragazzi – quali riferimenti e strumenti proponiamo loro per intrepretare la realtà che vivono e il mondo in cui siamo immersi. Come immaginiamo di formare competenze civiche per aiutare i ragazzi a orientarsi e inserirsi con fiducia nei contesti dei cambiamenti attuali?
Una sfida così impegnativa per la scuola, in questo momento di crisi delle democrazie e della tenuta sociale, dovrebbe trovare negli indirizzi politici indicazioni e strumenti per un dibattito aperto, per un confronto culturale e pedagogico, ma anche supporto per essere messa nelle condizioni di operare con efficacia e con effettivo impatto nella propria comunità.
Invece le Linee guida emanate dal ministro Valditara disattendono queste aspettative. Dal lungo paragrafo di “Principi a fondamento dell’educuzione civica” emerge una visione ideologica, che ben ha descritto Marco Meotto in A scuola di Individualismo qui su Doppiozero: l’ed. civica non dovrebbe essere appannaggio delle convinzioni della maggioranza che governa, perché riguarda e impegna tutta la società e tutti coloro che sono responsabile della formazione dei nostri bambini e ragazzi.
Con una lunghissima lista di obiettivi di apprendimento (49 per la scuola primaria, 56 per la scuola secondaria di primo grado, 98 per la scuola secondaria raggruppati in 42 aree tematiche) si dice alle scuole cosa deve fare: così “tanta roba” che sarà davvero difficile per le scuole inserirla nei curricoli e l’educazione civica rischierà di tradursi concretamente in un enorme elenco di contenuti tra cui scegliere con chissà quale priorità o approfondimento.
Non sono inoltre considerate nelle nuove Linee Guida le condizioni indispensabili alle scuole per operare in maniera efficace, aspetti che erano emersi nella prima attuazione dell’insegnamento dell’ed. civica e che, del tutto ignorate anche ora, limitano la possibilità di sviluppare significativi processi formativi.

La valenza trasversale dell’educazione civica richiede tempi e capacità di progettazione e di coordinamento dei docenti di classe che sono un aspetto molto critico.
I docenti hanno 40 ore all’anno per fare la progettazione e valutazione collegiale di tutto il PTOF e dunque di tutti i progetti e le attività della scuola; nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i consigli di classe hanno cinque-sei incontri annuali in cui organizzare e gestire le attività di classe, comprese le progettazioni personalizzate. Come potrebbero i docenti operare insieme per l’educazione civica, che richiede molta condivisione e partecipazione?
A questo si aggiunge un ulteriore aspetto: i docenti non hanno obblighi di formazione e dunque le attività di coinvolgimento e approfondimento sull’educazione civica sono in balia della disponibilità dei docenti, che peraltro hanno urgenze di formazione su più ambiti di innovazione della didattica.
L’educazione civica, intesa come visione educativa condivisa e non come spezzatino di ore e contenuti distribuiti tra i docenti, implica poi non solo cultura pedagogica ma anche cultura organizzativa: capacità di operare in gruppo, di gestire leadership, di comunicazione e documentazione, di innovazione e autovalutazione per il miglioramento.
Come il ministero si occupa-preoccupa di questi problemi?
Nell’avvio dell’insegnamento dell’educazione civica è stato fatto un grande investimento di formazione dei referenti di ogni scuola: cosa ne è di queste figure? Non avendo un ruolo di middle management formalizzato, sono figure che non possono garantire continuità e che rischiano di operare in grandi difficoltà, date le criticità che sono state indicate sopra; non sempre riescono a guidare una progettazione unitaria della scuola e ad evitare che ogni consiglio di classe decida per conto suo cosa insegnare e cosa valutare.
A fronte di queste complessità conveniva dare alle scuole linee orientative con riferimento alla L. 92 e ai documenti di rilevanza internazionale, piuttosto che un elenco così dettagliato e parcellizzato di contenuti e obiettivi di apprendimento.
I documenti di rilevanza internazionale, importanti per la portata culturale e pedagogica, andavano utilizzati e considerati come riferimenti fondamentali di tutto l’impianto formativo e non semplicemente riportati in allegato come “documentazione di approfondimento”.

Penso ad esempio alle “Competenze per una cultura della democrazia” del Consiglio d’Europa (che hanno anche utili indicatori e descrittori per la progettazione e valutazione e un impianto molto più coerente degli obiettivi di apprendimento delle Linee guida), ai documenti Unesco “Educazione alla cittadinanza globale: temi e obiettivi di apprendimento” e Educazione agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile – obiettivi di apprendimento.
Per la cittadinanza digitale il DigComp2.2 è in parte recepito, ma era più sensato farne riferimento in modo integrale ed esplicito per incentivare le scuole a farne uso assieme agli altri strumenti il DigCompEdu e SELFIE per l’autovalutazione dell’organizzazione della scuola e dei docenti; si tratta infatti di strumenti che le scuole hanno già trovato indicati nel PIANO 4.0 di attuazione del PNRR per la costituzione di ambienti di apprendimento innovativi.
Tra le carenze –inammissibili – dei riferimenti internazionali ancor più sorprende la mancanza di connessione alle Competenze chiave di cittadinanza (citate solo due volte in modo marginale e indicate solo in allegato tra gli approfondimenti): si tratta del riferimento previsto dalla normativa (decreto ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024) per la progettazione e valutazione per competenze che le scuole devono effettuare nelle fasi del percorso scolastico; le otto competenze non solo indicano conoscenze e capacità ma anche gli atteggiamenti, così importanti per l’educazione civica. Le scuole dovranno considerare le 8 competenze e anche le linee guida in inutile e incomprensibile separazione.
La mancanza di impegno a dare impostazione unitaria e coerente alla dimensione della formazione della cittadinanza è anche evidente per altri ambiti della normativa e degli impegni della scuola: non è preso in considerazione il Patto di corresponsabilità che esplicita l’impegno reciproco della scuola degli studenti e delle famiglie e non si fa alcun riferimento alla progettazione strategica e alla definizione di obiettivi di apprendimento prioritari su cui la scuola deve peraltro fare rendicontazione, vincoli della progettazione del PTOF. Non si citano Indire e Invalsi e dunque si auspica che vengano definite dal Ministero le possibili forme di collaborazione e supporto alle scuole.
Infine accenniamo all’Indagine ICCS – International Civic and Citizenship Education Study promossa da IEA che si propone di vedere in che modo i giovani, in vari paesi del mondo, vengono preparati per svolgere in modo attivo il proprio ruolo di cittadini. Questa indagine dovrebbe essere considerata dal ministero e dalle scuole per come considera le competenze di cittadinanza, per come le rileva e per gli esiti che riguardano l’Italia.
Come abbiamo cercato qui di esprimere, intendiamo l’educazione civica innanzi tutto come visione educativa che interpreta le sfide che la società presenta, impegna in riflessione e richiede condivisione di come pensiamo la cittadinanza e la costruzione di una società democratica e sostenibile.
Nelle nostre scuole ci sono sensibilità e intelligenze che in questi anni hanno assunto impegni di progettazione e responsabilità di condivisione per la formazione alla cittadinanza; sapranno andare oltre all’elenco di cose da fare e alla frammentazione di ore tra docenti per dare senso alle attività che svolgono e curare le dimensioni relazionali e innovare le metodologie in ottica di trasversalità e interdisciplinarità.
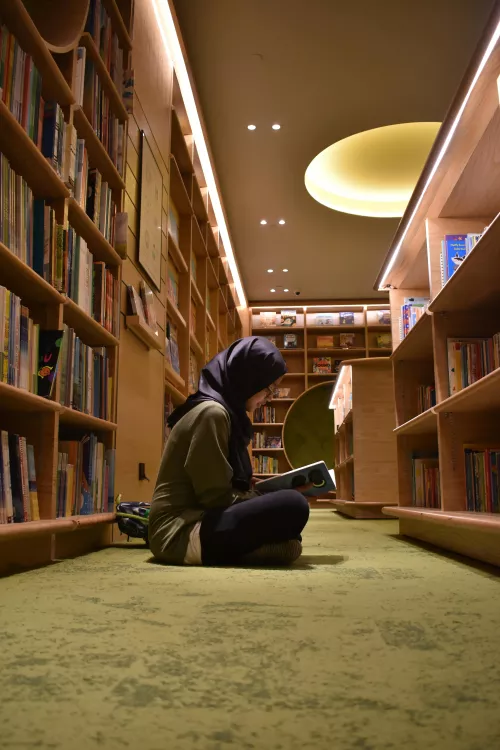
Archivio – Poste italiane 22.08.2024 (diario.world)
 (Foto: Gregorio Dimonopoli)
(Foto: Gregorio Dimonopoli)
Crisi demografica, mettere i soldi non basta: diamo alle donne la possibilità concreta di essere madri (ilriformista.it)
Cazzolate
Incentivare il primo figlio
In previsione della legge di bilancio, Giancarlo Giorgetti ha gettato sul piatto della spesa la spada di Brenno di sei miliardi per interventi a favore della natalità e della famiglia. Si tratterebbe – a stare alle prime indiscrezioni – di misure di carattere fiscale con un occhio alla problematica del quoziente familiare e alla selezione delle detrazioni fiscali, tenendo conto dei differenti carichi familiari. Staremo a vedere.
La denatalità
È importante, però, che vi sia, nel dibattito politico, una consapevolezza diffusa sulla crisi demografica (denatalità + invecchiamento): uno squilibrio che – come ha detto di recente il Governatore Fabio Panetta “rischia di avere effetti negativi sulla tenuta dei sistemi pensionistici, sul sistema sanitario, sulla propensione a intraprendere e a innovare, sulla sostenibilità dei debiti pubblici. Per contrastare questi effetti, è essenziale rafforzare il capitale umano e aumentare l’occupazione di giovani e donne, in particolare nei paesi – tra cui l’Italia – dove i divari di partecipazione al mercato del lavoro per genere ed età sono ancora troppo ampi’’.
Panetta, poi, ha segnalato l’utilità di “misure che favoriscano un afflusso di lavoratori stranieri regolari’’ da gestire in maniera coordinata all’interno dell’Unione, bilanciando le esigenze produttive con gli equilibri sociali e rafforzando l’integrazione dei cittadini stranieri nel sistema di istruzione e nel mercato del lavoro. Siamo arrivati ad un punto che rischia di essere di non ritorno anche per quanto riguarda l’occupazione.
La crisi sul versante dell’offerta di lavoro non è solo una pur grave questione di competenze inadeguate, ma anche di numeri, di persone in carne ed ossa che non sono disponibili a rimpiazzare chi esce dal mercato del lavoro (magari troppo presto rispetto alle esigenze) per la banale circostanza che non sono nate e cresciute.
Ma è sufficiente un maggiore stanziamento di risorse per risollevare il declino inesorabile della filiera della riproduzione sociale? Come la mettiamo con i valori, le culture che si sono consolidate negli ultimi decenni, anche tra le famiglie degli immigrati?
Sono consapevole di rischiare la crocifissione in sala mensa ma mi domando se è onesto parlare di denatalità senza neppure menzionare, tra le tante cause, il tema della Ivg. I demografi ne tengono conto, ma anche gli scienziati “tengono famiglia’’ e non si avventurano con disinvoltura su di un terreno minato.
Il punto
Lo ha fatto in un articolo su il Foglio (La crisi della natalità, le ‘mamme del mai’’ e lo spirito originario della 194’’ del 20 maggio 2024) Gian Carlo Blangiardo, già presidente dell’Istat. Il demografo ha coniato una definizione: “le mamme di mai, ovvero tutte quelle bambine non nate che oggi avremmo potuto conteggiare tra le donne in età fertile e dalle quali avremmo verosimilmente ricavato un utile e sostanziale contributo alla bassa natalità che ci preoccupa’’.
E proseguiva Blangiardo: “Se infatti guardiamo alle statistiche sulle interruzioni volontarie di gravidanza, possiamo rilevare come dall’avvio della legge 194 si siano registrati in Italia circa 6 milioni di interventi, a partire dai quali – stimata la componente femminile e tenuto conto delle sue corrispondenti probabilità di sopravvivenza sino ad oggi – si valuta che al 1° gennaio 2023 ci sarebbero state circa 2,2 milioni di donne 15-43enni in più. Il numero delle potenziali mamme si sarebbe così elevato a 13,8 milioni e, applicando loro i più recenti valori dei tassi specifici di fecondità per età della donna, si calcola che avrebbero dato luogo nel 2023 a 490 mila nati. Di fatto, invece delle 379 mila nascite segnalate da Istat in via provvisoria, nel bilancio demografico dello scorso anno avremmo sfiorato quel mezzo milione di nati che viene visto dai fautori della ripresa della natalità come obiettivo minimo da raggiungere. Purtroppo – continuava il demografo – a conti fatti solo i figli delle madri non nate sono stimabili in 100mila unità all’anno’’.
L’aborto clandestino
Non si tratta di mettere in discussione la legge n.194 del 1978, ma di applicarla correttamente perseguendo l’obiettivo allora indicato dal legislatore della “maternità responsabile’’. L’Ivg, infatti, non fu riconosciuta come un diritto soggettivo assoluto, ma come il rimedio ad un male peggiore, l’aborto clandestino, il flagello che ha accompagnato l’esistenza della donna durante i secoli.
Tornando al progetto di Giorgetti, se si vuole promuovere la natalità – nell’ambito delle politiche a sostegno della famiglia – occorre passare da una politica intensiva (ovvero iniziando la protezione sociale ed economica a partire dal terzo figlio: una politica che ricorda quella fascista degli 8 milioni di baionette) ad interventi estensivi che incentivino, a tutto campo, la procreazione fin dal primo figlio, che ora avviene mediamente ad un’età superiore ai 32 anni, quando il concepimento ad un’età inferiore non solo sarebbe più naturale, ma agevolerebbe anche l’ulteriore nascita di un figlio.
Il cambiamento dovrebbe consistere nell’offrire alle donne in difficoltà un’alternativa concreta rispetto al ricorso all’Ivg, senza coartarne la volontà, ma senza lasciarle sole nello scegliere la via (più sbrigativa anche per lo Stato) della soppressione di una creatura che ha in sé quella vita di cui la società ha bisogno e che è già presente tra di noi e che invece viene sprecata.
