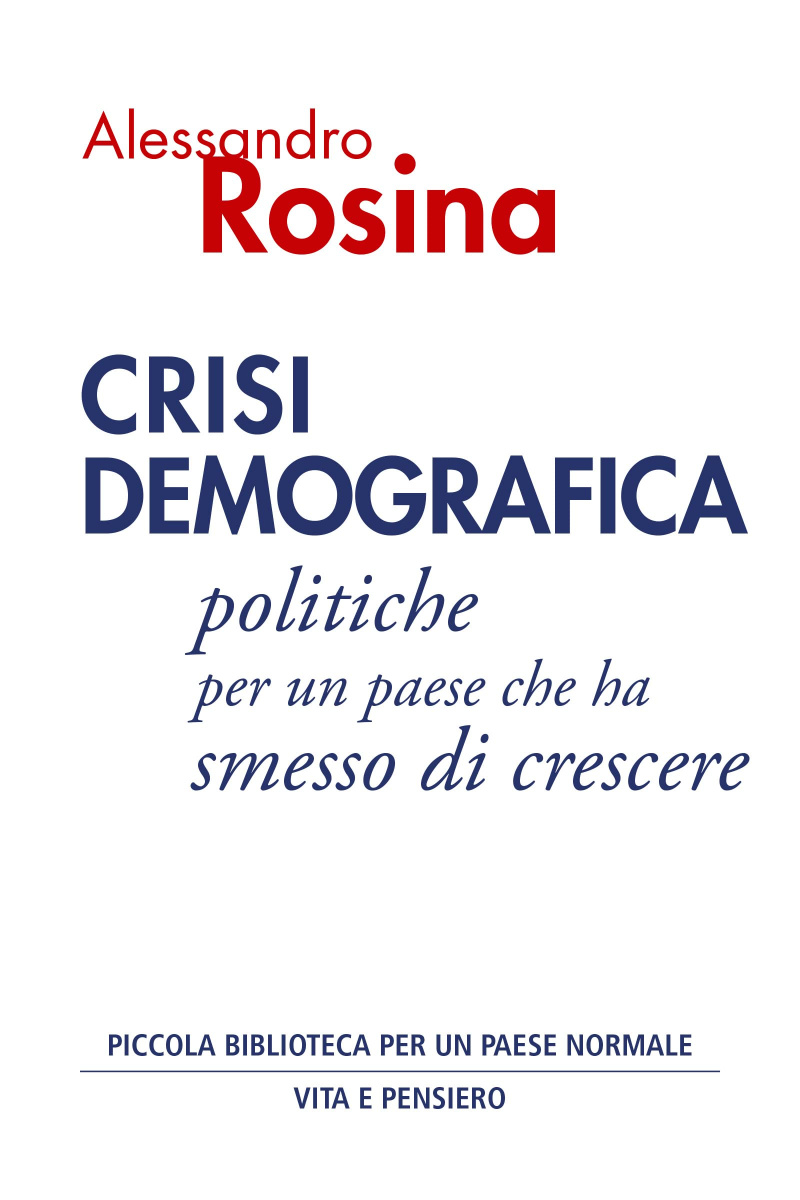di Aldo Cazzullo
Sulla scrivania, tra la sua immagine trasformata in personaggio dei Simpson e la foto con Nelson Mandela,
Tony Blair ha le copie del suo ultimo libro in uscita oggi in tutto il mondo, On leadership.
Rispetto ai dieci anni a Downing Street (1997-2007), e al tempo delle sue tre vittorie elettorali consecutive, ha meno capelli ma è più magro.
Sorride –— «mio padre mi ha insegnato a essere gentile con tutti» —, ma invita a cominciare subito.
Tony Blair, lei scrive che i conservatori sono diventati populisti, non solo in Inghilterra. Però vincono. In Italia sono al governo. Negli Stati Uniti hanno vinto nel 2016, e possono rivincere a novembre. Come mai?
«Ci sono diverse forme di populismo. C’è chi sfrutta il disagio della gente, per farla arrabbiare ancora di più. E c’è chi vuole essere popolare. Ma la vera responsabilità è nostra».
Nostra di chi?
«Dei centristi, della politica tradizionale. Ci si concentra sullo status quo, anziché perseguire il cambiamento, trovare soluzioni, produrre risultati. Se il fascino di Trump persiste, contro qualsiasi previsione, è perché i centristi sembrano incapaci di prendere posizioni forti, dall’immigrazione alle guerre culturali».
Si riferisce alla cultura woke?
«Ci sono questioni, come quella transgender, su cui entrambe le parti assumono posizioni estreme. Ma la maggioranza delle persone non pensa così. La maggioranza ha opinioni moderate. Dobbiamo trovare un terreno di mezzo, di buon senso, anziché adottare posizioni polarizzanti».
Che succede se Trump rivince a novembre?
«Wait and see. Aspettiamo a vedere come va a finire. Il mio istituto ha lavorato in Medio Oriente durante l’amministrazione Trump, e abbiamo assistito a un grande accordo tra Israele e i Paesi arabi».
Ma dal Medio Oriente l’America di Trump appariva in ritirata.
«A lungo termine, l’America tornerà a impegnarsi in Medio Oriente. In Africa già lo sta facendo. E alla fine l’Europa andrà con l’America».
Ma le democrazie occidentali non stanno forse perdendo la guerra politica con le autocrazie?
«All’apparenza la stagione dell’uomo forte è in pieno rinascimento. Dietro la Russia c’è la Cina; e l’alleanza a volte coinvolge la Corea del Nord e l’Iran. Ma non finirà così. L’America resterà la prima potenza mondiale. E la stragrande maggioranza dei Paesi in cui si vive meglio sono democrazie».
Eppure lei stesso fa notare che lo scetticismo nei confronti della democrazia è espresso anche da molti cittadini di Paesi democratici.
«È vero, perché la politica appare a volte stagnante, non riesce a gestire i cambiamenti. Ma le persone che vivono nelle autocrazie vorrebbero poter scegliere il loro governo. Vorrebbero venire nei Paesi democratici».
Sta dicendo che Russia, Cina, Iran, Corea del Nord non vinceranno la guerra politica contro la democrazie?
«Non vinceranno mai. Le democrazie prevarranno. Ma dobbiamo essere abbastanza forti da poter affrontare qualunque cosa emerga, in particolare dalla Cina. Ho sempre creduto e credo alla necessità di avere un rapporto con la Cina, di non isolarla. Ma vedo che il sistema politico di Pechino, sotto l’attuale leadership, si è mosso in modo ostile all’Occidente; il che ha provocato ostilità verso la Cina in America».
Ci sarà un conflitto militare tra America e Cina?
«Credo di no. Ma potrei sbagliarmi. Per questo dobbiamo prepararci a qualsiasi possibilità».
Lei scrive che Putin attaccando l’Ucraina ha commesso un errore che avrà «conseguenze devastanti» per la Russia. Eppure Putin è ancora al suo posto.
«Putin ha sbagliato i suoi calcoli. Ha pensato che l’Europa si sarebbe rivelata debole, che avrebbe rapidamente perso coraggio, che si sarebbe arresa. Invece l’Europa è rimasta al fianco dell’Ucraina».
Ma molti sostengono che l’Europa e gli Stati Uniti dovrebbero smettere di armare l’Ucraina, perché così si alimenta la guerra.
«È vero il contrario. Sostenere l’Ucraina è il solo modo per arrivare a un accordo. Uno dei motivi per cui il populismo vince è perché la politica tradizionale pensa sul breve periodo, anziché su quello lungo. L’Ucraina non si sta battendo soltanto per se stessa, ma anche per scoraggiare altre aggressioni. Se ci tirassimo indietro oggi, finiremmo per pagare un prezzo incomparabilmente più alto domani».
È giusto pure che l’Ucraina usi le armi fornite dall’Europa per colpire in territorio russo?
«È giusto supportare qualsiasi soluzione, qualsiasi tattica che faccia sì che Putin non possa proseguire la sua politica aggressiva, e sia invece indotto a venire a patti. Non possiamo abbandonare l’Ucraina».
Nel libro lei appare ottimista persino sulla pace tra Israele e i palestinesi.
«Sì. Perché la guerra di Gaza ha dimostrato una cosa che sono stato tra i pochi a dire sempre, a tutti i leader».
Cosa?
«Che l’unico modo per gestire la questione è risolverla».
Ma come si può far dialogare due parti, Israele e Hamas, il cui scopo è distruggere l’altra?
«Dobbiamo tornare alla soluzione dei due Stati. E la premessa di questa soluzione è l’unificazione della Palestina. Gaza non potrà essere ricostruita se resterà in mano a una forza che vuole distruggere Israele. Gaza deve essere governata da una forza palestinese che non sia Hamas. Senza Hamas, Israele ha tutto l’interesse a cercare la pace.
Ma Netanyahu ha bisogno della guerra per la sua sopravvivenza politica.
«È giusto limitare le distruzioni a Gaza. Ma per avere la pace, occorre che Israele si senta al sicuro. Non solo con i palestinesi; con tutti i Paesi arabi».
C’è il pericolo del ritorno dell’antisemitismo in Europa, in particolare a sinistra?
«Criticare Israele è legittimo, lo dico da grande sostenitore di Israele, e non va confuso con l’antisemitismo. Tuttavia la questione dell’antisemitismo è reale. Dobbiamo essere fermissimi nello stroncarlo».
Esiste anche l’islamofobia? I «riots» in Inghilterra ne sono una prova?
«Certo che esiste. E va combattuta allo stesso modo dell’antisemitismo».
Elon Musk ha scritto che nel Regno Unito, ora a guida laburista, «una guerra civile è inevitabile». Musk sostiene Trump, si muove come il vero capo della destra globale, se non dell’estrema destra. Eppure lei nel libro ne dà un giudizio positivo. Come mai?
«Un conto sono le cose che Musk dice sulla politica; un conto sono le cose che Musk fa come imprenditore, come ingegnere, come innovatore. Musk ha costruito razzi più efficaci di quelli della Nasa, della Cina, della Russia. Ha mandato nello spazio più satelliti che non il resto del mondo. Se oggi in Africa anche le più remote aree rurali sono connesse, così come le settantamila isole che compongono l’Indonesia, lo si deve al suo sistema satellitare Starlink».
Anche sull’intelligenza artificiale lei appare ottimista. Non causerà un’enorme distruzione di lavoro?
«Non penso che l’intelligenza artificiale distruggerà il lavoro umano. Penso che lo affiancherà. I robot non sostituiranno chirurghi e insegnanti; lavoreranno con loro. È un mondo nuovo. Non sto dicendo che questo mondo nuovo sia tutto buono; sto dicendo che è un mondo nuovo».
Insisto: ci sarà una distruzione del lavoro.
«Certo, alcuni posti di lavoro non ci saranno più. Se un lavoro può essere fatto meglio con l’intelligenza artificiale, sarà fatto con l’intelligenza artificiale: questa è la realtà, e i governi dovranno aiutare la gente ad affrontarla. È un momento straordinario per governare, perché la rivoluzione tecnologica sta cambiando tutto, ancora più velocemente di quanto abbia fatto la rivoluzione industriale».
Non vede anche rischi?
«Certo. Vedo rischi immani. Ma vedo anche immani opportunità. La rivoluzione industriale sfociò nella Prima guerra mondiale. La sfida della sinistra è capire la rivoluzione tecnologica, e far sì che sia giusta ed equa. Che funzioni per le persone. Giustizia sociale: il fine della sinistra resta quello. Se sapremo rendere i frutti della rivoluzione disponibili a tutti, dalla sanità alla scuola, non soltanto supereremo il vecchio conflitto novecentesco tra capitale e lavoro, ma pure quello moderno tra sovranismo e globalismo, tra populismo ed élites ».
Esiste anche un populismo di sinistra?
«Certo. Resiste l’ideologia per cui più è grande lo Stato, più è giusta la società; ma non funziona così. Il socialismo che considera il business un nemico non esercita su di me alcuna attrazione; proprio come il populismo di destra, per cui il nemico sono gli immigrati».
Però il prezzo dell’immigrazione lo pagano le classi popolari: meno salari, meno diritti.
«È così. L’immigrazione ha dato e dà un grande contributo alle società occidentali. Ma va tenuta sotto controllo: perché è quando la gente ha la sensazione che le cose siano fuori controllo, che nascono i sentimenti anti-immigrati. E lo dico da laburista, sia pure del New Labour. Da progressista quale sono sempre stato».
Lei si esprime per la tolleranza zero.
«Legge e ordine non sono cose di destra. Il primo dovere dello Stato è tenere la gente al sicuro, e la lotta al crimine per me è una cosa di sinistra, perché le prime vittime del crimine, del traffico di droga, della violenza sono le classi popolari. Uno dei motivi per cui i progressisti sono in difficoltà è perché non sono abbastanza fermi su legge e ordine. Ricorderò sempre quando vidi un ragazzo urinare contro la porta nella strada dove vivevo; cercai di farlo smettere, mi minacciò con un coltello. Sono umiliazioni che minano la fiducia delle persone comuni in sé stesse e negli altri».
Si comincia a capire che la Brexit è stata un errore. Sarà possibile porvi rimedio? Il Regno Unito tornerà in Europa?
«È una questione di lungo periodo. Io non ho dubbi che il posto del Regno Unito sia dentro l’alleanza politica europea, perché è il nostro continente, la nostra parte di mondo. Ma dopo la Brexit bisogna muoversi con attenzione. Ora c’è un nuovo governo, con un leader pro-europeo, che migliorerà i rapporti».
Vedremo mai gli Stati Uniti d’Europa?
«È una questione di lunghissimo periodo (Tony Blair sorride). Ma credo di sì. Ci saranno tre superpotenze. L’America. La Cina, per quanto la sua popolazione sia in declino, e scenderà a 800 milioni. E l’India, che invece arriverà a un miliardo e mezzo: come la popolazione degli Stati Uniti e dell’Unione europea messa insieme e moltiplicata per due. Qualcosa che facciamo fatica anche solo a concepire. Per reggere il confronto si stanno creando aggregazioni di Stati un po’ dappertutto: nel Sud-Est asiatico, in Africa, in America Latina. Accadrà anche in Europa: in quali forme, è una domanda aperta. L’Europa si unirà per controbilanciare il sistema. E sarà sempre l’alleato chiave degli Stati Uniti».
Lei scrive di aver provato gioia soltanto due volte, in dieci anni da primo ministro.
«I momenti di pura gioia sono molto rari in politica. Per me sono legati all’accordo del Venerdì santo per la pace nell’Irlanda del Nord, e all’assegnazione a Londra delle Olimpiadi del 2012».
Che cosa invece non rifarebbe? Le si rimprovera l’appoggio agli Stati Uniti nella guerra in Iraq.
«Restare al fianco degli Stati Uniti era nel profondo interesse del mio Paese. Prendemmo decisioni sulla base delle informazioni allora disponibili».
Ma se potesse tornare indietro?
«Quel che è fatto è fatto. Sia per l’Afghanistan sia per l’Iraq si possono trovare buone ragioni per cui non andava fatto. Ma una volta che è stato fatto, avremmo dovuto restare sulla stessa linea. Per questo ero contrario al ritiro dall’Afghanistan nel 2020».
Lei però scrive che fu un gesto di «hubris», di superbia, pensare di poter «trapiantare la democrazia su un corpo politico non preparato ad accoglierla».
«È così. Ma credo ancora che Saddam Hussein sarebbe stato un grandissimo fattore destabilizzante nel Medio Oriente».
Lei riconosce però anche di essere diventato impopolare.
«È il destino di ogni leader: all’inizio sei meno capace e più popolare. Con il tempo diventi molto più capace, e molto più impopolare. È accaduto anche a me. Gli ultimi anni da premier sono stati decisamente migliori dei primi. Salario minimo, riduzione della povertà, investimenti nella sanità… Il mio errore è stato non difendere la mia eredità. Ho imparato che bisogna farlo; perché nessuno lo farà al posto tuo.
Davvero quando era primo ministro non aveva un cellulare?
«Davvero. Non l’ho mai voluto, con mia grande soddisfazione».
E come faceva?
«Se dovevo prendere una telefonata, la prendevo. Ma mi colpisce la disinvoltura con cui oggi molti leader usano Whatsapp, Telegram, Signal e varie piattaforme per comunicare. Non mi sembra sicuro».
Che ricordo ha della regina Elisabetta?
«Una persona straordinaria, con una straordinaria devozione al dovere. Metteva la propria funzione sopra qualsiasi cosa, compresa se stessa».
Quando morì Diana le cose sono andate proprio come nel film «The Queen»?
«Non lo so. Non ho visto il film».
Non ci credo neanche morto.
«Le assicuro che è così. Non guardo mai i programmi su di me, e in genere seguo poco film e tv sulla politica. Così come consiglio i leader di non seguire i social, non leggere i commenti, ignorare i messaggi di odio, per non cadere vittime della paranoia. Preferisco vedere una serie italiana su Netflix».
Quali serie?
«Suburra e Lidia Poet».
Comunque, nel film «The Queen», lei consiglia alla regina di tornare a Londra, mettere la bandiera a mezz’asta fuori da Buckingham Palace, commemorare lady Diana. È andata così?
«Abbiamo discusso di tutto questo con la regina. Fu una circostanza molto difficile, molto dura. E lei alla fine ha fatto la cosa migliore. Come sempre».
E di Margaret Thatcher che ricordo ha?
«Su alcune cose eravamo d’accordo e su altre in disaccordo, ma abbiamo avuto un buon rapporto personale. Con me è sempre stata molto gentile, generosa, disponibile. Alla mano. Poi, certo, era Margaret Thatcher. Potevi dissentire; non potevi dire che non fosse attaccata a quello in cui credeva».
E di Silvio Berlusconi?
«Quando due primi ministri lavorano insieme, importa poco di quale partito siano. La cosa fondamentale è la fiducia. Berlusconi era considerato un personaggio controverso. Ma con me, quando diceva una cosa, la faceva».
Questa è una notizia.
«Ad esempio mi aiutò proprio sulle Olimpiadi, spostando l’appoggio italiano dalla Francia all’Inghilterra».
Giorgia Meloni l’ha mai conosciuta?
«No. Sono certo che prima o poi la incontrerò. È un fenomeno politico molto interessante».
«Un leader non deve dire alla gente quel che la gente vuol sentirsi dire», lei scrive. E fin qui sono tutti d’accordo. Ma poi aggiunge: «un leader non deve necessariamente dare alla gente quel che la gente vorrebbe avere». E questo per molti leader è più difficile da accettare.
«Henry Ford diceva: se avessi chiesto alla gente che cosa voleva, avrebbe risposto “cavalli più veloci”, non automobili. Il leader non deve pensare a quello che la gente vuole, ma a quello di cui la gente ha bisogno; e convincerla che sia quello che vuole. Altrimenti non è un leader, è un follower».
Lei scrive anche che un leader ha il dovere di essere ottimista.
«Nessuno sale volentieri a bordo di un aereo pilotato da un pessimista. Guardi la parabola del nostro tempo. Le cose stanno migliorando. La storia progredisce. Si vive più a lungo. Paesi molto più poveri di noi sono molto più ottimisti di noi. Il ventunesimo secolo sarà straordinario. Con la rivoluzione tecnologica ci potrà essere più prosperità per tutti. Troveremo tecnologie green per lottare contro il cambio climatico senza danneggiare l’economia. È solo questione di ritrovare la fiducia. E la consapevolezza della nostra vera, immensa ricchezza: la libertà».