










































































L’angolo fascista
Non leggete “il Fango Quotidiano”
Un Paese civile non ha bisogno di forcaioli e bugiardi.
Tutte le condanne di Marco Travaglio
Maurizio Belpietro, La Verità e le condanne – Diario
Procedimenti giudiziari per Pietro Senaldi

























































































Non leggete “il Fango Quotidiano”
Un Paese civile non ha bisogno di forcaioli e bugiardi.
Tutte le condanne di Marco Travaglio
Maurizio Belpietro, La Verità e le condanne – Diario
Procedimenti giudiziari per Pietro Senaldi




































































































Non leggete “il Fango Quotidiano”
Un Paese civile non ha bisogno di forcaioli e bugiardi.
Tutte le condanne di Marco Travaglio
Maurizio Belpietro, La Verità e le condanne – Diario
Procedimenti giudiziari per Pietro Senaldi















Le recenti elezioni tedesche fanno riaffiorare lo spettro bruno, ricordando che giusto un secolo fa la loro prima affermazione i nazisti l’ebbero proprio in Turingia.
Il rimosso, quel 1933, s’impone di nuovo. Quell’anno per Heinrich Mann significa l’esilio e la pubblicazione di un saggio incandescente, L’odio. Come il nazismo ha degradato l’intelligenza (tr. di Eusebio Trabucchi, L’Orma), dedicato disperatamente «alla mia patria», ormai perduta.
Per la prima volta in maniera appassionata e ‘partigiana’ Mann illustra con la potenza del dolore l’ingiustizia subita rievocando la situazione politica del Terzo Reich. L’odio illumina la vita quotidiana di quel terrore che già nei primi mesi si viveva in Germania con arresti arbitrari, perquisizioni illegittime, sparizioni improvvise, ritrovamenti di cadaveri deformati, reclusioni brutali e ingiustificate nei primi Lager, chiusura forzata di sedi di partiti, sindacati, associazioni, giornali, case editrici, pestaggi violenti degli oppositori.
E su tutto e tutti una diffusa cappa di odio, compatta, sostenuta dal terrorismo di stato. Mann, il fratello maggiore di Thomas, nato anche lui a Lubecca, nel 1871, morì in esilio a Santa Monica nel 1950 poco prima di tornare in Germania, o più esattamente nella Repubblica Democratica Tedesca, in qualità di presidente della Accademia delle Arti di Berlino Est.
La scelta di tornare in Germania – a differenza di Thomas – e di optare per quella che veniva chiamata ‘Germania comunista’ ossia nella neonata DDR, chiarisce le simpatie di sinistra di Mann, che nel saggio afferma la speranza in un futuro comunista per la Germania, in termini utopici, mentre l’autore non affronta la grave responsabilità della KPD, del partito comunista tedesco, notando, tuttavia onestamente: «Il Partito comunista di Germania non ha mai davvero interpretato il proprio ruolo, non ha mai agito in modo indipendentemente, limitandosi a prendere ordini da Mosca, e spesso senza saperli neppure eseguire. Gli mancava una profonda convinzione interiore della propria missione, e di conseguenza anche volontà e forza».
Fu lungo il percorso che condusse lo scrittore a diventare il testimone della sinistra –tanto da ventilare la sua candidatura a presidente della Repubblica di Weimar contro il feldmaresciallo Paul von Hindenburg, quello che nel ’33 incaricò Hitler, il ‘caporale austriaco’, ad assumere la carica di cancelliere, consegnando di fatto il paese nelle mani del partito nazista e alla dittatura.
Mann, che proveniva da una agiata famiglia di commercianti anseatici, malgrado l’opposizione del padre aveva imposto la sua volontà di divenire scrittore. La liquidazione della ditta di famiglia –quella dei ‘Buddenbrook’ – con la precoce morte del padre, gli consentì di poter vivere di rendita e di compiere viaggi con prolungati soggiorni in Italia, tra cui quasi due anni tra Roma, a via di Torre Argentina, e Palestrina.
È il periodo ‘dannunziano’ della trilogia, così intensamente decadente di Le Dee o i tre romanzi della Duchessa d’ Assy, che coincide con la direzione nel 1895, ancorché per breve tempo, della rivista «Il secolo ventesimo», di tendenze nazionalistiche, monarchiche, conservatrici, e persino antisemite. Proprio a cavallo tra i due secoli avviene la svolta ideologica di Mann, che trova una sua spiegazione persino geografica con l’orientamento sempre più accentuato e definitivo per la Francia e la sua cultura democratica, laica, illuminista, che affiorò nel 1915 – a guerra iniziata – nel saggio Zola, pacifista e democratico, che causò la rottura con il fratello Thomas. Intanto Heinrich con Professor Unrat o la fine di un tiranno del 1905 si era confrontato con una critica spietata del filisteismo autoritario tedesco.
Nel 1930 la trasposizione filmica in L’angelo azzurro con Marlene Dietrich per la regia di Josef von Sternberg gli assicurò un successo internazionale, mentre in Germania lo scrittore aveva colto un’altra affermazione con Il suddito. Che divenne un testo esemplare per l’‘altra’ Germania, quella democratica, quella dei quattordici anni scintillanti, spregiudicati, creativi della Repubblica di Weimar, che non sopravvisse al Trattato di Versailles e alla grave crisi del 1929 e soprattutto alla demagogia nazionalsocialista, allo scatenamento del terrore dalle SA. Heinrich si schierò sempre per la giovane democrazia in tutti i possibili interventi pubblici, protestando la sua fiducia in una unità europea fondata sull’alleanza tra Germania e Francia, con una Francia già pronta ad accettare una pace profonda, definitiva.
Ma la Germania aveva compiuto la sua drammatica e scellerata scelta storica, quella dell’odio classista, razzista, nazionalista, quella dell’odio contro la ragione fino a giungere ai roghi, manipolata da Hitler ed egemonizzata da Goebbels, l’artefice del tentato assassinio della cultura tedesca, che era ancora egemone in Occidente.
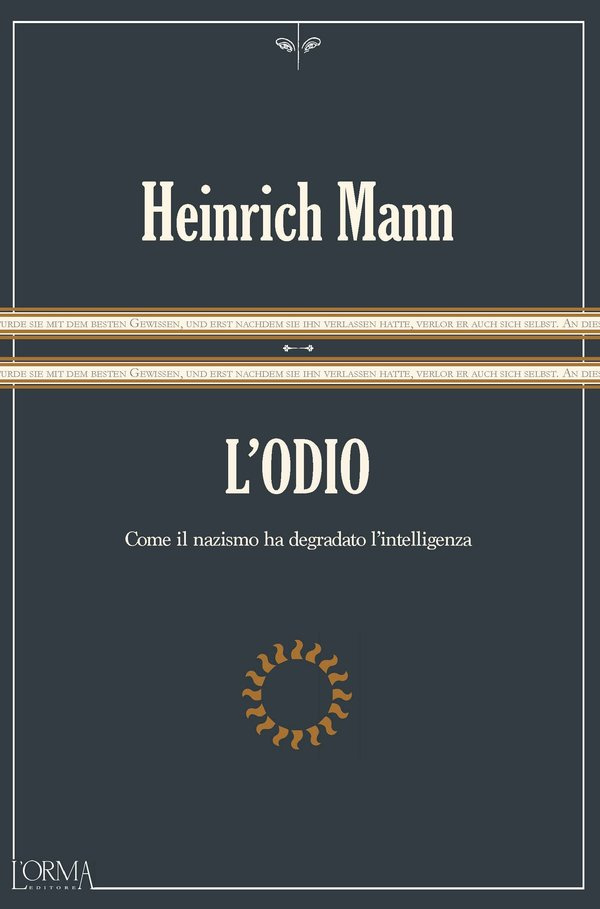
Con il suo vivace excursus, retoricamente magistrale e con la sua singolare acutezza piscologica, Mann è uno dei primi a comprendere l’abilità del giovane demagogo, come pure la sua perfidia.
L’analisi di Mann, che riguarda Goebbels, diventa anche una chiave per altri destini di intellettuali tedeschi attratti irresistibilmente dalla demonia nazista: «Un caso noto è quello del giovane letterato fallito divenuto ora l’attuale ministro della Propaganda. Era stato allievo di Friedrich Gundolf, un docente universitario ebreo, un critico di grande gusto e sottigliezza che proveniva dal circolo iniziatico del poeta Stefan George. Capita che chi disprezza la folla si getti poi a capofitto nei movimenti popolari, ma proprio a causa dell’avversione che prova per le masse incolte finisce per aizzarle contro gli intellettuali. […] Aveva dimenticato il suo maestro israelita e si scagliava contro lo spirito ebraico. Non si era scordato delle sue disfatte letterarie e per questo metteva alla pubblica gogna gli scrittori più dotati. Gli studi raffinati e profondi che aveva compiuto gli rendevano ripugnante ogni idea che aveva di massa, e così incitava il proprio uditorio fino a farlo esplodere tutte le volte che pronunciava la parola “marxista”.
I passati insuccessi e una malformazione al piede che lo affliggeva fin dalla nascita avevano alimentato a lungo il suo desiderio di vendetta contro il mondo, e ora era in grado di infonderlo anche negli altri. Era questo il suo più grande talento. Trasudava odio, appestava l’aria ovunque andasse, contaminava stanze, piazze, l’intero Paese. Certo, non era il solo: gli agitatori nazisti non hanno mai fatto altro, sia prima di salire al potere che ora. Ma in lui l’odio aveva radici più profonde. Per riuscire a dare libero sfogo ai suoi più biechi istinti aveva dovuto cancellare il proprio passato».
Heinrich non era presente nella fatidica notte del 10 maggio quando Goebbels denunciava la ‘vergognosa’ corruzione della cultura tedesca a causa del ’bolscevismo culturale’ che connotava gli intellettuali ebrei e marxisti, fautori di una sterile “letteratura dell’asfalto”. Heinrich non era più a Berlino, aveva lasciato precipitosamente la sua abitazione, devastata subito dalle SA e si era rifugiato per una provvisoria sistemazione economica in un villaggio di pescatori sulla Costa Azzurra, a Sanary-sur-mer, dove si erano raccolti numerosi scrittori tedeschi.
L’esilio e il rogo, ecco i primi risultati dell’odio: «Siamo stati costretti ad abbandonare il nostro Paese, che non sarà mai veramente loro. Così si sono ridotti a bruciare i libri, un’assurdità che non si vedeva dai tempi dell’Inquisizione». Le considerazioni di Mann sono la testimonianza perspicua per comprendere la stupita incredulità di fronte a tale rigurgito di barbarie. In Germania tale efferatezza culturale era ormai sconosciuta.
I roghi che alla Festa di Wartburg del 18 ottobre 1817 gli studenti nazional-liberali avevano simbolicamente acceso riguardavano i testi dell’occupazione napoleonica (tra cui il celebre Code Napoléon). E su quel rozzo antecedente si modellò l’“Azione contro lo spirito anti-tedesco” degli studenti nazionalsocialisti culminata con il rogo del 10 maggio 1933: quella notte bruciò all’Opernplatz di Berlino – e simultaneamente in una sessantina di altre città, soprattutto universitarie –, l’intera cultura moderna, da Marx a Freud, da Heine a Heinrich Mann.
Esilio, rogo dei suoi libri, l’anno proseguiva sempre più amaramente: il 25 agosto Heinrich era nella prima lista dei 33 avversari del regime ai quali era stata disconosciuta la cittadinanza tedesca.

Si era dimesso dalla “Sezione Letteratura” della “Accademia Prussiana delle Arti”, di cui era stato eletto presidente nel 1931, che era la principale istituzione tedesca per le arti. In quei mesi il suo rammarico passava gradualmente in disperazione, quella rievocata con una forza impetuosa e aspra nel saggio
L’Odio, il primo pubblicato all’estero dall’editore Emanuel Querido ebreo-olandese (sefardita di origine portoghese come Spinoza), che divenne un punto di riferimento editoriale per gli scrittori tedeschi dell’esilio: finì deportato e assassinato insieme alla moglie nel campo di sterminio di Sobibór. Con orgoglio intellettuale Heinrich aveva affermato nell’introduzione della rivista «Die Sammlung» (pure edita dall’intrepido Querido) a cura di Klaus Mann: «Non ci presentiamo come giornale della “emigrazione tedesca” […], sebbene la nostra sostanziale intenzione sia quella di costituire un luogo d’incontro della grande letteratura tedesca in esilio. Noi ci presentiamo come il giornale dello spirito europeo, al quale appartiene quello veramente tedesco. Pubblicheremo contributi provenienti da tutti i paesi europei, e anche da altre parti del mondo, e si dimostrerà così, con una simile raccolta, che la vera letteratura tedesca appartiene a quella mondiale».
Nei primi tempi dell’esilio, Mann si faceva delle illusioni sui contrasti fra le fazioni all’interno del partito nazista, ben sapendo però come avrebbe risposto Hitler ad ogni tentativo insurrezionale: «Le prevedibili rivolte verrebbero soffocate nel sangue, in un mare di sangue. Ma poi si ripeterebbero comunque. Gli oppositori interni al partito finirono assassinati, in un bagno di sangue nella ‘Notte dei lunghi coltelli’ tra il 30 giugno e il primo luglio del 1934.
Il saggio manniano da una parte analizza l’odio scatenato in Germania dai nazisti, dall’altra si augura che finalmente l’Europa possa ritrovare se stessa in una unità economica e politica, nonché militare, fondata sulla cultura. È commovente e sorprendente lo spirito quasi profetico di Heinrich Mann, la sua invincibile fiducia nella forza della ragione: «Un rinnovamento tanto profondo può iniziare solo se si attiva il pensiero». Un processo che è ancora in atto. In un senso, ma anche nell’altro: ogni tanto si accendono ancora roghi, o si combatte contro la vocazione democratica con temibili recrudescenze, come segnalano i recenti avvenimenti tedeschi.
L’Odio si conclude con l’unica possibile forma di speranza. Un testimone scomodo viene ammazzato dai nazisti: «Non tornerà più. O forse sì, fra qualche tempo, in un’altra forma. In mille forme. Innumerevoli testimoni! Innumerevoli!».
Heinrich Mann non tornò più in Germania, così come Thomas e come Klaus.
La grande famiglia venne travolta dal Terzo Reich. Fino al 1945 in patria i loro libri vennero bruciati, proibiti, distrutti.

 (AFP)
(AFP)
di Andrea Minuz
Bastano i social e la fascinazione per il Medioevo a spiegarne il successo?
Forse no: c’entra l’archetipo del professore comunista. E allora ecco le dirette con Dibba e l’invettiva sul “capitalismo dilagante”
Guarda che Barbero è bravo, un talento precoce, uno studioso di Medioevo come pochi”, mi dicono alcuni colleghi allarmati, saputo che stavo per fare questo pezzo. E allora diciamolo subito: Barbero è bravo.
Bravo come storico del Medioevo, bravo come divulgatore. Barbero diverte, intrattiene, incanta platee diversissime su e giù per la penisola: da Floris al Petruzzelli, da Sarzana al San Carlo, dal Salone di Torino al Leoncavallo. Barbero è un format (“In viaggio con Barbero”), Barbero è un podcast (“Chiedilo a Barbero”), Barbero è un canale YouTube (“La storia siamo noi”).
Barbero è una diretta social con Dibba per lanciare “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza”, Barbero è una rockstar medievista, tipo Jethro Tull, polistrumentista, eclettico, carismatico, l’occhietto spiritato, come Ian Anderson. Fatta la doverosa premessa è lecito interrogarsi come altri prima di noi sul fenomeno Barbero. Sul perché e per come si è generato.
Quali corde ha saputo toccare. Su cosa insomma spinge a farsi settanta metri di fila a Torino per il firmacopie di Barbero come uno Zerocalcare qualsiasi, o a dannarsi per trovare posto a un suo spettacolo (che i suoi fan non chiamerebbero mai “spettacolo”, semmai conferenza, intervento, lectio).
Ho capito l’entità del fenomeno Barbero un po’ di tempo fa, quando persone davvero molto estranee a libri e festival culturali hanno cominciato a dirmi “ma tu che conosci questo e quello non è che puoi rimediare un biglietto per Barbero che è tutto esaurito”.
Ed erano disposte a farsi parecchi chilometri, a pagarlo anche il doppio, a intrufolarsi magari di nascosto, qualsiasi cosa insomma pur di godersi Alessandro Barbero in “Cosa pensava la donna nel Medioevo: Caterina da Siena”.
A Napoli, invece, orde di ragazzini in coda per sentire Barbero su Federico II, “tra storia e leggenda”. A quel punto non si poteva più restare indifferenti. Bisognava capire.
Diciamolo subito: Barbero è bravo. Fatta la doverosa premessa è lecito interrogarsi sul fenomeno che spinge a farsi 70 metri di fila per il firmacopie
Prima ipotesi, la più ovvia: il barberismo è figlio dei social e d’una frettolosa smania di sapere modellata su podcast e tutorial. Caricarsi a pallettoni con Barbero per poi spuntarla su Facebook in una furibonda disputa con @Eraclito75 sulla battaglia di Lepanto e le sue conseguenze sul nostro assetto geopolitico (Lepanto: un primo allargamento della Nato?).
Qui Barbero si gioca anche una lunga militanza da “wargamer”, in gergo un “grognard”, cioè un veterano dei giochi di simulazione di strategia militare, con l’aria vagamente ossessivo-maniacale di chi da giovane è stato un piccolo Mozart del “Risiko!”. Questo dei social è un punto decisivo per due motivi.
Primo perché soprattutto su Facebook, il social dei vecchi, la storia con la S maiuscola è rinata come eterna contesa e miniera di dispute, controversie, dibattimenti tra falangi di nerd che si danno battaglia cercando su Google una citazione a effetto da Marc Bloch per fare il pieno di like e vincere la Palma d’Oro del “saperla lunghissima”, apice di un pomeriggio solitario davanti a uno schermo con la schiuma alla bocca.
Poi perché a differenza di altri grandi divulgatori (Sgarbi, Daverio, Piero e Alberto Angela), Barbero non viene dalla tv. Barbero è una web-star. Sì, d’accordo, non ha i social e nasce come costola di “Superquark”, ospite fisso di Piero Angela con pillole di “microstoria” in cui volendo, retrospettivamente, si può anche vedere un passaggio del testimone tra torinesi colti e raffinati.
Ma non è sulla tv che si è costruito il fenomeno. Il barberismo nasce col passaparola, rimbalzandosi tra gruppi whatsapp e pagine Facebook video di lezioni e conferenze tenute in giro per l’Italia. Video registrati dai fan, quindi bassa qualità, inquadratura fissa rubacchiata col cellulare, audio così-così.
Una low-definition che restituiva il fascino di una comunità catacombale per pochi adepti. Nel frattempo, diventavano milioni di visualizzazioni. Però poche settimane fa, a una lezione-conferenza sul delitto Matteotti era vietato riprendere Barbero col telefonino. Al Teatro Sociale di Rovigo c’era una troupe, regista, telecamere, tutto (costo del biglietto: 42 euro). Forse è il momento di un film, una docufiction, una serie. Chissà.
Citazioni che servono a vincere la Palma d’oro del “saperla lunga”, apice di un pomeriggio solitario davanti a uno schermo con la schiuma alla bocca
Altra ipotesi: la fascinazione per il Medioevo, che acchiappa sempre. Perché podcast e tutorial li fanno tutti, ma il Medioevo solletica fantasie sfrenate, accende l’immaginazione, vira sempre un po’ sul fantasy, e da Carlo Magno a Tolkien e Atreju c’è, volendo, tutta un’immaginifica continuità.
Miscelato nel modo giusto, il Medioevo si vende sempre bene, come aveva capito meglio di tutti Umberto Eco. Qui Barbero può contare su solidissime e poderose ricerche, ma anche su cose minori e svolazzanti, tipo “La voglia dei cazzi e altri fabliaux medievali”, raccolta di poemetti erotici curata da Barbero contro i soliti cliché sul medioevo buio e tetro, quando invece si trombava alla grande, come sa bene chi si è formato non su Le Goff e Braudel ma su “Quel gran pezzo dell’Ubalda”, “Metti lo diavolo tuo ne lo mio inferno”, “Le notti peccaminose di Pietro l’Aretino” o l’immortale “I Racconti di Viterbury”.
“Gli italiani pagano il biglietto per visitare il tempio greco o la galleria dei busti dei filosofi”, diceva sempre Eco, “ma nel duomo di Milano, o nella chiesetta del Mille vanno ancora ad ascoltare la messa, eleggono il nuovo sindaco nel palazzo comunale del XII secolo”.
Questo eterno Medioevo italiano del palio, dei borghi, delle contrade, dei chiostri, dei monasteri, delle abbazie, il Medioevo di San Francesco e Frate Indovino, di Guido D’Arezzo e Brancaleone da Norcia, delle feste medievali, del carnevale medievale, delle rievocazioni in costume, dei prodotti trappisti e di armature, alabarde, balestre in vendita all’Autogrill, insomma tutto questo magma sorvegliato dal sommo Poeta è un altro punto a favore per Barbero. Medievista è del resto il suo fandom più idolatrante.
Pagine, tributi, gruppi di ascolto, “Primo Vassallo”, “I vassalli di Barbero”, la community “Feudalesimo e Libertà”, il gruppo musicale BardoMagno, una specie di versione gothic-metal dei Modena City Ramblers, che raduna “sotto lo spirito del Sacro Romano Impero” il meglio dei talenti musicali italiani (brano di culto “Magister Barbero”: “scaglia la sua temibile spranga / contro chi la historia infanga / Barbero Barbero / illuminaci il sentiero”). Social più Medioevo suona bene. Solo che Barbero non si limita al Medioevo.
Barbero spiega cose, eventi, personaggi, epoche, andando ormai a spasso nel tempo: la disfatta di Caporetto, la parabola delle Br, Plutarco, Lenin, il crack di Wall Street, Garibaldi, i vichinghi, Nilde Iotti, Matteotti, Cavour, il sacco di Roma, il 25 aprile.
Un barberiano della prima ora (“quando ancora non lo conosceva nessuno”) mi dice che il segreto di Barbero è che parla un linguaggio accessibile a tutti, senza tecnicismi, “e poi fa continui collegamenti col presente”.
E anche qui, d’accordo. Va bene. Ma non può essere solo questo. In tanti parlano un linguaggio accessibile a tutti, pure troppo. I collegamenti col presente sarebbero poi i ferri del mestiere di qualsiasi professore di storia minimamente non votato a martoriare la classe.
Certo, Barbero qui sa essere davvero molto televisivo. In una conferenza a Milano parla di San Francesco come di “un uomo straordinario ma anche molto scomodo”. Discorrendo magari dei longobardi, se ne esce con cose come “e a un certo punto che si fa? Signori, siamo in Italia, si mette su una commissione d’inchiesta!”, e tutti giù a ridere. “Mai invadere la Russia” è un altro suo refrain che strappa sempre qualche sghignazzata al pubblico. Cose così.
C’è un talento, per carità. Il primo ad accorgersene fu Aldo Busi. Letto il manoscritto che altri avevano respinto o ignorato (tra cui Gesualdo Bufalino), Busi pubblicò il primo romanzo di Barbero con Mondadori, “Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo” (il titolo era di Busi). Seicentocinquanta pagine fitte di un finto diario di un ambasciatore in viaggio nella Prussia di Federico Guglielmo, tra incontri con Goethe e Fichte, abbordaggi di marchesine, principesse, contadine, pomeriggi piovosi a Friburgo.
“Scritto con una pignoleria maniacale”, disse l’editor di Mondadori.
Con quel primo romanzo Barbero vince lo Strega. Era il 1996. Aveva trentasette anni. Nelle recensioni si scomodava “Barry Lyndon”, si parlava di “scene di battaglia che sembravano uscite da un quadro”, di una scrittura “allegra con brio che ha poco di storico”. Nelle foto di rito, un giovanissimo Barbero ricordava un po’ Andy Warhol, versione sabauda, con capigliatura da ragioniere.
Però nessuno degli altri suoi romanzi (nove sin qui) ebbe poi il successo di “Mr. Pyle”. Il “barberismo” non è un fatto di libri, ma di video. E’ presenza scenica, performance, equilibrismi, giocolerie da palcoscenico. Guardo e riguardo le conferenze su YouTube. C’è in effetti un pathos. Barbero non spiega, ma rivive, interpreta, va in trance. E’ letteralmente posseduto dal passato.
E poi un senso dello show ma senza strafare, il corpo che si agita, un po’ di storytelling ma ben dosato, senza effetti speciali, stregonerie, video, power-point, ma con piglio professorale, austero, sabaudo. Il fatto è che in un paese abbarbicato a un’idea sepolcrale di cultura, con pochissimi laureati, e la comprensibile convinzione che la lezione universitaria vada modellata sulla messa, il primo che mette due battute in fila e soffia un po’ di alito vitale sui morti del passato diventa Robin Williams in “L’attimo fuggente”.
E il nostro Robin Williams, c’è poco da fare, dev’essere comunista. Perché il talento affabulatorio, il pathos, il coinvolgimento, il Medioevo va bene tutto. Ma in Barbero c’è il format italiano più vecchio e rassicurante di sempre, come una prima serata su Rai 1 con Carlo Conti: il professore di storia comunista. Un archetipo. Una maschera.
Un personaggio fisso della nostra eterna commedia. Vedo Barbero e mi si apre così uno squarcio fantasy e distopico su come sarebbe stata una Leopolda marxista-medievista, radicata nella base del partito, con Gramsci al posto di Baricco, il cappotto di Togliatti invece dell’iPhone, la scrivania di Berlinguer sul palco, ma senza quei laptop messi in bella vista sopra, il mito della “sezione” e non del “garage”, l’attrazione ancora forte e struggente per la Grande Madre Russia al posto d’una Silicon Valley vista col binocolo da Firenze.
C’è in Barbero la fierezza di aver avuto la tessera del Pci “firmata da Berlinguer”. C’è la certezza di essere appartenuto alla “gente migliore del paese”, ma sfiorato dal dubbio di aver tifato per la parte sbagliata, e vabbè. Ma cos’è il comunismo per Barbero? Il trionfo del proletariato? L’abolizione della proprietà privata? Il comunismo come vago sentimento professorale e borghese di “insoddisfazione per le cose come stanno”?
In un paese abbarbicato a un’idea sepolcrale di cultura, il primo che mette due battute in fila diventa Robin Williams in “L’attimo fuggente”
Quel bisogno emotivo di credere in un’alternativa allo status quo, anche quando l’alternativa si è rivelata sempre, sistematicamente, di gran lunga peggiore dello status quo? Non si sa. Nel frattempo Barbero fa le dirette Anpi per separare il comunismo buono da quello cattivo, spiega che Stalin andando al potere si è “dimenticato di cosa vuol dire essere comunista” (che è la versione Barbero del refrain da bar “ma quello non era vero comunismo!”).
Barbero con Angelo D’Orsi, Barbero a braccio sul “capitalismo dilagante” e a braccetto con Montanari sulle Foibe; Barbero che celebra il 25 aprile con Marco Rizzo, festa dell’antifascismo e dell’“anticapitalismo”, e Barbero fianco a fianco con Dibba che lo guarda sbattendo le ciglia mentre dice “nessuno storico ricorderà le vittime palestinesi perché non sono morti occidentali”, quando tanto per cominciare, a una settimana dal 7 ottobre, erano semmai spariti morti e ostaggi israeliani, ma questi son dettagli, lasciamo perdere.
Barbero è un usato sicuro, garantito, chiavi in mano.
Radicato nel territorio. Cauto e diffidente verso le giocolerie harvardiane, le nebulose foucaultiane, le supercazzole dei pischelli ProPal, “decostruire-il-soggetto-coloniale-bianco-binario-occidentale”, eccetera. Troppo svelto per sprofondare in queste supercazzole. Siamo semmai a Togliatti. Siamo a Frattocchie. All’egemonia che si costruisce e difende con lo studio severo della Storia, la disciplina più importante, l’occhio puntato sulla comprensione del mondo.
E al posto del partito, di “Rinascita” e Botteghe Oscure a mettergli la medaglia ci sono oggi i social, i Festival del libro e della mente, le professoresse democratiche. Più che l’ideologia contano i segni: capigliatura, giacche, cravatte, occhiali, tutto quanto in Barbero celebra e conferma cliché e luoghi comuni sui professori di Lettere che da noi non possono che essere fatti così. Barbero ci mette più brio, talento, eclettismo. Parte dal Medioevo e arriva agli studenti di Pisa caricati dalla polizia e ci infila anche un po’ di Assange perché le democrazie zittiscono il dissenso. Siamo peggio dell’Iran.
“In una società complessa come la nostra”, dice, “sarebbe triste il giorno in cui gli studenti non protestassero più”. Chi non può dirsi d’accordo con una frase del genere? E sarebbe noioso, pedante, fuori luogo aggiungere che la cosa più critica e protestataria che può fare oggi uno studente è forse sfoderare, tra mille bandiere palestinesi che sventolano in Ateneo, un timido striscione che invochi la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas. Ma del resto, chi da giovane voleva ritrovarsi parte di una minoranza infima e isolata?
Cauto e diffidente verso le supercazzole decostruzioniste, è usato sicuro, radicato nel territorio. Più che l’ideologia contano i segni
di Guia Soncini
L’avvelenata
Ultimo stadio
La presidente del Consiglio è un’arcitaliana fatta e finita, la sua rivale di sinistra è un modello per gli aspiranti stylist di Porta Venezia che mangiano cous cous e forse, chissà, per gli ammiratori di Valentina Petrillo. Chi si comprerà il libro di Elly e, soprattutto, per chi votano gli ascoltatori di cantanti di successo a me sconosciuti
Cinque anni fa, a Sanremo ci fu una polemica che lì per lì sottovalutai. Riguardava la vittoria di Mahmood, che con “Soldi” aveva battuto Ultimo. La sottovalutai perché “Soldi” era così evidentemente la più bella canzone italiana di questi anni che polemizzare non poteva che essere indizio di fesseria.
Ma la sottovalutai anche perché non avevo, prima di quel Sanremo, sentito nominare nessuno dei due, epperciò mi pareva una gara tra ignoti. Finché qualcuno mi disse: ma Ultimo fa gli stadi. Ora, ormai i concerti negli stadi li fanno i cani e i porci, ma non moltissimi anni fa «fare gli stadi» era ancora il segno che eri un, scusate la citazione, colosso della musica.
E invece ora c’era un cantante che riempiva l’Olimpico e io non sapevo esistesse, e fin lì non era grave: non ascolto i viventi. Il dettaglio preoccupante è che nessuno dei miei amici, quelli che invece i viventi li ascoltano perché hanno il terrore d’essere definiti «boomer», aveva mai sentito una canzone di Ultimo.
Sono passati cinque anni. Continuo a non aver mai sentito una canzone di Ultimo, a non conoscere nessuno che abbia mai sentito una canzone di Ultimo, figuriamoci che sia stato a un concerto di Ultimo. Di Ultimo che, leggo, in otto anni di carriera ha riempito quarantuno stadi. Dunque non conosco l’Italia? Non basta che veda religiosamente “Temptation Island”?
Giorni fa parlavo delle prossime elezioni statunitensi con la più americana delle mie amiche. Lei diceva che è troppo presto per capire chi vinca, perché c’è una massa di americani che non vengono intercettati dai giornali e dai sondaggi, che esistono ma sono difficili da inquadrare. Poi, siccome è anche la più italiana delle mie amiche, ha aggiunto: sai, quelli che qui andavano ai concerti dei Modà, che vanno ai concerti di Ultimo (non conosco neanche nessuno che conosca una canzone dei Modà o sia stato a un loro concerto, in effetti).
Il pubblico non inquadrabile immagino sia l’incubo dei sondaggisti, e in Italia io m’illudo che tutto sia inquadrabile. Di recente un tassista bolognese mi ha detto che non ci libereremo mai di Lepore perché «la gente vota a seconda di cosa votava il bisnonno», e visto che i nostri bisnonni erano tutti fascisti (anche se a Bologna no, anche se nell’Italia intera rappresentata sui social a fine aprile si millantano tutti avi partigiani: cento milioni di nonni partigiani), credo di sapere come finirebbero delle elezioni qua più di quanto si sappia come finiscano le elezioni là.
Però m’è rimasto questo tarlo dell’invisibile e massiccio pubblico di Ultimo: come votano? Come pensano? Chi sono? Dove si nascondono, prima e dopo i concerti? Se il carattere italiano lo definisce, come credo, Bruno Cortona, cioè il Vittorio Gassman del “Sorpasso”, se il carattere italiano è fatto di «Chi è ’sta cicciona? Perbacco, bella donna» e «Sono veramente sorry», di millantare agio economico e non avere i soldi per la benzina, di provarci con tua figlia senza riconoscerla e di ammazzare un amico di cui non sapevi il cognome, se il carattere italiano è quella mistura di cialtroneria e margini dell’illegalità, cafonaggine e capacità di uscirne indenni, se il carattere italiano è quella roba lì che noialtri indossiamo in genere con meno stile di Gassman, quanti Bruno Cortona in sessantaquattresimo ascoltano Ultimo?
Quando hanno annunciato la partecipazione alle paralimpiadi di Valentina Petrillo, che con la muscolatura d’un uomo si percepisce donna e quindi corre tra le donne, le mie amiche (tutte troppo vecchie per avere ambizioni atletiche) si sono indignate per conto filiale: un uomo che ci arrubba lo sport femminile, le nostre bambine respinte dalle millanterie postmoderne, scandalo e busciardìa.
Poi Petrillo, al netto dei gameti, ha fatto ciao ciao con la manina a qualcuno a bordo pista, ha gareggiato senza l’accompagnatore che avevano al fianco le altre concorrenti (non vedenti) per non uscire di corsia, ha detto che il lilla era il suo colore preferito.
E io mi sono chiesta se stesse prendendo forma il soggetto d’un nuovo film rappresentativo dell’italianità, del paese in cui Cortona ha sul parabrezza un finto contrassegno parlamentare, Totò vende la fontana di Trevi, e tra le femmine cieche corre un uomo che pare proprio ci veda.
Stavo parlando dell’imminente libro di Elly Schlein con amici che chiedevano «ma chi se lo compra?», quando è scoppiato un irrilevante scandaletto da social, la cui irrilevanza non m’impedirebbe di parlarne, ma magari un altro giorno. Oggi dirò solo che riguardava Elly Schlein, e un’intervistata di sinistra che ha detto che Giorgia Meloni è più brava di lei (un’ovvietà così ovvia che io la ripeto da anni senza che ciò dia scandalo: ohibò, sarà che non sono percepita di sinistra?).
Oggi dirò solo che del libro di Giorgia Meloni nessuno si è mai chiesto «ma chi se lo compra», nonostante quando uscì ella non fosse ancora la prima presidente del Consiglio declinata al maschile. Oggi vorrei parlare della più saggia delle mie amiche (sempre quella di prima), che mi ha interrotta mentre dicevo ma è ovvio che la Meloni governerà trecento anni, su, ma veramente dobbiamo far finta che quest’ovvietà sia infuocata materia di dibattito.
Mi ha interrotto per dirmi della Meloni quel che in America si dice dei rapper: che «represents». Perché ti votino devi far loro da specchio, devi far sentire qualcuno rappresentato nelle istituzioni, devi somigliare agli elettori.
Certo, Trump al massimo represents i miliardari cafoni, i bancarottieri con soldi ereditati, però poi non è vero: represents i maschi che ti mettevano le mani sul culo anche se non volevi, represents quelli con più ambizione che talento (uno dei tratti più diffusi tra gli esseri umani di questo secolo), represents quelli con inspiegabile autostima, represents quelli per cui meno interesse alla politica estera, meno welfare, meno mollezze europee significa innanzitutto: meno tasse per gli americani.
Kamala Harris chi diamine represents? Quelle che indossano bene Chloé? Quelle che si sono prese un marito coi figli già fatti per risparmiarsi la scocciatura? Quelle con la risata nevrotica? Quelle abbastanza fighe da potersi risparmiare il mezzo tacco slanciante e indossare le Converse?
Mentre mi perdevo a pensare alle elezioni americane, la mia amica saggia mi ha riportata alla Meloni: la Meloni represents, la Schlein chi diamine represents? Non mi è venuta in risposta neanche una categoria, ho fatto scena muta come le asine che non hanno studiato contando su un brunocortonico colpo di fortuna. Ha dovuto rispondersi da sola.
La Meloni è arcitaliana, la Schlein rappresenterà mai le atlete che riescono a battere maschi millantatori di disabilità? Figuriamoci: al massimo rappresenta gli aspiranti stylist di Porta Venezia che, nel monolocale che chiamano «loft», d’estate tifano Petrillo davanti al cous cous, e in autunno fanno il gruppo d’ascolto di “X Factor” mangiando sushi. È un’immagine tremenda, lo so. Non smetto di pensarci da ieri.
Penso che, per distrarmi, mi butterò sulla discografia di Ultimo. Magari è la volta che capisco il paese reale.

 (Giannelli – corriere.it)
(Giannelli – corriere.it)