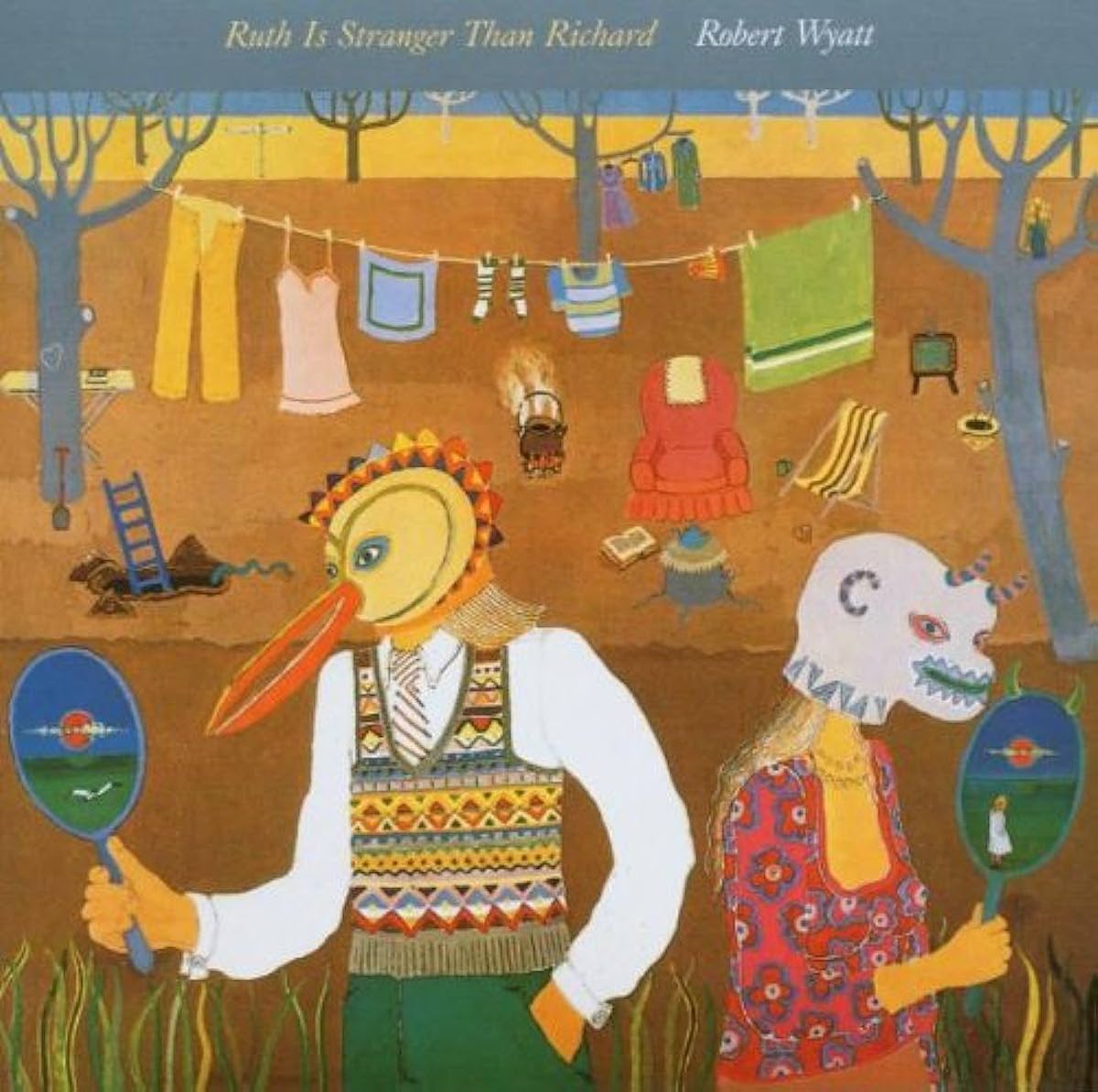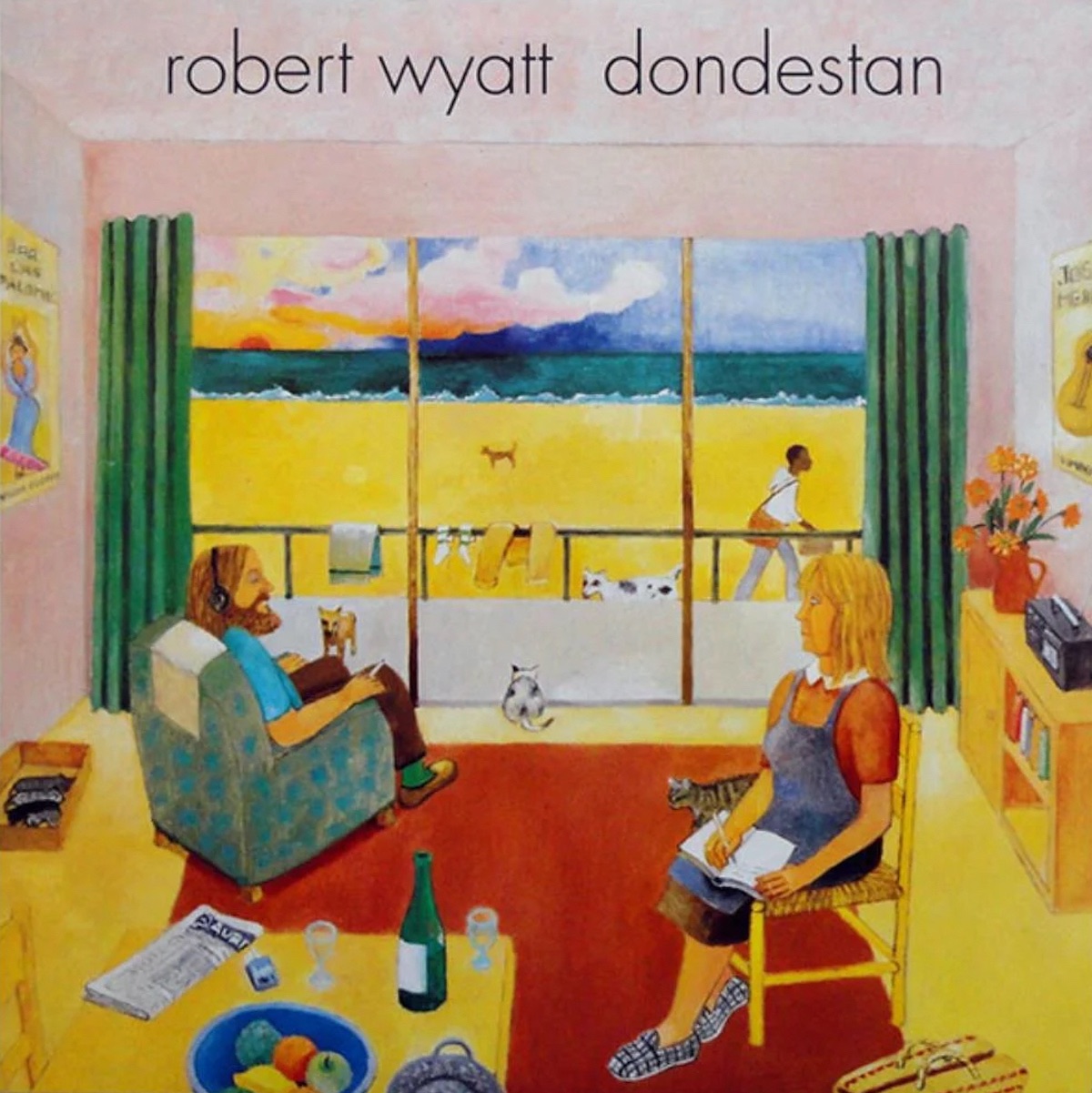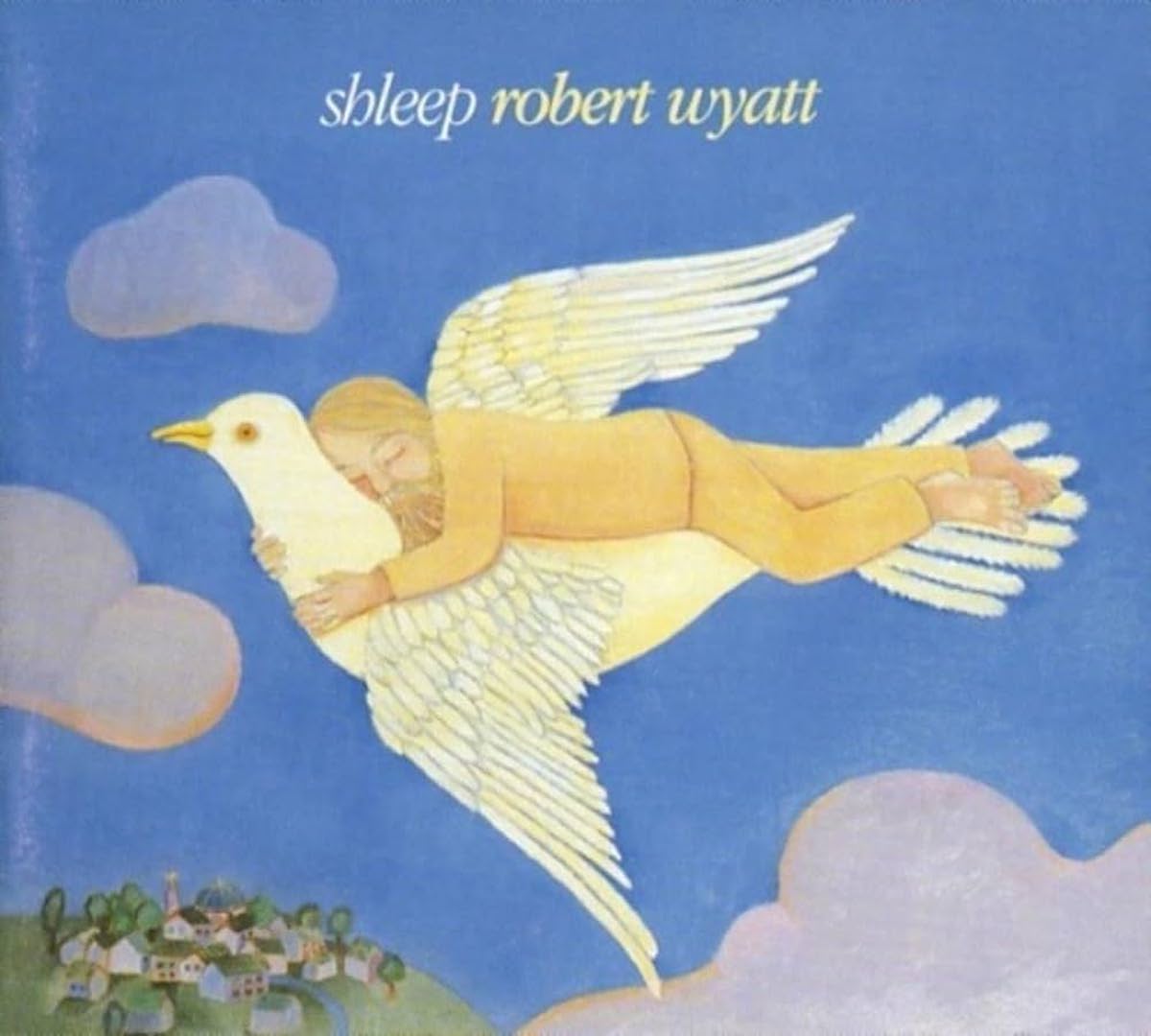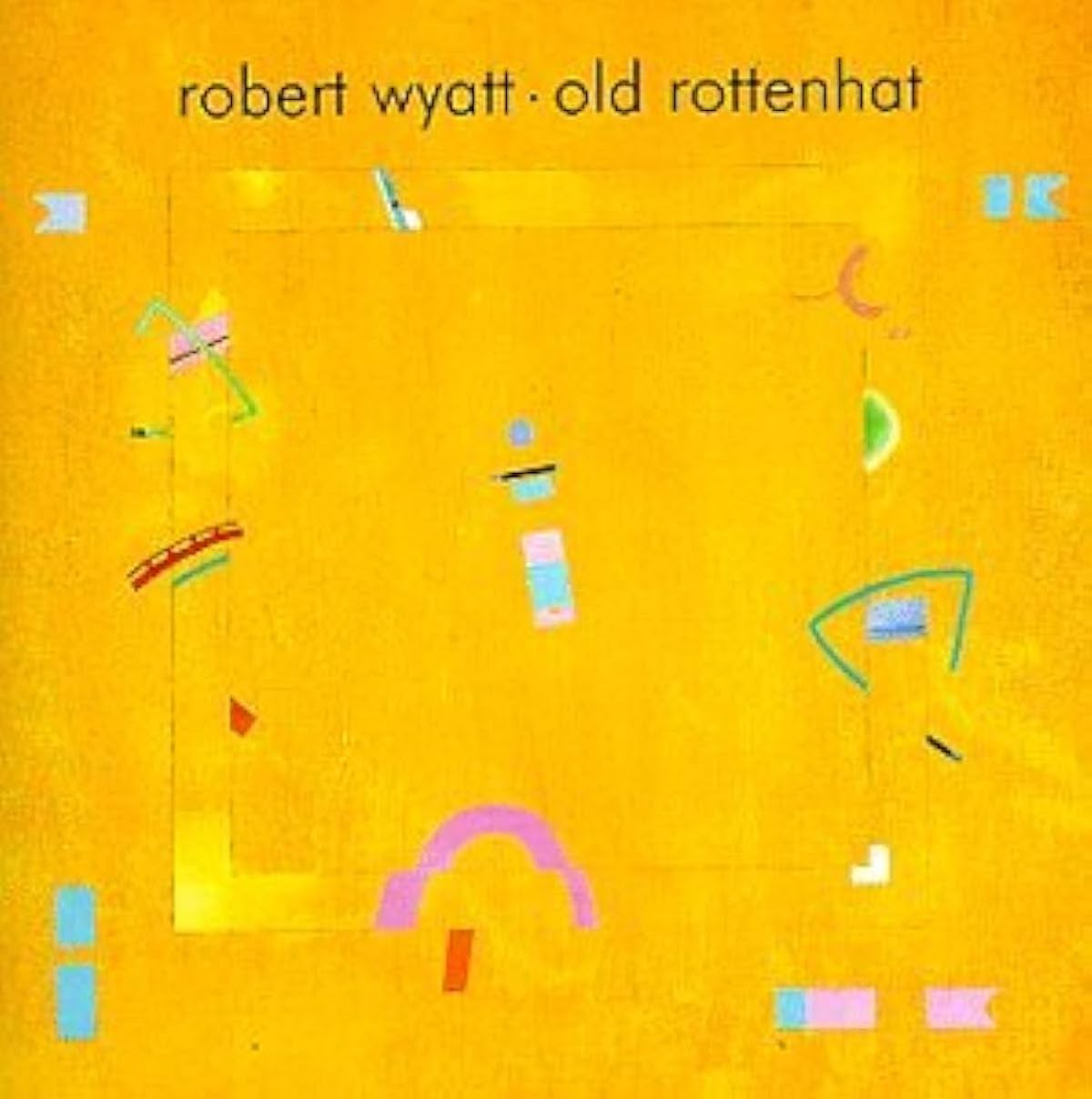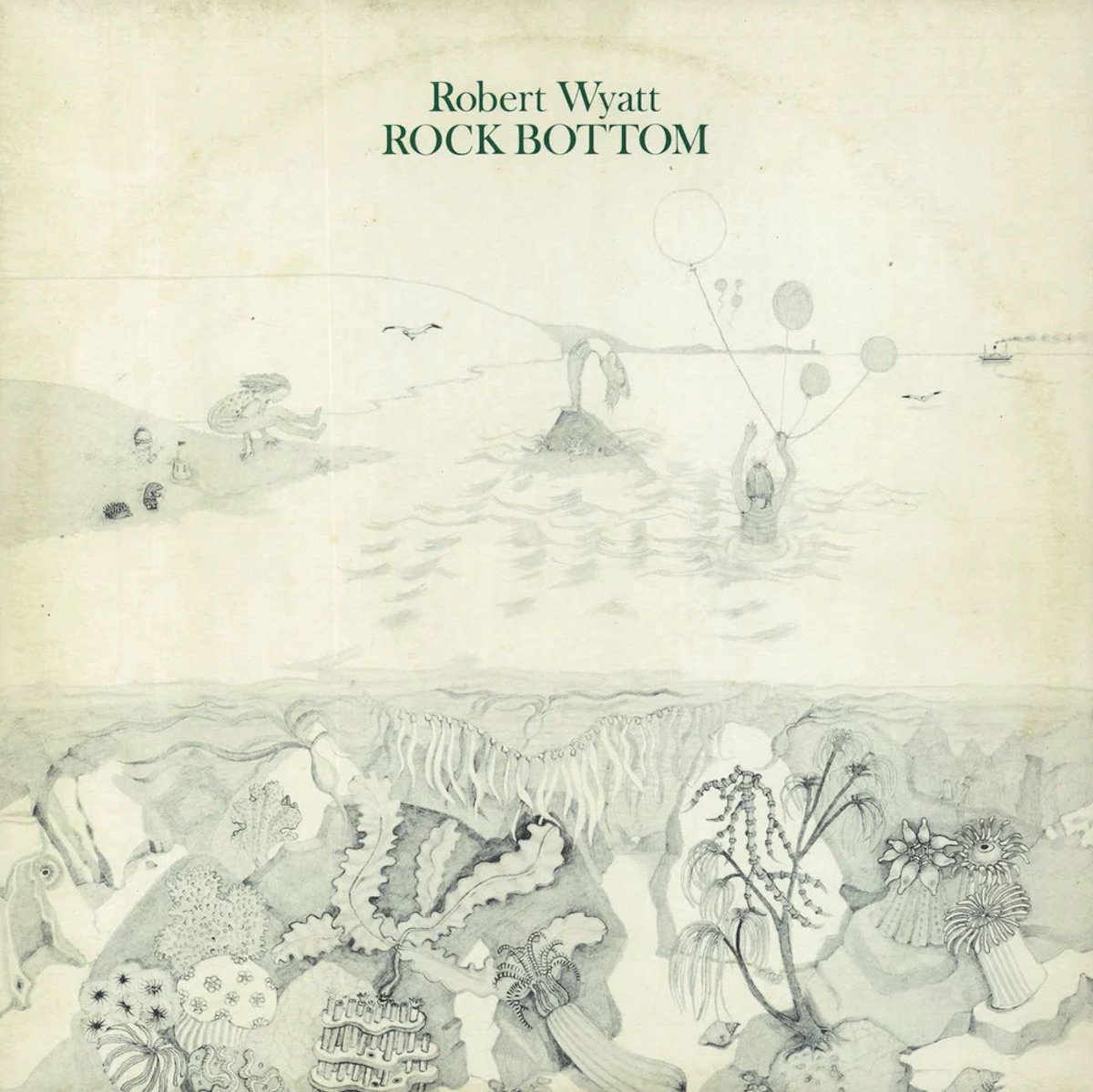RIP
Aveva 90 anni. Senza di lui, il rock inglese sarebbe stato diverso.
La discografia, l’influenza su Eric Clapton, i Fleetwood Mac e Mick Taylor, il rapporto con la musica nera, la filosofia di vita, la strada. «Continua a suonare il blues da qualche parte, John»
È morto John Mayall. Il godfather of British blues aveva 90 anni e si era ritirato dall’attività on the road per problemi di salute. L’annuncio viene dalla famiglia: «È con grande tristezza che diamo la notizia della morte di John Mayall. S’è spento serenamente nella sua casa in California ieri, 22 luglio 2024, circondato dall’affetto della famiglia. I problemi di salute che lo aveva costretto a porre fine alla sua epica carriera on the road hanno infine dato pace a uno dei più grandi guerrieri della strada di questo mondo». Non è stata ancora comunicata la causa del decesso.
«Ci ha regalato 90 anni d’instancabile impegno nell’educare, ispirare e intrattenere», si legge ancora nel comunicato. Al momento della morte erano presenti le ex mogli Pamela e Maggie, la segretaria Jane, gli amici più cari. «Continua a suonare il blues da qualche parte, John. Ti vogliamo bene».
Mayall è stato uno dei grandi pionieri del blues nell’Inghilterra degli anni ’60. Nei suoi Bluesbreakers sono passati musicisti del calibro di Eric Clapton, Mick Fleetwood, John McVie, Peter Green, Mick Taylor, quest’ultimo noto per aver fatto parte dei Rolling Stones. Senza figure “paterne” come lui e Alexis Korner, il British blues sarebbe stato diverso e quindi anche il rock inglese come lo abbiano conosciuto nella seconda metà degli anni ’60 che gli deve parecchio.
Nato nel Cheshire nel novembre 1933, appassionato fin da piccolo di blues e jazz americano, ha iniziato a suonae da autodidatta pianoforte, chitarra, armonica a bocca. Ha cominciato a suonare nelle band negli anni ’50, dopo essere stato con l’esercito in Corea, in un’epoca in cui i grandi del blues americano erano per il resto del mondo e quindi anche per gli inglesi figure lontane, persino esotiche, dal repertorio tutto da indagare.
Quelli che consideriamo giganti del blues americano non avevano alcun mercato in Europa. Giovani inglesi come Mayall, Alexis Korner e Cyril Davies offrivano la loro lettura di quella musica grezza, vera e lontana, ponendo le basi per un parte significativa della storia del rock. Era anche una musica che, sradicata dal mondo di sfruttamento in cui era nata, sapeva di libertà. La sofferenza che esprimeva era vissuta come universale.
«Il blues» ha detto Mayall una decina d’anni fa Guardian «s’adattava alla perfezione allo stile di vita dei primi anni ’60. Tutto stava cambiando nella moda, nell’arte, nella politica. Negli anni ’50 in Gran Bretagna si ascoltava il jazz tradizionale e l’interesse per il blues è nato proprio nella scena jazz. È successo qui e non in America perché all’epoca la loro scena era caratterizzata dalla segregazione razziale». Musicisti come Elmore James, Freddie King, JB Lenoir appartenevano a un altro mondo, ma «parlavano dei nostri sentimenti e delle nostre vite».
Mayall ha fondato i Bluesbreakers nel 1963 dopo essersi trasferito a Londra su suggerimento di Korner (a fine decennio andrà a vivere in California), suonando nei club della città tra cui il Marquee. Del gruppo ha fatto parte com’è noto Clapton, fuoriuscito dagli Yardbirds e in cerca di un’esperienza musicale meno pop.
Il disco di riferimento è Blues Breakers del 1966, attribuito a John Mayall with Eric Clapton, quando quest’ultimo è ormai lanciato verso il successo coi Cream. Nel successivo e fondamentale A Hard Road il chitarrista solista è invece Peter Green, futuro membro chiave dei Fleetwood Mac, ma sono passati dal gruppo, sorta di nave-scuola del rock-blues britannico, moltissimi musicisti, in un continuo avvicendamento nella line-up tipico più delle formazioni jazz con un bandleader fisso che dei gruppo rock.
Suonare, suonare, suonare era il suo credo. Diffondere il verbo del blues – uno dei suoi album s’intitola Crusade – era la sua missione, che portava a termine non solo facendo i pezzi dei grandi, ma anche pubblicandone di suoi autografi. «Mai pensato che suonare il blues significasse copiare alta gente», ha detto.
«Un bluesman deve cantare della propria vita. E dopo un po’ mi sentito sufficientemente sicuro da farlo anch’io, oltre a suonare cover e tributi. Se la musica è la rappresentazione della tua vita, allora dovevo introdurre un elemento jazz, con cui sono cresciuto», si veda ad esempio The Turning Point di fine anni ’60.
Per una ventina d’anni, a patire dalla metà degli ’80, Mayall ha rimesso in piedi una nuova versione dei Bluesbeakes, per poi continuare semplicemente con la sua band fino al ritiro annunciato nel 2021, quando aveva 87 anni. «Per via dei rischi derivanti dalla pandemia e dell’età avanzata, ho deciso che è giunto il momento di appendere le road shoes al chiodo», ha detto.
Era riverito dai colleghi, anche dai bluesman afroamericani che non si sentivano defraudati ma ne elogiavano l’opera di divulgazione. È il caso ad esempio di B. B. King che lo considerava un maestro conscio che senza di lui e altri divulgatori «molti di noi musicisti neri d’America passeremmo ancora l’inferno». Era uno che dava spazio ai suoi musicisti, come ha fatto notare Walter Tout: «Per un chitarrista blues, un concerto dei Bluesbreakers e il top, è tipo il Monte Everest. Se suoni con B. B. King o con Buddy Guy ti limiti a fare accordi tutta la sera. E invece con John sei parte integrante della band, ti fa fare gli assoli, grida il tuo nome dopo ogni pezzo, ti porta sul fronte del palco e ti fa cantare».
Molti musicisti e appassionati hanno conosciuto il blues ascoltando i suoi dischi prima ancora di quelli dei bluesman afroamericani, anche in Italia. «Ha indicato la strada a migliaia di giovani, che grazie a lui e ai suoi capolavori discografici hanno scoperto le origini e la bellezza della “musica origine”», scrive oggi Fabio Treves sui Facebook. «Quando lo ascoltai nel lontano 1965, a Londra, mi innamorai della sua musica, del suo canto, dell’armonica suonata con semplicità e senza inutili virtuosismi. Era un sagittario cocciuto e coerente che non ha mai abbandonato la strada del blues. Il mio soprannome “Puma di Lambrate” lo inventò un giornalista negli anni ’70 proprio in omaggio a John, “il Leone di Manchester”. Grazie John, senza di te il blues oggi non sarebbe quello che è».
Mayall ha raccontato la sua storia nell’autobiografia del 2019 scritta con Joel McIver Blues From Laurel Canyon: My Life As A Bluesman, il suo ultimo album in studio è The Sun Is Shining Down del 2022. Quest’anno la Rock and Roll Hall of Fame gli ha riconosciuto il Musical Influence Award, dedicato a chi ha esercitato un’influenza determinante sul rock e la sua cultura. Lui diceva che il blues è la musica che «esprime con cruda onestà le esperienze di vita». Ne amava il mistero: «Credo che nessuno sappia esattamente cosa sia. È solo che non riesco a smettere di suonarlo».