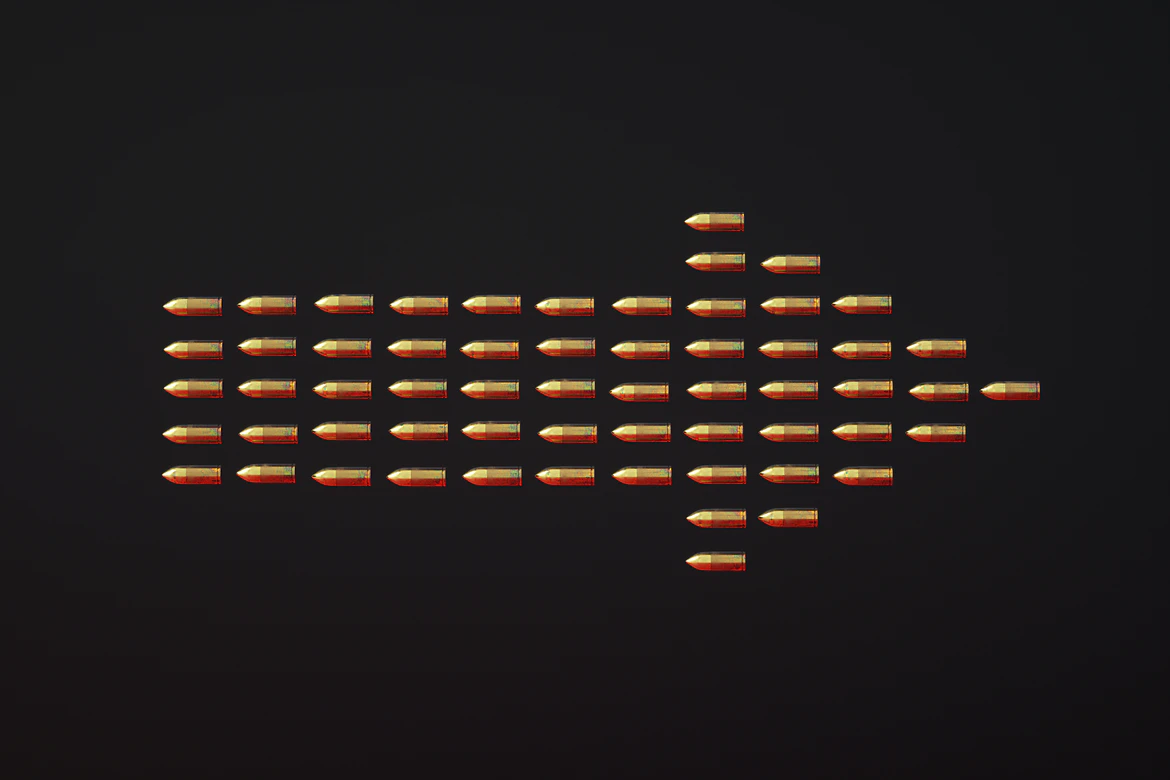di Silvia Calvi
Dis-educazione
Il ministro propone di ripristinare il giudizio sul comportamento anche per le medie, ma senza una responsabilizzazione condivisa e senza l’educazione civica degli studenti non si ottengono molti risultati
Si chiama “Revisione della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti”. È il decreto legge votato dal Consiglio dei ministri pochi giorni fa: tradotto, si propone la reintroduzione del voto in condotta. Non che fosse completamente sparito. Perché la “Valutazione del comportamento degli alunni”, sancita dalla Riforma Gentile nel 1924, ha sempre fatto parte del dna della scuola italiana – dalle elementari alle superiori – per almeno i suoi primi cinquanta anni.
Abolita nel 1977 per le classi elementari e medie (dove fu sostituita da una “valutazione informativa”, cioè un «giudizio sul livello globale di maturazione dell’alunno») è rimasta però sempre in vigore alle superiori: fino a oggi, per essere promossi, serve la sufficienza in tutte le materie e «un voto in condotta non inferiore a 6».
Ma va detto che, dagli anni Novanta in poi, è stato un lungo tira e molla. Con l’avvento dell’autonomia scolastica e l’introduzione del Regolamento dell’autonomia (DPR n 275/99, art. 17) il peso della condotta si è alleggerito fino al punto che, dall’anno scolastico 2000-2001, non condiziona più in alcun modo la promozione o l’ammissione agli esami. Ci ha pensato la ministra Mariastella Gelmini a reintrodurre una maggiore severità, con l’obiettivo di combattere i primi casi di bullismo.
E oggi? La proposta del governo è quella di ripristinare anche per le medie il voto in condotta e dargli lo stesso peso di un tempo: lo studente che al termine dell’anno scolastico avrà 6 in condotta sarà rimandato a settembre. Con l’insufficienza, sarà bocciato.
Per il momento è ancora solo un disegno di legge, quindi dovrà essere approvato anche dal Parlamento: per l’entrata in vigore se ne riparla nel 2024. Ma con Cristiano Corsini, docente di Pedagogia sperimentale all’Università Roma 3 e autore del saggio “La valutazione che educa” (Franco Angeli) si può provare a inquadrare questa proposta nel merito. «L’educazione in generale, e la valutazione in particolare, sono sempre questioni inevitabilmente politiche.
Nel senso che, come e più di ogni altra faccenda educativa, la valutazione è infatti una forma di gestione del potere. I giudizi comportano effetti pratici, e a chi li formula è conferito il potere di incidere in qualche modo sul corso di eventi futuri», dice Corsini che, nel suo libro, si chiede se questo strumento sia davvero utile all’apprendimento.
«Quando si parla di condotta, poi, il vero problema è quello di assegnare un voto a qualcosa che è un po’ più difficile definire e valutare. Considerate anche le diverse sensibilità degli insegnanti. E soprattutto oggi, che abbiamo ben chiaro il legame c’è tra le “competenze di cittadinanza” e il “comportamento”, da qui il recente potenziamento dell’educazione civica nella scuola dell’obbligo. Perché senza una responsabilizzazione davvero condivisa, e senza fare i conti con la complessità del mondo, non si va molto lontano, rischiamo di cambiare solo le parole.
Con l’aggravante che l’educazione civica non funziona per coercizione e paura: questo sguardo violento sulle cose non può produrre una vera conquista dell’adultità, del senso di responsabilità personale. Ma una cosa è certa: per quanto criticabile sia la scelta del ministro Valditara, un problema c’è». E i recenti casi di cronaca aiutano a spiegare dove sia, questo problema.
L’insegnante di Rovigo trasformata in un bersaglio da un alunno che alla fine viene promosso con il 9 in condotta (poi la scuola, diffusa la notizia e l’indignazione generale, ha fatto dietrofront); la docente di un liceo del Lazio buttata a terra da alcuni studenti che filmano la caduta con i telefoni sospesa dalla dirigente per «non turbare la serenità degli alunni» e via così. Tutto vero.
Eppure, una dimensione così complessa e astratta come la vita a scuola dei nostri figli può essere davvero ridotta a un numero? O non rischia di diventare qualcosa che, nei consigli di classe, si risolve in un’astratta – magari anche discriminante – controversia sui valori morali o le pratiche educative (che, tra l’altro, possono cambiare anche radicalmente da un insegnante all’altro).
«Il problema è che negli anni è andata in frantumi quella che era una comunità educante, composta da genitori e insegnanti», dice Corsini. Poi ci sono problemi strutturali: classi troppo affollate alle superiori, spazi inadeguati o insufficienti.
«Una didattica cooperativa – aggiunge Corsini – avrebbe bisogno di spazi accoglienti e figure qualificate e, come dimostrano tutte le esperienze scolastiche sperimentali italiane o di altri Paesi, è quella che funziona meglio della didattica punitiva. Dunque minacciare gli studenti con il “voto in condotta” è soprattutto inutile. È l’espressione di uno sguardo monodimensionale e colpevolizzante che non va da nessuna parte».
Ma se per molti addetti ai lavori la strada imboccata dal governo non è la soluzione, allora cosa si può fare? «Il rispetto si costruisce con insegnanti più formati, preparati e competenti», spiega Daniele Novara, pedagogista e direttore del Centro Psicopedagogico di Piacenza. «I professori dovrebbero gestire l’intera classe, anche l’alunno “difficile”, oltre a saper sviluppare le competenze psico-socio-emotive di tutti gli alunni e di gestire eventuali crisi dovute a casi di bullismo.
Tutti gli indicatori ci dicono che i ragazzi ne hanno un grande bisogno, non perché siano più arrabbiati, anzi: sono soprattutto depressi. Dobbiamo tutti lavorare perché la scuola diventi un luogo dove si va volentieri. E dove si sperimenta il piacere di costruire se stessi, non l’obbligo di rispondere di se stessi agli altri».