
























































L’angolo fascista
Non leggete “il Fango Quotidiano”
Un Paese civile non ha bisogno di forcaioli e bugiardi.
Tutte le condanne di Marco Travaglio
Maurizio Belpietro, La Verità e le condanne – Diario
Procedimenti giudiziari per Pietro Senaldi












































































Non leggete “il Fango Quotidiano”
Un Paese civile non ha bisogno di forcaioli e bugiardi.
Tutte le condanne di Marco Travaglio
Maurizio Belpietro, La Verità e le condanne – Diario
Procedimenti giudiziari per Pietro Senaldi



















di Edoardo Sirignano
Bisogna agire subito e fare in modo che gli ex togati, come nel caso del senatore M5S Scarpinato, non possano accedere a informazioni che riguardino il loro precedente lavoro,
in barba a qualsiasi considerazione su un possibile conflitto d’interesse. Posizione netta in tal senso è quella della Lega, il partito più dossierato.
«Il limite – dichiara il senatore del Carroccio Marco Dreosto – ormai è superato. Ex pm, ora politici, che chiedono di leggere atti che li riguardano? Se non fosse una cosa seria sembrerebbe uno scherzo. La questione non può passare inosservata ed è necessario fare chiarezza».
A tal proposito, i verdi insistono su una commissione ad hoc, in grado di andare oltre le competenze dell’Antimafia. «Non arretreremo – continua – nemmeno di un centimetro. Non è possibile vedere attori ostili di vario tipo, che lavorano per sovvertire la volontà popolare, contro gli interessi nazionali».
Giampiero Zinzi, deputato della Lega e membro dell’Antimafia, intanto, sulla vicenda Scarpinato, spiega come il movimento di cui fa parte «oltre a trattare la questione formalmente, avendo presentato una proposta di legge per evitare scandali di incompatibilità, chiede al pentastellato urgenti spiegazioni sulla sua particolare vicenda. Si tratta di un comportamento inopportuno.
Parliamo di fatti che lo riguardano direttamente e in cui non dovrebbe entrare nel merito, ma osservare da soggetto terzo. Fino a quando il testo, che abbiamo già depositato in entrambi i rami del Parlamento, non entrerà in vigore, non possiamo fare nulla. Bene il presidente Colosimo che gli ha negato di accedere alle intercettazioni che lo riguardavano». Sulle medesime posizioni della maggioranza, pur non avendo firmato il documento presentato da Lega, Fdi e Fi, pure i renziani.
«È paradossale – afferma la coordinatrice nazionale di Italia Viva Raffaella Paita – che Scarpinato, dopo aver chiesto la distruzione delle sue intercettazioni, ora provi a chiedere di avervi accesso. Abbiamo la conferma del doppiopesismo e del conflitto di interessi. Ho più volte chiesto che Scarpinato, ma lo stesso vale per Cafiero de Raho sulla vicenda Striano, chiarisca la sua posizione in Antimafia. La mia domanda è ancora senza risposta». Il senatore Roberto Scarpinato, nel frattempo, continua a insistere per leggere gli atti su se stesso e scrive addirittura al presidente dell’Antimafia Colosimo: «Nell’esprimere il mio stupore per avere dovuto apprendere dalla stampa un provvedimento che mi riguarda, chiedo la formale comunicazione di tale provvedimento che lede gravemente le mie prerogative di parlamentare e pregiudica la mia partecipazione ai lavori della commissione antimafia, ai fini di adire le vie istituzionali a difesa dei miei diritti».

di Luca Pons
Nel giorno dell’anniversario della marcia su Roma, la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti ha ricordato sui social un evento calcistico.
Ma nei commenti molti hanno sottolineato la ricorrenza fascista, e Frassinetti ha risposto citando uno scrittore francese collaborazionista: “Fascismo immenso e rosso”.
“Fascismo immenso e rosso”, ha scritto sul proprio profilo Facebook la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti. Si tratta di una citazione di Robert Brasillach, scrittore francese di estrema destra che collaborò durante l’occupazione nazista. Il commento di Frassinetti è arrivato ieri, 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma.
Il post della sottosegretaria riguardava un anniversario calcistico, ma quando altre persone nei commenti hanno sottolineato anche la ricorrenza fascista, Frassinetti ha risposto con queste parole. Ne è nata una polemica alla quale la stessa sottosegretaria ha risposto scusandosi, ma parlando di “tempesta in un bicchier d’acqua”.
Cosa ha scritto la sottosegretaria Frassinetti sui social
Brasillach era uno scrittore e giornalista di estrema destra che durante il regime di Vichy, in Francia, collaborò con le autorità naziste. Alla fine della guerra, venne fucilato. Tra le accuse c’era quella di aver accettato che la sua rivista riportasse gli indirizzi di persone ebree e partigiane che erano ricercate dalla Gestapo.
La citazione di Frassinati viene da un passaggio in cui Brasillach scriveva: “I bimbi che un giorno saranno ragazzi di 20 anni apprenderanno con oscura meraviglia dell’esistenza di questa esaltazione di milioni di uomini, i campeggi della gioventù, la gloria del passato, le sfilate, le cattedrali di luce, gli eroi caduti in combattimento, l’amicizia tra i giovani di tutte le nazioni rinate […] Il fascismo immenso e rosso”.
Ma sul suo settimanale scrisse anche interventi duramente antisemiti come: “Bisogna risolvere il problema ebraico, perché l’ebreo è lo straniero, è il nemico che ci ha spinti alla guerra ed è quindi giusto che paghi. Sì, noi vogliamo salvaguardare la razza francese, proteggerla dai nocivi fermenti che la ingombrano ed avviliscono, noi vogliamo che in Francia vi siano dei francesi”.
Come detto, Frassinetti ha postato ricordato un anniversario calcistici legato al Milan. Tra i commenti, però, molti hanno sottolineato anche che il 28 ottobre era l’anniversario della marcia su Roma.
Il post originale di Frassinetti
A questi commenti, la sottosegretaria all’Istruzione – storica militante di estrema destra – ha risposto in modo più che ambiguo. Prima Frassinetti ha suggerito che non poteva commemorare la marcia fascista perché i suoi social vengono osservati in quanto figura pubblica: “C’è chi di lavoro mi spia fb con la lente di ingrandimento…”.
Poi, quando qualcuno ha scritto che “il 28 ottobre è un’altra roba” e ha messo un cuore nero “senza il rosso” (in riferimento al Milan), Frassinetti ha risposto con la citazione di Brasillach.
I commenti di Frassinetti
Pd e Avs chiedono le dimissioni
Le sue parole hanno portato a una dura reazione politica. La responsabile Scuola del Pd, Irene Manzi ha affermato che “citare le parole di Brasillach, collaborazionista dei nazisti e antisemita, sul ‘fascismo immenso e rosso’ non è accettabile. Le parole sono importanti, a maggior ragione, quando si riveste un importante incarico che ha a che fare con l’educazione”.
Il senatore dem Dario Parrini ha chiesto che la sottosegretaria dia le dimissioni. Insieme a lui anche Alleanza Verdi-Sinistra, il cui capogruppo al Senato Peppe De Cristofaro ha detto che i “riferimenti nostalgici” sono “indegni di una rappresentante delle istituzioni”, in particolare perché “non è la prima volta che fa riferimenti che richiamano il fascismo, il periodo più buio della storia, senza mai prenderne le distanze”.
La replica di Frassinetti: “Solo una battuta infelice, non apologia di fascismo”
“Penso che sia un po’ una tempesta in un bicchier d’acqua”, ha detto la stessa Frassinetti a Lapresse in risposta alla polemica. “Si parlava di calcio, come sempre ci sono gli sfottò, ho citato questa frase ‘immenso e rosso’, perché uno diceva che c’è solo il nero e io dico che c’è anche il rosso. E basta. Ma sempre parlando di calcio”.
Frassinetti ha affermato di non aver festeggiato la marcia su Roma, “perché non c’è nessuna mia frase apologetica di nessun tipo”, e di non aver nemmeno “esaltato questo autore”. Poi ha insistito: “Io sono anche avvocato. Apologia vuol dire esaltare il fascismo, ma non c’è nessuna frase”.
Ad Adnkronos, la stessa Frassinetti ha detto che il riferimento era “una battuta, probabilmente infelice”. E ha dichiarato: “Le intenzioni vanno guardate bene. Chiedo scusa se ho urtato la sensibilità di qualcuno, ma non volevo. Sicuramente ammetto che l’autore è controverso, non è che lo esalto. Il mio commento era semplicemente descrittivo”.

Il naufragio di Prodi
Una scrittrice albanese e italiana critica l’ex premier che vorrebbe trasformare l’Ucraina in uno Stato cuscinetto, con un approccio che strumentalizza i popoli, riducendoli a merce di scambio tra potenze.
D’altronde fu lo stesso Prodi a definire un incidente lo speronamento della Kater i Radës del 1997
Scrivo oggi come albanese e italiana, come intellettuale e come parte lesa di una storia che non si è mai voluta riconoscere del tutto. Una storia di ferite e parole sfuggenti, di responsabilità negate e verità nascoste sotto il velo opaco della “stabilità”.
Perché proprio oggi, quando sento le parole di Romano Prodi, colui che un tempo rappresentava l’Italia in Europa, dire che l’Ucraina sarebbe stata più «utile» come Paese «cuscinetto» tra Russia e Nato, non posso fare a meno di rivivere un’eco che mi riporta al 28 marzo 1997.
Quell’anno, infatti, nel mare Adriatico, centotré miei connazionali perirono nel tentativo di fuggire dalla miseria; la motovedetta su cui viaggiavano, la Kater i Radës, venne speronata da una fregata italiana, la Sibilla, lasciando al mare e al silenzio le vite e i destini di persone che cercavano un rifugio, una speranza. La tragedia fu presto archiviata come incidente.
Prodi, lo stesso Prodi, allora presidente del Consiglio italiano, liquidò quella tragedia con parole tanto misurate quanto disumane, classificandola come una fatalità della storia, come un errore tecnico di chi, in quegli anni, stava “contenendo” la questione migratoria. Era una forma di geopolitica del sacrificio, mascherata da linguaggio neutro.
Oggi, con la stessa semplicità, dice che l’Ucraina avrebbe dovuto restare “neutrale”, una zona cuscinetto tra due blocchi, sacrificata a una stabilità teorica. Una dichiarazione che parla di equilibrio, certo, ma anche di disumanizzazione e di un’ideologia del sacrificio che dimentica le persone, che non considera le vite umane ma solo i confini, le barriere, le terre di mezzo.
Ma davvero è accettabile trattare la vita e la dignità di un popolo come una merce di scambio tra potenze? È un pensiero che fa rabbrividire. Come scriveva Milan Kundera, “la lotta dell’uomo contro il potere è la lotta della memoria contro l’oblio.”
In queste parole risuona il dolore di chi, come me, non ha mai dimenticato ciò che accadde nel 1997, la disumanità di un governo che non volle prendersi carico delle proprie responsabilità. Essere ricordati, essere riconosciuti, è parte fondamentale della dignità di un popolo, e ignorare questa memoria è una forma di oppressione silenziosa, di violenza invisibile che non smette mai di colpire.
Il 28 marzo 1997, la Kater i Radës navigava verso le coste italiane, carica di famiglie, di giovani, di padri e madri in fuga dal collasso economico e sociale dell’Albania. Il crollo delle piramidi finanziarie aveva gettato l’intero paese in una spirale di disperazione; molti avevano perso tutto, e l’Italia rappresentava per loro un sogno di salvezza, una promessa di dignità.
Ma quella speranza si trasformò in tragedia, la tragedia del Venerdì Santo, quando la fregata italiana Sibilla, su ordine di respingere le imbarcazioni clandestine, speronò la motovedetta, lasciandola inabissarsi in pochi minuti. Chi viaggiava su quella barca trovò la morte, le loro famiglie trovarono il silenzio e l’indifferenza.
Quando Prodi parlò di incidente, di errore, come se quelle vite fossero un dettaglio tecnico, l’intera comunità albanese si sentì tradita, negata nella propria umanità. Non c’era nessun errore in quelle vite; c’era la disperazione di chi era costretto a partire, di chi cercava dignità oltre le proprie frontiere. Non si trattava di uno sbaglio, ma del prezzo imposto a un popolo che per anni era stato considerato un problema da arginare.
La tragedia della Kater i Radës non fu solo un naufragio; fu una ferita aperta nella coscienza albanese, una memoria non riconosciuta che ancora oggi ci richiama al dovere della verità. Questa verità è parte della nostra dignità, ma è anche parte della dignità dell’Italia stessa.
Quando sento Prodi dichiarare che l’Ucraina avrebbe dovuto «rimanere un Paese cuscinetto», risento lo stesso gelo, la stessa volontà di relegare una nazione al ruolo di sacrificabile. L’Ucraina, così come l’Albania del 1997, non è un pezzo di terra neutra, una fascia di contenimento. È un popolo con una storia, con una cultura, con una volontà di autodeterminazione che non può essere ridotta a uno strumento per gli interessi di altri.
La scelta di Prodi di definirla «cuscinetto» non è solo una parola infelice; è l’espressione di una visione che considera alcuni popoli utili solo nella misura in cui rimangono nella propria area d’influenza, nella propria neutralità, nella propria passività.
Ancora una volta, è il linguaggio della geopolitica del sacrificio, di una stabilità raggiunta a spese delle vite umane. Ma come possiamo, come esseri umani, accettare un tale compromesso? Come si può giustificare la pace in un luogo imponendo la sofferenza e l’instabilità in un altro? Come scrisse Jean-Paul Sartre, «l’uomo è condannato a essere libero»; un popolo è dunque condannato ad affermare la propria identità e a rivendicare il proprio diritto di scelta, anche se questo diritto non si adatta ai giochi di potere delle grandi potenze.
Scrivo oggi non solo per rivendicare la dignità della comunità albanese, ma anche per richiamare l’Italia alle sue responsabilità storiche. Perché la verità non è solo un diritto dei sopravvissuti e delle vittime; è un dovere morale di ogni società che si consideri giusta e civile.
Primo Levi ci ha insegnato che «chi dimentica il passato è condannato a ripeterlo»; l’Italia, e l’Europa intera, non possono permettersi di dimenticare. E questo dovere di ricordare non è rivolto solo ai popoli, ma soprattutto ai leader che, come Prodi, dovrebbero rispondere delle proprie parole e delle proprie decisioni.
Oggi, da italiana, io chiedo che si facciano finalmente i conti con la storia. Perché ogni volta che una tragedia viene ridotta a un “incidente” o un popolo a un “cuscinetto”, la dignità umana è vilipesa, ed è la stessa storia di un paese che viene sporcata. Il dolore, l’incomprensione, il silenzio non sono solo una ferita per la comunità albanese, ma una mancanza di giustizia per il popolo italiano, che merita di riconoscere il proprio passato per costruire un futuro autentico.
Questa memoria che porto dentro come albanese è una memoria che appartiene anche all’Italia; perché è l’Italia che deve riconoscere, chiedere scusa, accogliere quel pezzo di storia che non ha voluto vedere. Pretendo che queste scuse arrivino, non per riaprire ferite, ma per risanarle, per restituire alla comunità albanese e all’Italia stessa una dignità che non può essere sacrificata in nome di alcun interesse.
La verità non è un favore, è un diritto inalienabile di ogni essere umano, perché, come scrisse George Orwell, «nel tempo dell’inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario».

di Milena Gabanelli e Giuseppe Sarcina
Il 5 novembre, un martedì, gli Stati Uniti vanno
alle urne per eleggere il successore di Joe Biden.
Come funziona il sistema per scegliere il nuovo capo dello Stato.
Perché il popolo americano non sceglie direttamente il Presidente? E perché si vota sempre di martedì e non di sabato o domenica come avviene nella quasi totalità dei Paesi occidentali?
Le ragioni sono antiche e profonde. Nel 1787 tutti i rappresentanti delle Tredici ex colonie riuniti nella Constitutional Convention di Philadelphia, tanto i latifondisti e schiavisti del Sud, quanto i commercianti e i banchieri del Nord, concordarono sul principio fondamentale della divisione e dell’indipendenza dei tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. I delegati decisero rapidamente che il Congresso, cioè il ramo legislativo, sarebbe stato eletto dai cittadini.
Ma chi avrebbe scelto il Presidente, vale a dire il capo dell’esecutivo? La discussione durò diversi mesi, fino a quando fu escogitato il meccanismo ancora oggi in vigore. Il Presidente sarebbe stato scelto formalmente da un nuovo organismo: il Collegio dei Grandi elettori. Primo problema: quanti dovevano essere i Grandi elettori? I costituenti partirono dalla rappresentanza del Congresso. Ogni Stato esprime un numero di deputati proporzionale alla sua popolazione.
Ma ogni Stato, che sia grande come la California o piccolo come il Connecticut, deve avere lo stesso peso politico e pertanto ha diritto a due senatori. Si decise, dunque, di attribuire a ciascuno Stato dell’Unione una quota di Grandi elettori pari alla somma dei deputati e dei senatori inviati a Washington, a questi si aggiungono tre rappresentanti di Washington Dc, la capitale.
Oggi il totale è pari a 538. La Costituzione poi impone che i Grandi elettori non siano titolari di cariche pubbliche federali. In generale vengono scelti dai partiti fra i politici locali o militanti di provata fede, e devono fare semplicemente da tramite alle preferenze espresse dai cittadini.
Le regole del voto.
Le procedure di voto sono fissate dai singoli Stati. Nei primi tempi potevano andare alle urne solo gli uomini bianchi, purché proprietari di terre. Nel 1870 vennero ammessi ai seggi gli afroamericani e caddero anche i divieti collegati al censo, ma in molti Stati del Sud fino al 1965 rimasero in vigore norme che ostacolavano il voto dei «black people».
Le donne invece conquistarono la scheda elettorale nel 1920. Una delle regole di base è che gli americani devono registrarsi nell’ufficio elettorale del proprio Stato. In diversi aree del Sud, come Alabama e Georgia, le amministrazioni repubblicane hanno varato una serie di norme restrittive per scoraggiare una larga partecipazione al voto. I movimenti per i diritti civili degli afroamericani sostengono che tutti i vincoli e i cavilli burocratici servono ad allontanare dalle urne chi ha più difficoltà a districarsi con i moduli e i formulari.
Vale a dire le minoranze etniche, tendenzialmente meno istruite o, più semplicemente, con meno tempo a disposizione. Ci sono pure degli esempi surreali. La Georgia, guidata dai repubblicani, nel 2021 ha approvato una legge che vieta di distribuire acqua e cibo a chi è in coda, magari da ore, davanti ai seggi. Come dire: statevene a casa.
È possibile votare anche per posta, e di regola chi vuole spedire la propria scheda deve registrarsi in un elenco speciale. Nella maggior parte degli Stati (dalla Virginia all’Arizona) è un’opportunità offerta a tutti gli elettori. Altrove (da New York all’Alabama) solo ai disabili o agli over 65. Tutti i voti, qualunque sia il modo in cui sono stati espressi, vengono scrutinati insieme nell’election day o, al massimo, qualche giorno dopo. Nessun elettore, quindi, può essere condizionato da una parte dei risultati rivelati in anticipo.
Le tappe per la candidatura.

La Costituzione Usa stabilisce che per candidarsi alla presidenza occorrono tre requisiti: essere nati negli Stati Uniti; essere residenti nel Paese da almeno 14 anni, e aver compiuto i 35 anni. In teoria possono presentarsi tutti coloro che soddisfano questi criteri. In realtà la competizione è gestita dai due partiti del sistema: i democratici e i repubblicani.
Entrambi organizzano vere e proprie consultazioni in ciascuno Stato, chiamando gli elettori a indicare direttamente chi dovrà sfidare il campione dell’altro partito. Ogni Stato esprime una quota di delegati in proporzione al numero dei suoi abitanti, che si ritrovano poi nelle rispettive convention per assegnare la nomination ai candidati.
Quest’anno non c’è stato alcun problema per Donald Trump, designato a luglio nella Convention repubblicana a Milwaukee (Wisconsin). Cambio in corsa, ammesso dalle regole, per i democratici che il 19 agosto, nella Convention di Chicago, hanno consegnato l’investitura a Kamala Harris, dopo il ritiro di Biden.
Con più voti non sempre si vinceIl 5 novembre, come abbiamo visto, gli americani non troveranno sulla scheda il nome di Trump o Harris, ma in loro rappresentanza quello dei Grandi elettori. Sono le autorità competenti di ogni singolo Stato che procedono al conteggio dei voti e alla designazione del numero dei Grandi elettori. In 48 Stati su 50 vige la regola del maggioritario puro: chi prende uno solo voto in più si aggiudica l’intero pacchetto.
Facciamo l’esempio della California: su 20 milioni di votanti registrati, se 10 milioni più uno scelgono i Grandi elettori democratici, tutti i 54 seggi vanno a Harris e zero a Trump. Funziona così in 48 Stati, ad eccezione del Nebraska e del Maine, dove i rappresentanti sono distribuiti con il sistema proporzionale. La soglia da raggiungere è di 270 Grandi elettori.
Questo sistema spiega perché può accadere che il candidato che prenda più voti a livello nazionale, possa comunque perdere le elezioni. L’ultima volta è accaduto nel 2016 a Hillary Clinton: accumulò tre milioni di preferenze più di Donald Trump, ma non fu sufficiente per diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti.
Il conteggio.
Per ufficializzare il risultato però bisogna attendere qualche settimana. Le autorità dei singoli Stati devono comunicare i dati, prevedono le leggi, «non più tardi del quarto mercoledì di dicembre». Quest’anno la scadenza sarà il 25 dicembre. Il Congresso poi si riunisce il 6 gennaio, per ratificare i risultati e proclamare la nomina del Presidente. Una data insignificante per un passaggio puramente formale fino al 2021, quando i supporter di Trump assaltarono Capitol Hill per provare a sabotare la ratifica.
È anche capitato che ci fossero dubbi reali sui conteggi e che nessun concorrente raggiungesse quota 270 Grandi elettori. In questo caso la Costituzione prescrive che sia la Camera dei Rappresentanti a scegliere il Presidente. Nel 2000 si verificò un clamoroso corto circuito. Al Gore e George W.Bush presentarono una serie di ricorsi per il risultato in Florida.
Alla fine intervenne la Corte Suprema di Washington che assegnò la vittoria a Bush. Tutte queste tappe procedurali spiegano perché il periodo di transizione duri due mesi e mezzo. Il termine ultimo è fissato dalla Costituzione: il nuovo Presidente deve giurare il 20 gennaio, e mettersi al lavoro a partire da mezzogiorno.
Perché il martedì?
Resta l’ultima curiosità: perché si vota sempre a novembre e di martedì? La decisione risale al 1845, quando il Congresso stabilì che novembre era il mese più adatto, perché erano terminati i raccolti e quindi gli elettori, per lo più possidenti terrieri, si potevano spostare. Si scartò subito la domenica, in quanto giorno dedicato al riposo, si scelse il primo martedì del mese per dare il tempo di raggiungere i seggi, a cavallo o in calesse.
Quest’anno la data è fissata per il 5 novembre.

Probabilmente un buon numero di lettori si attende che in questa puntata della rubrica Le parole della neopolitica io mi occupi di Alessandro Giuli, da poche settimane Ministro della Cultura.
Giuli è stato al centro di commenti, critiche, espressioni di sostegno proprio per il lessico contenuto nell’incipit, piuttosto elaborato e concettoso, del suo intervento alla seduta congiunta delle commissioni cultura di Camera e Senato, l’8 ottobre 2024, nelle quali ha presentato le linee programmatiche della sua attività come ministro.
Alcune delle parole contenute nella parte iniziale dell’intervento sono state oggetto di polemica politica o di satira e potrebbero benissimo essere trattate qui: per esempio, infosfera globale, ipertecnologizzazione, apocalittismo.
Ma, lasciando a Giuli il ruolo di protagonista delle soluzioni più inattese dell’attuale lingua della neopolitica, vorrei analizzare una parola usata qualche giorno prima del discorso davanti alle commissioni parlamentari. Il 6 ottobre, in un intervento a un’iniziativa di Fratelli d’Italia a Brucoli, in provincia di Siracusa, Giuli ha detto: «La sinistra si sta spaccando sulla Rai, posto che i 5 Stelle siano di sinistra, perché il frazionismo è un tratto distintivo della sinistra, che appena può si divide». La parola che va messa sotto la lente è una parola che credevo desueta, frazionismo.
Frazionismo è parola nata un secolo fa all’interno degli schieramenti di sinistra: i vocabolari storici ricordano la sua presenza in un articolo dell’«Unità» del 1924 (anno della fondazione, da parte di Antonio Gramsci, di quel quotidiano comunista); ma lo si ritrova già l’anno precedente nell’«Avanti!» del 4 ottobre, in una posizione di rilievo, dal momento che appare nel titolo: «Il frazionismo e la paralisi del Partito».
Ero convinto che, anche in questo caso, si trattasse di una trovata personale, e magari un po’ esibizionista di Alessandro Giuli, che negli ultimi tempi aveva frequentato gli scritti di Gramsci e, immagino, quelli del suo tempo e del suo ambiente, per elaborare il libro Gramsci è vivo. Sillabario per un’egemonia contemporanea, uscito quest’anno da Rizzoli.
Pensavo, insomma, a un recupero dotto e isolato di una parola oggi disusata in politica, perché legata agli anni della scissione del Partito socialista e della conseguente nascita del Partito comunista; una parola pienamente legata alla politica comunista, e al suo riferimento internazionale, la Russia: si tratta, infatti, di un calco sul russo frakcionnost’, derivato da frakcija ‘frazione’, usato per indicare la tendenza a formare correnti organizzate all’interno del partito socialdemocratico. La parola faceva parte del vocabolario politico russo già dall’epoca prerivoluzionaria.
Da Gramsci ai nostri giorni
L’interpretazione di un recupero dotto aveva tutta l’apparenza di essere corretta, anzi di essere l’unica interpretazione ragionevole. Dai resoconti parlamentari, infatti, emerge che alla Camera non si parla più di frazionismo dal 1971; più recente la rinuncia a questa parola nei dibattiti del Senato, dove, comunque, nessuno ha più usato il termine né nella scorsa legislatura né in quella attuale. Insomma, frazionismo sembrava davvero una parola messa in archivio.
Ma non è proprio così. Prescindendo dalle ricostruzioni storiche delle divisioni dei partiti di sinistra, la parola continua a riaffiorare, sia pure sporadicamente, innanzi tutto in bocca ai politici di sinistra.
Nicola Zingaretti, del Partito Democratico, in un’intervista a fanpage.it, il 27 maggio 2024 ha dichiarato: «grazie alla leadership di Schlein tanto frazionismo e tanto egoismo, che pure è rimasto, oggi sono più marginali di un tempo»; Luigi Zanda, anch’egli del Partito Democratico, in un’intervista al «Foglio» del 1° ottobre 2024 (cioè cinque giorni prima del discorso di Giuli), ha a sua volta usato frazionismo: «in Italia, paese di colazioni dai tempi di De Gasperi, serve un proporzionale con una soglia di sbarramento alta, almeno il 5 per cento, in modo da rappresentare le diverse opinioni e combattere il frazionismo che ha sempre avuto effetti nefasti».
La parola compare anche in sedi periferiche, quali la «Gazzetta di Benevento», dove la parola risulta utilizzata in un comunicato di Renzo Cicatiello di «Articolo Uno Sannio. Parte da Noi con Elly Schlein» del 3 marzo 2023:
Retoricamente, si è alimentata una finta discussione sulle correnti, sulla loro esistenza, sulla loro funzione, senza mai affrontare con la necessaria verità, il tema della differenza, del frazionismo necessario, della fatica della sintesi che diventa unità e non unanimismo.
Ma non mancano testimonianze di esponenti centristi, come Benedetto Della Vedova, nel sito di +Europa, il 12 gennaio 2022, in occasione dell’annuncio dell’alleanza con Azione: «Rimaniamo soggetti distinti ma diamo un segnale in una politica italiana caratterizzata da separazioni e frazionismo».
E troviamo la parola anche in dichiarazioni e testi di esponenti di destra: l’ex leghista Roberto Castelli, in una conferenza stampa del 21 settembre 2023 («agli autonomisti che soffrono di frazionismo: se ci uniamo forse potremo fare sentire la nostra voce, fare sentire la voce del Nord»), la Gioventù Nazionale (organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia) di Lamezia Terme, in un post del 6 luglio 2018 su Facebook:
Combattere al tempo stesso, ma con la mentalità squadrista e rivoluzionaria e non certo con il frazionismo sovversivo, la cultura e il modello oggi vigenti, aggredire il capitalismo con l’autonomia e con lo sviluppo di un corporativismo imposto dal basso.
Resta più che probabile che la parola frazionismo frullasse nella testa di Alessandro Giuli in seguito alle sue recenti letture di Gramsci e dintorni; ma la sua riesumazione non cade in un vuoto assoluto.
Le attestazioni sono poche, ma dalla ricostruzione qui presentata si ricava che frazionismo riemerge più di qualche volta dal deposito di parole politiche poco usate, ma non scomparse del tutto.

In Se noi bruciamo ha raccontato tutte le contestazioni e le rivolte dell’ultimo decennio.
Abbiamo parlato con lui di rabbia, repressione, e della rara e famosa pars construens.

Se noi bruciamo è il secondo libro di Vincent Bevins, pubblicato da Einaudi. È un racconto di tutte le proteste popolari scoppiate negli anni Dieci: in Tunisia, Egitto, Bahrain, Yemen, Turchia, Brasile, Ucraina, Hong Kong, Corea del Sud, Cile. Bevins racconta le speranze e le delusioni di queste proteste, dando voce a chi vi ha preso parte. E si chiede: come possono funzionare queste rivolte? Bevins è nato a Santa Monica, ha quarant’anni, è stato corrispondente dal Brasile e dall’Indonesia per il Financial Times, il Los Angeles Times e il Washington Post.
ⓢ Come ti è venuta l’idea di scrivere Se noi bruciamo?
Non ho scelto di interessarmi alle rivolte popolari, è un fenomeno esploso fuori da casa mia a San Paolo, in Brasile, nel giugno 2013. Da lì, mi sono appassionato. Nel 2019, subito dopo l’uscita del mio primo libro, ho deciso di ampliare le ricerche. Ho trascorso quattro anni in giro per il mondo, intervistando circa 250 persone provenienti da 12 nazioni diverse e leggendo i libri più rilevanti sull’argomento. Ho scritto Se noi bruciamo in quattro anni, dopo averlo concepito per un decennio.
ⓢ Pensi sia vero che, come diceva Churchill, la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte le altre forme che sono state sperimentate finora?
Io e Churchill abbiamo una concezione diversa di cosa sia una democrazia. Il mondo è cambiato. Se consideri democrazia soltanto la gestione formale di elezioni periodiche, penso che sia una forma di governo imperfetta. Nel contesto di Churchill ci sta guardarsi intorno e vedere il fascismo, i totalitarismi, e considerarli inferiori. La democrazia, però, non dovrebbe essere soltanto l’esistenza di processi che selezionano i leader, ma un sistema dove i leader rappresentano davvero il popolo, dove gli elettori hanno un potere decisionale, non solo di scegliere se sarà questo o quel partito a governare. Le prime proteste sui generis sono nate alla fine del ventesimo secolo, e sono esplose negli anni Dieci. Oggi gli eletti rispondono alle élite economiche, non ai cittadini. C’è differenza fra i finti processi democratici e le democrazie nel vero senso della parola.
ⓢ In Italia abbiamo il Movimento 5 Stelle, utile strumento per incanalare la rabbia popolare in un partito tutto sommato innocuo. Hai seguito le vicende italiane negli ultimi anni?
Ho incluso nel libro soltanto le proteste di massa così grandi da rovesciare un governo, o destabilizzarlo obbligandolo a profonde riforme. C’è però un fenomeno parallelo: l’antipolitica come risposta a crisi di rappresentanza nel sistema globale. È successo la scorsa decade in molti Paesi, uno di questi è l’Italia. In Brasile nel 2010 un clown si è candidato alle elezioni con lo slogan: «Votate per me, le cose non possono andare peggio». Questa soluzione, cioè premiare chi dice “votami, sono un outsider quindi farò meglio di chi è già lì, sto sfottendo il sistema, sfrutto un potere alternativo, magari perché sono ricco o una celebrità”, è emersa come strategia politica. È il contesto dove sono nati i 5 Stelle. Comunque, anche se ti presenti alle elezioni gridando che odi il sistema, se vinci poi devi governare. Un outsider non è più illibato delle persone all’interno delle istituzioni. Donald Trump è l’esempio perfetto, come Zelensky, Macron, Obama.
ⓢ Boris Johnson?
Anche lui. Spesso, chi si definisce alieno alla stanza dei bottoni mente. Boris Johnson appartiene per nascita alla casta che domina il Regno Unito. Donald Trump è un miliardario che finge di essere un imprenditore immobiliare, quando in realtà è un ereditiere che adora stare in televisione. La Brexit è stata alimentata dall’antipolitica, prima di trasformarsi in un autosabotaggio. L’antipolitica, così come il populismo di destra, è una pessima soluzione a problemi reali. È facile dire io non sono parte di questo, io farei meglio. Le cose si possono migliorare anche dall’interno. C’è il rischio altrimenti di scadere nell’autoritarismo alt-right, vedi Bolsonaro in Brasile. Liberiamoci dai partiti politici, dalla lotta e dal dibattito, l’essenza della democrazia, e affidiamoci a un uomo forte, a un gruppo di uomini che rappresenteranno l’intera nazione. Questo è lo sbocco più pericoloso.
ⓢ Secondo te è possibile immaginare oggi una rivoluzione negli Stati Uniti? Non tipo il 6 gennaio, qualcosa di più sistemico.
C’è una regola generale, nella storia dei movimenti rivoluzionari: di solito, arrivano di fretta e inaspettatamente. La Storia può bussare alla porta quando meno te l’aspetti. Posso immaginare nel mio Paese il collasso di una società che crea un vuoto di potere? È possibile, gli Stati Uniti sono un sistema politico potente ma disfunzionale. Temo però che, se succedesse fra poco, predominerebbero le frange più di destra dell’esercito. Una milizia estremista vincerebbe comodamente terribili battaglie combattute per strada.

ⓢ In Italia, al confine della cortina di ferro, negli anni ’70 il Partito comunista aveva il 30 per cento dei voti, e movimenti rivoluzionari di estrema sinistra ottennero un grande potere. Secondo alcune teorie, questi sommovimenti popolari morirono quando l’eroina venne introdotta nel mercato italiano dalla Cia per assopire i giovani, e spegnere le loro velleità rivoluzionarie. È realistico immaginare un simile disegno manipolatorio dietro al boom dei social media, perfetto strumento per depotenziare le proteste, confinandole sul telefono?
Non servono dietrologie, sappiamo per certo che negli ultimi vent’anni l’esplosione di aziende che sviluppano social media, guidate dal profitto e dalla pubblicità, ha profondamente trasformato la percezione umana del senso di comunità, del mondo, della politica. Siamo cambiati, da un punto di vista cognitivo, dal costante rapporto con i social media. Non è internet in generale ad aver inquinato il modo in cui le persone interagiscono, la colpa è di un modello d’impresa nato in California che prevede l’appropriazione di infrastrutture pubbliche da parte di un gruppo di oligarchi che hanno scoperto la formula per massimizzare i profitti: aumentare il tempo che passiamo incollati allo schermo del telefono.
ⓢ C’è anche l’influenza politica, vedi il caso di Elon Musk.
Elon Musk usa il potere economico per cambiare il discorso pubblico. I social media sono stati creati negli Stati Uniti, una delle società più individualiste. È molto semplice spiegare cos’è accaduto, quanto sia stato un fenomeno sconvolgente. È difficile levare internet a questi oligarchi, riprenderlo, creare un movimento democratico per rendere pubblico ciò che avrebbe già dovuto essere esserlo. Immaginiamo cent’anni fa, ai tempi dell’invenzione del telefono: cosa sarebbe successo se le persone che sostenevano di averlo inventato, invece di fornire servizi ai cittadini, si fossero arrogate il diritto di manipolare le tue conversazioni per tenerti in linea più tempo possibile, magari mettendo la pubblicità a metà chiamata?
ⓢ Hai fatto a lungo un mestiere da sogno, il corrispondente dall’estero. Che cosa ne pensi del citizen journalism?
Gli strumenti che fornisce internet sono un’aggiunta positiva all’ecosistema dei media. È un bene che una persona comune, non stipendiata da un’organizzazione, possa registrare l’intervista a un attivista di un movimento locale e pubblicare il video online. Nel frattempo il giornalismo professionistico, una parte importante della democrazia e della civiltà negli ultimi cinquecento anni, sta morendo perché non c’è più un modello di business sostenibile. Il giornalismo come vocazione, qualcosa che fai perché servono delle abilità e una dedizione a tempo pieno, sta sparendo. Dovremmo trovare dei modi per salvarlo. È difficile, penso ci sia bisogno di progetti politici, non di un piano aziendale. Non si può creare un modello economico innovativo, ci vuole un movimento per proteggerlo. Se non lo creiamo, il giornalismo scomparirà. E, dato che sta morendo, qualsiasi cosa che testimonia la prima bozza della storia va bene. Il problema è che il citizen journalism sembra rispondere alle stesse logiche dei social media, spesso viene messa in risalto la cosa più scioccante, strana o scandalosa. E questo non per colpa di quello che il giornalismo partecipativo è o può essere, è colpa dei social media. C’è il rischio che le aziende di marketing e pubblicità prendano possesso dello spazio che una volta era dei giornali, spacciandosi per attività editoriali.
ⓢ Se dovessi ritrovarti leader di una protesta popolare, quali sarebbero le tue prime tre richieste all’autorità?
Idealmente, ci potrebbe essere un tumulto se il governo commettesse abusi evidenti. Bisognerebbe rispondere organizzando gli attivisti in un sistema democratico all’interno del movimento per eleggere i rappresentanti e responsabilizzarli. Sarebbe necessario creare una lista di riforme. E, ovviamente, ci vuole una forte partecipazione popolare. Così quando vai dal governo con le tue domande, dopo una preparazione strategica, puoi dire: guarda, ho questo milione di persone, sono dietro di me e li rappresento davvero. La prima cosa che chiederei è tre pasti gratis al giorno nelle scuole pubbliche. Ci sono persone affamate in America. Potremmo chiamarlo il Black Panther Breakfast Program. Il governo non può rifiutare, e miglioreremmo gli Stati Uniti.
ⓢ L’Italia in confronto è un paradiso socialista, qua tutti i bambini hanno pasta e pizza gratis a scuola.
Anche il Brasile. Questo è un buon modo di negoziare. Chiedi una cosa grande, che non riuscirai a ottenere, ma fai nascere una conversazione.
ⓢ “Siate realisti, chiedete l’impossibile”, come dicevano nel ’68.
Nel 2020 molte persone in America hanno chiesto di abolire la polizia. Una richiesta troppo radicale per essere accettata, ma che ha fatto nascere un dibattito sullo status quo. Non puoi sperare di sfamare tutti i bambini del mondo, ma puoi accendere la scintilla che mette in moto un dibattito. Pasti gratis a scuola, e cercare di rendere gli Stati Uniti un Paese che non si senta al di sopra delle leggi internazionali. Sarebbero due belle conquiste.
ⓢ Aggiungerei, come terza, ospedali gratis. Ultima domanda: pensi che il cambiamento climatico sarà la forza che, in futuro, ci obbligherà a cooperare?
Lo spero. Ci sono molte possibilità in questo scenario apocalittico, tra cui l’inevitabilità di una collaborazione globale. Molti ostacoli la impedirebbero, ci vorrebbe un lavoro profondo, al momento improbabile, fra agenti internazionali. Le catastrofi climatiche aumenteranno l’immigrazione verso le nazioni più ricche, che potrebbero rispondere con violenza. Questo sarebbe catastrofico per la maggioranza dell’umanità, che casualmente non è nata nel mite bacino nord atlantico.
Finzioni
Nell’ottobre del 1924 André Breton pubblicava il primo Manifesto Surrealista: qui un racconto per festeggiare il centenario della società segreta che alla fine trionferà sulle tenebre, dalle tenebre
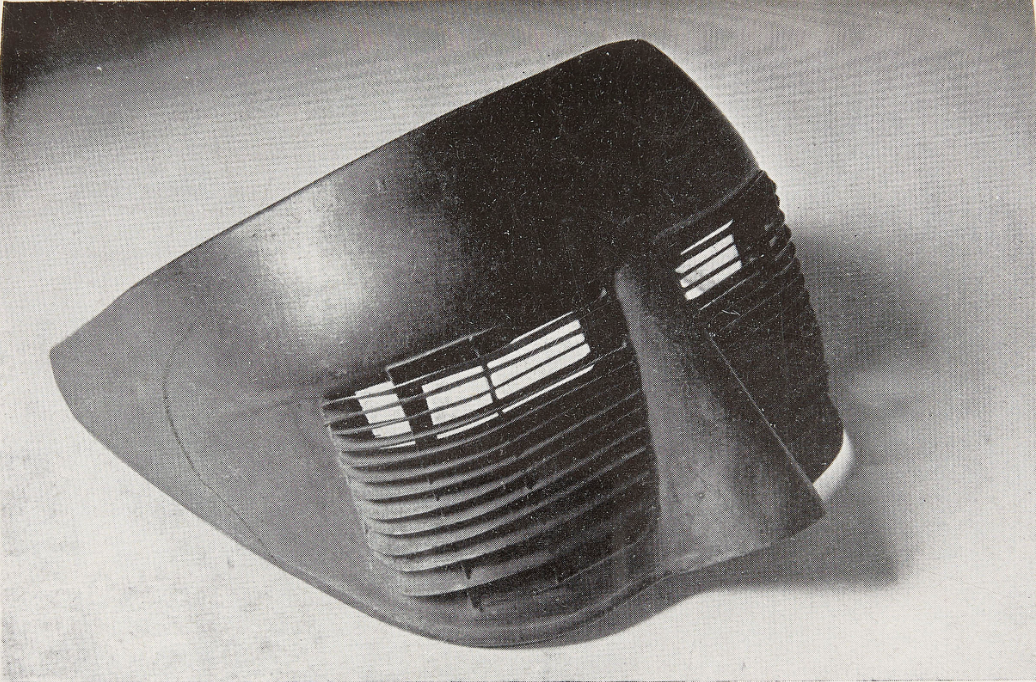 (Man Ray, 1936, illustrazione per «L’amour fou» di André Breton – Gallimard 1937, Einaudi 1974 e successive edizioni)
(Man Ray, 1936, illustrazione per «L’amour fou» di André Breton – Gallimard 1937, Einaudi 1974 e successive edizioni)
In Commedia dell’orrore in Francia, racconto che probabilmente è stato censurato dall’editoria mondiale per decenni, Roberto Bolaño riporta la disavventura di un giovane cileno a Parigi, convocato da telefonate anonime al cimitero del Père Lachaise per aderire a una setta di seguaci di André Breton che alberga nelle catacombe o piuttosto nelle fogne della capitale francese.
Pur avendo le sembianze letterarie di uno scherzo, il fatto è accaduto davvero ed è autobiografico: quando ormai era diventato un autore conosciuto, dopo la pubblicazione di alcuni libri alla metà degli anni novanta, prima del boom planetario dei Detective selvaggi, Bolaño – lo raccontò in via confidenziale all’amico scrittore Enric Montano, che mi ha poi riferito la storia – aveva preso a ricevere telefonate notturne al suo numero di casa, a Blanes.
Una voce contraffatta e suadente gli ripeteva due o tre volte la settimana che la sua presenza sarebbe stata gradita per la notte successiva, in un certo posto di Parigi, per delle ragioni che via via si andarono precisando nel corso delle notti, e che alla fine presero la conformazione, nelle parole di Bolaño riferite da Montano, di «un piano di sabotaggio universale a danno delle merde, per tramite della setta dei surrealisti clandestini».
Progetto che si doveva ispirare alla guida del dittatore e sacerdote del surrealismo, André Breton, che poco prima di morire aveva lasciato scritto proprio questo: il surrealismo doveva ritirarsi in clandestinità, e agire dalle catacombe di Parigi. («Le surréalisme est le ‘rayon invisible’qui nous permettra un jour de l’emporter sur nos adversaires», aveva scritto altrove).

Bolaño non aveva problemi a parlare di notte, perché soffriva di insonnia. Anzi, sogghigna Montano, i suoi amici poterono rilassarsi per un po’, perché ricevettero via via meno telefonate del solito, fino a smettere del tutto di riceverne.
Era proprio questo che turbò da principio Bolaño: non si sentiva più libero di chiamare i suoi amici di notte, perché la voce suadente gli teneva impegnato il telefono, e dopo le prime due o tre volte, lui stesso non osò occupare la linea aspettando la telefonata che non si presentava mai con cadenza fissa (intere notti passate a attendere inutilmente la prossima chiamata, racconta lo scrittore cileno).
Alcuni, ma non Montano, cominciarono a preoccuparsi del fatto che l’amico aveva smesso di svegliarli nottetempo per impegnarli in estenuanti chiamate telefoniche (a tema perlopiù letterario). Bolaño è scomparso, o è morto, disse qualcuno.
E qualcun altro andò a controllare e lui, evasivo, disse che stava avendo problemi con il gestore della sua linea telefonica, che a quel tempo era l’unico gestore di tutta la Spagna, e non stava dando problemi ad altri che a lui, sicché nessuno credette a quella versione, e ciascuno si fece la propria idea a proposito di quel repentino cambiamento.
A Bolaño le telefonate piacevano, ma davano anche motivo di frustrazione, perché egli non aveva tempo né voglia di andare a Parigi, la città che era stata per una stagione quella del suo amatissimo ma ormai defunto amico Mario Santiago, di cui avrebbe poi scritto nei Detective selvaggi sotto il nome di Ulises Lima, magari per poi scoprire che le telefonate erano solo una presa in giro, stuzzicata dalla sua incipiente fama e favorita dall’esistenza, già allora residuale, degli elenchi telefonici.
Poiché le telefonate continuarono a lungo, Bolaño cominciò a riflettere sul da farsi. Da un lato aveva il desiderio che quello scherzo si fermasse, perché cominciava a stancarlo e perché la cosa si stava protendendo verso una durata allarmante. Dall’altro era indeciso se rispondere una volta per tutte presente, o almeno scriverci sopra un grande romanzo convulso e stellato. Cominciò a credere che ci fosse qualcosa di vero nella faccenda della setta.
Agli scettici rispondeva con una frase di Breton presa da L’amour fou: «Mi sembra che la più grande debolezza del pensiero contemporaneo risieda nella stravagante sopravvalutazione di ciò che è noto rispetto a ciò che ancora rimane da conoscere».
Un mattino di pioggia battente, dopo essere rimasto alzato tutta la notte a rimuginare sulla telefonata ricevuta, nella quale stavolta si erano letti interi passi da opere di Breton che Bolaño avrebbe potuto riconoscere già al primo sintagma, lo scrittore si recò in cartoleria e comprò una mappa tascabile di Parigi, con grande sorpresa del cartolaio che lo conosceva come uno che mai più avrebbe messo piede a Parigi in questa vita.
Attraverso gli appunti che da un certo momento in poi aveva cominciato a accumulare, Bolaño prese a segnare sulla cartina i luoghi che gli erano stati indicati di volta in volta: luoghi sempre diversi, tranne per il Père Lachaise, che ricorreva nella proporzione di uno a tre («And every third thought shall be my grave», dice Prospero nella Tempesta).
Dopo qualche mese, e svariate telefonate notturne durante le quali lui non diceva mai niente, quando ormai si era alle porte della primavera, Bolaño ebbe da suo figlio, allora un bambino di sei o sette anni, l’idea di unire i puntini che aveva segnato in rosso sopra la cartina.
Tracciando, quasi incidendo, precise linee rosse con il pennarello, padre e figlio videro apparire sopra la cartina (che da poco ho potuto vedere con i miei occhi, oggetto dozzinale con i luoghi di interesse turistico segnalati da uno sgarbato rilievo di plastica) il disegno di una sorta di ragnatela sbilenca che al suo centro aveva, stranamente, un luogo a nord di Parigi immerso tra le nebbie (almeno così se lo immaginavano i due improvvisati cartografi cileni, non molto pratici della città).
Le telefonate cessarono di colpo il giorno della pubblicazione dei Detective selvaggi. Anni dopo, quando Bolaño decise di trarre dalla curiosa esperienza un racconto, o forse un romanzo-fiume di cento cartelle, come gli era già capitato, fu ormai troppo tardi.
Commedia dell’orrore in Francia rimase incompiuto perché lo scrittore dovette concentrare le sue esigue forze di uomo gravemente malato nella stesura di un altro romanzo, edito comunque dopo la sua morte e a sua volta non finito. La storia delle telefonate fu dimenticata da tutti e Montano non ha fatto altro che custodirla silenziosamente per decenni, insieme alla cartina, ormai ingiallita e cenciosa.
2.
Batignolles è tra i quartieri che in anni recenti hanno subìto la trasformazione più profonda, in una città già ipercinetica di suo (Patrick Modiano, lui sì indomito cartografo della capitale francese, in uno dei suoi ultimi romanzi fa dire al narratore che in certi luoghi di Parigi «si ha l’impressione ormai di camminare in una città straniera»).
A Batignolles sorge il complesso architettonico avveniristico attorno al parco Martin Luther King, che, non per il nome, sembra un giardino di Downtown Chicago, circondato da palazzi di vetro e acciaio. Un po’ più in là c’è il nuovo tribunale, un grattacielo scalare che fa ombra da lontano alla piccola square de Batignolles, frequentata e dipinta dagli impressionisti, e ora invasa da una mandria irrequieta di corridori folli, compressi in anguste tutine catarifrangenti. Il cimitero del quartiere è defilato, nascosto dal boulevard périphérique che abbraccia la città, in un groviglio di perenni lavori in corso e qualche – fatto raro – immobile diroccato.
Quasi nessuno degli abitanti del quartiere ha un parente sepolto lì, e se non fosse stato per una ricerca mirata, non lo avrei mai trovato passandoci accanto. Mi ero trasferito a Batignolles da poche settimane. Avevo appena letto certi racconti parigini di Julien Green portati a casa mia da un’amica e abbandonati con sdegno sul comodino: essi mi avevano condotto al minuscolo cimitero di Passy, un luogo sorprendente, mimetizzato in un angolino alle spalle del Trocadéro.
Mi chiesi se non ci fosse un cimiterino ben nascosto in ciascuno dei quartieri della città, e così mi misi a cercare nel mio. Il nuovo vicino, un milionario che viveva nel Midi e teneva un «pied-à-terre in città» (in realtà un appartamento di duecento metri quadri con tre balconi sulla strada, in fondo alla quale anni addietro doveva essere stata ricavata, separando la stanza degli ospiti dal resto del pied-à-terre, e includendo per mia fortuna una luminosa vetrata liberty, la casa dove vivevo da poco), mi disse di non averne mai sentito parlare.
Si espresse negli stessi termini la signora portoghese della pastelarìa, con cui ero entrato subito in cordiale confidenza, e che viveva nel quartiere, mi disse, da oltre trent’anni.
Trascorsi una intera domenica mattina a camminare nei paraggi, senza trovare il cimitero di Batignolles, che pure con questo nome compariva nell’elenco dei cimiteri cittadini che avevo consultato. Non ancora rassegnato a impiegare una mappa elettronica disponibile in rete, andai al mercato delle pulci, a Saint-Ouen, dove Breton incontrò una donna che gli chiese se voleva ascoltare una poesia da lei conosciuta a memoria.
Lì trovai incorniciata una antica cartina di Parigi, molto ampia e troppo preziosa. La consultazione andò a buon fine. Finsi di trattare sul prezzo, che non avrei accettato nemmeno se fosse stato la metà di quello che mi chiedeva il minaccioso rigattiere (la metà di assai è sempre assai, diceva mio padre in napoletano), poi me ne andai con l’informazione che finalmente avevo acquisito (ho buona memoria «fotografica» e senso dell’orientamento, soprattutto se ho potuto osservare una mappa prima di addentrarmi nel territorio).
Mi dedicai ad altro. Qualche settimana dopo, un pomeriggio di novembre, tornando da una lunga passeggiata lungo l’Oise, mi ritrovai nei sobborghi a nord della città, e mi venne in mente di rientrare dalla parte del tribunale, non lontano dal quale avrei trovato il cimitero. Era accanto a un campo di calcio dove si stava giocando una improbabile partita tra bambini di otto anni. All’ingresso vidi la vecchia insegna di un marmista funebre, sul muro di una piccola palazzina crollata.

Il cancello d’ingresso, verde speranza, cigolava e opponeva resistenza. Mi venne incontro quello che doveva essere il custode, un omone sulla cui pelle nera la camicia bianca produceva un effetto di grande eleganza. Mi diede il benvenuto e disse di chiamarsi Bemba.
Poi, dopo una strana pausa, aggiunse con un sorriso, professeur Bemba. Pensando a uno scherzo, sorrisi. Accolgo sempre con entusiasmo lo sparuto gruppo dei parigini gioviali. Mi chiese se volessi per caso sapere chi erano gli uomini illustri sepolti lì. Credevo che non ce ne fossero, dissi. Mi disse che André Breton era lì. Mi sembrò che insistesse con lo sguardo in qualche modo.
Che ci fa qui Breton? Chiesi di condurmi alla sua tomba, dubitando che il professeur Bemba avesse ragione. Ci sarà magari un omonimo, o un parente. Breton è al Père Lachaise, mi dicevo, o a Montparnasse, con Baudelaire e Beckett. Di nuovo il custode si comportò in modo strano. Non posso, mi disse, deve andarci da solo (ma non mi aveva appena detto che mi ci avrebbe portato lui? Me lo ero immaginato, ingannato dalla sua gentilezza?). Se la accompagnassi, qui all’ingresso non resterebbe nessuno.
Posai lo sguardo sulla guardiola dipinta con la stessa pittura usata per il cancello. C’erano due o tre avvisi comunali, gli orari del cimitero, e un’altra targa sbiadita che diceva «C’est vivre et cesser de vivre qui sont des solutions imaginaires. L’existence est ailleurs». Una frase appropriata, in quel contesto, ricordo di aver pensato. Mi incamminai, benedetto da un cenno amichevole del professeur Bemba che mi fece tornare la mente a certi vecchi greci di paese, quando lasci casa loro dopo aver goduto della più perfetta e gratuita ospitalità, e quelli ti seguono fin sull’uscio, e poi alzano il braccio, e dicono con voce stentorea, come se fosse la battuta di un attore in teatro, kalò dròmo!, buona strada.
Il cimitero era completamente silenzioso. Come molti, subisco il fascino di questi luoghi, mi piace soffermarmi sulle vecchie tombe. Ci si raccoglie volentieri. Una epigrafe più recente delle altre chiedeva al defunto, senti i nostri baci? Avanzando lungo il vialetto principale notai che il cavalcavia del périphérique passava praticamente sopra il cimitero. Insolito. E d’altronde il viavai dei veicoli non interveniva a turbare la pace dei morti, e nemmeno quella dei vivi che gli rendevano visita.

Mi ci volle quasi un’ora prima di trovarla. Mi ero arreso quando per caso vi posai sopra lo sguardo: la tomba di Breton, e di Elisa, la donna cilena sepolta accanto a lui. Mi vennero in mente i suoi libri, quelli che avevo amato, libri fatti di apparizioni: Nadja, e L’amour fou, dove, districandosi in una foresta di segni, si può trovare scritto: «la bellezza è come un treno che incessantemente scalpita nella Gare de Lyon. E di cui so che non partirà mai, che non è partito».
E può forse lasciare indifferenti la grazia spericolata del Manifesto surrealista del 1924, quando proclama che «il linguaggio è stato dato all’uomo perché ne faccia un uso surrealista?»… Una strana associazione: dietro la tomba di Breton c’era una cappella il cui vetro laterale era stato sfondato (da un corvo?). Se ci si metteva esattamente tra essa e la tomba dello scrittore, dove stavo io, si vedeva oltre il vetro rotto un cristo dipinto in fondo alla cappella che saluta anche lui con il braccio, come il professeur Bemba o come il vecchio greco che dice kalò dròmo, come se qualcuno (un corvo?) avesse rotto il vetro di proposito per favorire l’incontro fra Breton e Gesù.

La temperatura era calata bruscamente, e non doveva mancare molto al tramonto. Era una di quelle giornate in cui Parigi può essere molto bella, come fu scritto, quando il cielo è limpido e fa freddo. Sentii una mano che si posava dolcemente sulla mia spalla. Era il professeur Bemba, che mi coglieva distratto, spaventandomi. Il cimitero chiude mi disse, dobbiamo andare. E ce ne andammo.
Ero rapito dai pensieri, un po’ malinconico ma allo stesso, nella pienezza di quel sentire, ero felice. Bemba fece tintinnare un gigantesco mazzo di chiavi. Arrivati al cancello cigolante mi allungò un foglietto di cui mi sembrò che tenesse una scorta nel taschino della camicia (non aveva freddo a girare vestito in quel modo?). Sorrise, e io ricambiai.

Mi disse di chiamarlo, se mi avesse fatto piacere, e io annuii senza capire, a malapena stavo ascoltando quello che mi diceva. Mi incamminai verso casa come in sogno, non ricordo la strada percorsa per arrivarci.
Fui bruscamente risvegliato solo dal rombo di una motocicletta che sfrecciò davanti al portone di casa, mentre faticosamente compivo il rituale dell’estrazione delle chiavi dalla tasca dell’impermeabile (gesto che a Parigi, se compiuto in strada, è del tutto inutile: i palazzi si aprono con codici alfanumerici che si devono digitare a memoria, le chiavi subentrano soltanto à l’etage: la forza dell’abitudine, oppure, appunto, un piccolo rituale del ritorno a casa, un sonaglio per scacciare gli spiriti cattivi che potrebbero averla occupata in nostra assenza).
A casa mi accorsi del foglietto, che intanto avevo completamente dimenticato. Per la prima volta lessi quello che c’era scritto sopra, stampato con quello che doveva essere un vecchio ciclostile. Diceva Professeur Bemba, poi sotto, più piccolo, aggiunto a mano, le magicien de Batignolles, il mago di Batignolles, voyant medium, grand maître de sciences occulte, e poi una serie infinita, o dovrei dire automatica, di corbellerie.

Mi lasciai andare a esclamazioni di divertito e grossolano stupore. Pensai subito di chiamare Margot per raccontarle della mia nuova conoscenza e dell’incontro inatteso con Breton. Pensai di andare a farmi leggere il futuro, la mano, o che so io. Ridevo. Cucinai un piatto di pasta, bevvi del vino. Che ci faceva Breton nel cimitero di Batignolles? Avrei dovuto indagare ma fui presto distolto da tutt’altro, già quella sera. Per quasi un anno smisi di chiedermelo, e mi dimenticai di tutta la storia.
3.
Una amnesia inconsueta, adesso devo riconoscerlo. Potrei dire che ho avuto da fare con un libro che non riuscivo a concludere, o che sono stato distolto da faccende personali. Ma sarebbe poi vero? Qualcosa mi ha fatto tornare in mente Breton: con la redazione del «manifesto» parliamo di un possibile omaggio in occasione del centenario della pubblicazione del Manifesto surrealista. Allora mi vengono alla memoria entrambe le cose: la storia che mi aveva raccontato Montano, e la bizzarra collocazione cimiteriale di Breton.
Mi ricordo che Montano mi ha scritto da poco per avvisarmi del fatto che sarebbe tornato a Parigi in autunno. Gli chiedo questa volta di portare con sé la cartina di Bolaño, o una riproduzione di essa. Intanto mi metto a cercare il foglietto del professeur Bemba, che dovevo aver conservato da qualche parte. E in effetti non mi è difficile farlo saltare fuori, sotto una pila di cartacce e vecchi giornali che giacciono in apparente disordine sopra un tavolino.
Quasi senza pensarci, chiamo. Mi parla una voce suadente, che non si presenta né mi chiede niente, come se si aspettasse una mia telefonata. Mi dice che ci sarà un rendez-vous al cimitero di Batignolles. È importante non parlare con nessuno di questa cosa, dice. Ha una voce allusiva. Suadente e allusiva. Uno scherzo. Allora sprofondo di nuovo in quella specie di trance, la stessa di quando uscii dal cimitero per tornare a casa.
Non racconto niente a nessuno. Non che prenda sul serio la cosa, ma è divertente assecondarla. E poi, io sono già a Parigi. Vado. Si gela, per strada non c’è nessuno. Dal lato della bottega dei marmisti c’è una figura immersa nel buio che mi fa un cenno. Passo di là, il cancello verde è chiuso. Dal rudere si accede al cimitero attraverso una breccia nel muro. Davanti a me c’è un gruppo di persone, parlano sottovoce.
Sono vestite con lunghi cappotti scuri. Mi avvicino, e noto che tutti portano delle maschere nere sul volto. Un incrocio tra un casco da schermidore e un manufatto veneziano, devo aver già visto qualcosa del genere ma non ricordo dove. È poco rassicurante.
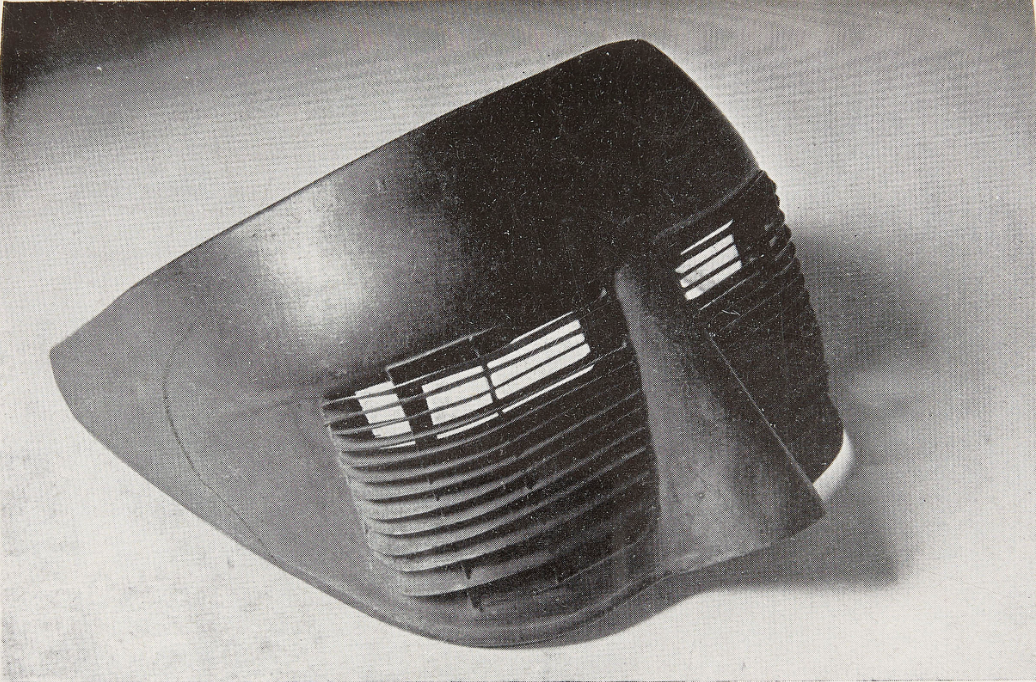
Dalle movenze flessuose riconosco sotto la sua bardatura il professeur Bemba, che oltre alla maschera mi sembra indossi un vero e proprio passamontagna. Vengo accolto da un sottile mormorio, dal quale non si distinguono che poche confuse parole come nuages, tu ne pardonnes pas, vases… Taccio. Il corteo si dirige naturalmente verso la tomba.
Sento le gambe pesanti. Ho freddo. Vengono posate delle conchiglie sulla lapide. Ci rincantucciamo in un luogo del cimitero che non avevo visitato, in fondo, quasi sotto il cavalcavia dell’autostrada. Lì c’è soltanto una tomba, isolata, quasi sopraffatta da rigogliosa vegetazione che al buio si distingue a malapena da un drappeggio barocco. I passamontagna e le maschere mi fanno paura, ho paura. Mi giro e muovo verso l’uscita. Diciamo pure che scappo via. Nessuno si cura di me.
Di notte, sogno: quello che mi sembrava il professeur Bemba si dirige verso la lapide solitaria, e con mio sommo sgomento la abbatte in avanti come il sedile di un’automobile. Nella striscia di terreno adesso liberata dalla pietra si apre una fenditura di luce, una botola. Uno degli astanti emette un grido pauroso, stridulo, poi un guanto azzurro emerge dalla botola. Corro via con uno scatto repentino, nessuno mi segue. Poi mi sveglio.
Ci vogliono quattro o cinque giorni perché io esca nuovamente di casa. Montano mi ha scritto per dirmi che la sua visita a Parigi è rimandata, che non si sente abbastanza bene per affrontare il viaggio da Barcellona. La libreria dove avrebbe presentato il suo ultimo libro tradotto in Francia ha proposto una nuova data, in primavera, e lui ha accettato.
Acclude una foto alla letterina elettronica con la quale mi informa di questo (spesso acclude immagini alle sue letterine elettroniche: conservo ancora un memorabile fotogramma di Cary Grant con gli occhiali da sole lungo i binari del treno, in Intrigo internazionale). È la cartina di Bolaño, ripresa evidentemente dal suo cellulare (Montano, dall’alto dei suoi settanta sette anni, è esperto nell’uso del cellulare). La apro subito dopo aver letto il testo.
Quello che si disegna sullo schermo non mi raggela meno bruscamente della botola illuminata sotto l’erba, nel cimitero sognato. La ragnatela rossa tracciata sulla mappa individua un punto decentrato, a nord ovest di Parigi, che non esito con orrore a individuare nel quartiere di Batignolles.
Le surréalisme vous introduira dans la mort qui est une société secrète. (Breton)