
Joseph Rykwert: gli dèi, gli uomini e l’architettura (doppiozero.com)
Architettura
“Se la città deve essere messa con la fisiologia, più che a ogni altra cosa essa assomiglia a un sogno”, così scrive Joseph Rykwert nella prefazione del suo libro più noto L’idea della città: antropologia della forma urbana nel mondo antico, tradotto in italiano nel 1976, da Einaudi (e ora ristampato da Adelphi), ma scritto negli anni Sessanta del Novecento e pubblicato negli Stati Uniti.
Senza i sogni, come ci raccontano i miti e le leggende, le città antiche non sarebbero sorte, e non avrebbero avuto ciascuna una propria specifica forma. Rykwert, nato in Polonia nel 1926 e morto ieri, ha studiato negli anni Quaranta in Gran Bretagna con i grandi ricercatori della prima generazione del Warburg Institute di Londra, in particolare con Rudolf Wittkower, per poi insegnare il resto della sua lunga vita anche negli Stati Uniti.
Dotato d’una capacità di scrittura saggistica che è racconto e fabulazione, lo studioso polacco ha messo in luce come le grandi innovazioni architettoniche e urbanistiche derivino dallo stretto rapporto tra questa disciplina, atta a costruire, e le espressioni religiose del mondo classico, quella greca e romana prima di tutto e, per quanto riguarda quest’ultima, le sue ascendenze etrusche che si compendiano in un “rito” assorbito e rielaborato dalla civiltà costruttiva di Roma, in cui la lettura dei movimenti celesti e delle pratiche religiose erano strettamente intrecciate con i principi giuridici: ordine divino e ordine umano.
Bellissime sono le pagine dedicate a mura, porte, templi, o agli spazi sociali come il foro: forme e simboli che organizzano lo spazio collettivo e quello privato. Senza mai cadere in nostalgie, Rykwert ci ha fatto capire come la morfologia del paesaggio urbano nasca in stretto rapporto con i miti che innervano le pulsioni più profonde delle antiche civiltà.

Capace di affrontare la lettura dell’architettura modernista, e al tempo stesso a suo agio con la filosofia di Hegel, come con il disegno di Piranesi o le idee di Leon Battista Alberti, con il pensiero antropologico come con quello sociologico, questo magnifico studioso, che parlava un italiano non solo corretto ma elaborato e colto, è stato un personaggio solitario nella cultura architettonica del Novecento, capace di dialogare con saperi e discipline di cui aveva appreso i primi rudimenti nella Polonia ebraica nell’ambito di quella scienza interpretativa che è il Talmud.
Dotato d’una forza immaginativa davvero unica, come mostra l’altro capolavoro della sua produzione, La casa di Adamo in Paradiso, tradotto da Adelphi nel 1972, si può dire che Rykwert sia stato un materialista religioso, in grado d’accostarsi alle immagini della sfera del sacro sapendovi leggere insieme le strutture più profonde.
Strutturalista senza strutturalismo, aveva una conoscenza profonda dell’architettura di ogni luogo e d’ogni epoca, da quella giapponese a quella australiana, superando le tradizionali divisioni accademiche. In quel libro scandagliava il mito della “prima casa” intesa come archetipo sempre presente e agente sia sul piano immaginativo che su quello simbolico.
Pochi forse sanno che proprio Rykwert è stato uno degli ispiratori delle Città invisibili di Italo Calvino, che non a caso fu tra coloro che vollero la traduzione einaudiana di L’idea di città.
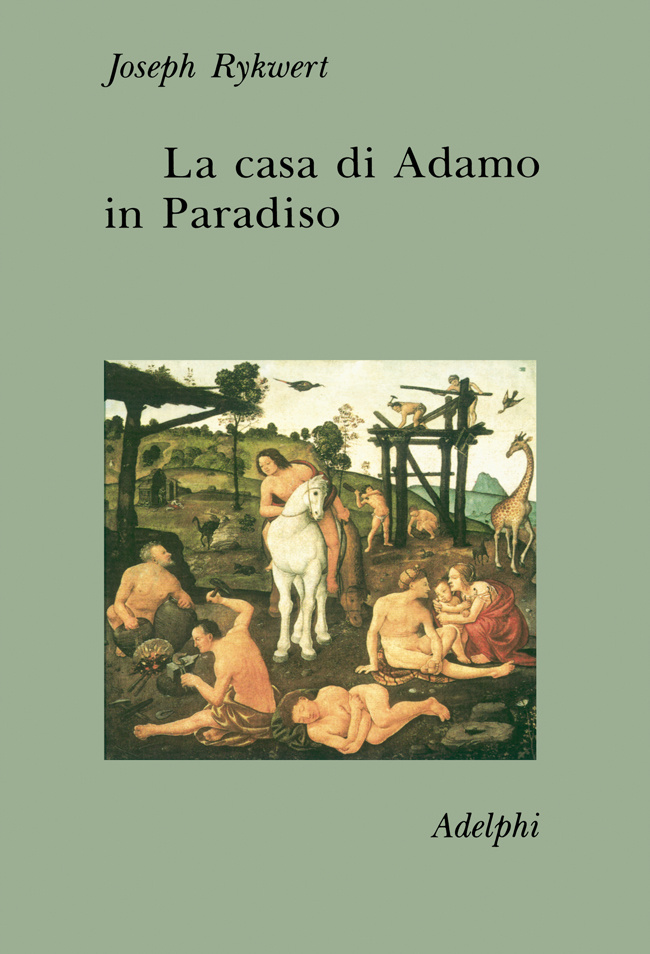
Tra gli abbozzi e le note vergate dallo scrittore ligure nel corso dell’elaborazione del suo poema in prosa, che tanto ha ispirato il pensiero di architetti e urbanisti, il nome di Rykwert compare accanto all’elenco di temi e oggetti che gli interessavano.
Nel momento in cui si accingeva a scrivere il suo viaggio tra le città del passato e quelle del futuro, un’opera che ha ancora tanto da dirci riguardo al crogiolo di culture e immagini che sono oggi le città del mondo, Calvino pensava alla presenza degli dèi occulti e sconosciuti nelle nostre metropoli.
Ma se si vuole capire cosa sia stata l’architettura per l’umanità bisogna aprire un altro libro di Rykwert dal titolo invitante e insieme misterioso e ossimorico: La colonna danzante (Libri Scheiwiller), il cui emblematico sottotitolo non a caso è: Sull’ordine in architettura.
Un libro che stabilisce la corrispondenza tra gli edifici e il corpo umano, procedendo a una ricostruzione rigorosa e motivata delle successioni formali legate al tema architettonico della colonna, opera tradotta nel 2020 e ben presto scomparsa dagli scaffali delle librerie, che invece dovrebbe essere adottata da tutte le facoltà d’architettura del mondo.
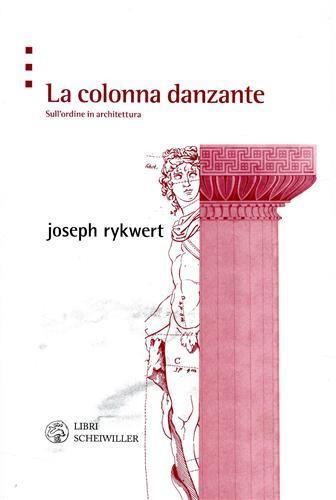
In uno dei suoi ultimi lavori, La seduzione del luogo: storia e futuro della città (Einaudi 2008), lo studioso polacco ha fatto il punto in modo inequivocabile sulla perdita di quel valore religioso delle città, dove la questione centrale riguarda il legame che gli uomini e le donne stringono gli uni con gli altri, unione simbolica dissolta e trasformata oggi in un puro valore economico.
Nella prefazione al volume Rykwert spiega come l’architettura non possa essere guidata da ragioni solamente razionali o economiche, ma piuttosto da concetti, sentimenti e soprattutto da desideri. La città intrattiene un rapporto profondo con il conscio e l’inconscio degli esseri umani, e anche con quelli delle società, poiché esistono forme oniriche collettive che attraversano tutte le città.
Senza mai abbandonarsi a forme irrazionali, Rykwert ha dosato con cura i due poli della natura umana, quello della tendenza alla costruzione raziocinante, incarnata per forza di cose in architettura dalle tecniche costruttive, e quello del meraviglioso, che prescinde dagli interessi economici e politici che oggi invece vorrebbero dirigere dall’alto, mentre inevitabilmente emergono forze pullulanti e inafferrabili generate dal basso.
Nella parte del libro intitolata Interrogativi per il nuovo millennio, e nella nuova postfazione scritta per la edizione italiana, Rykwert sottolinea come il proliferare di grattacieli nelle maggiori capitali del mondo – il suo sguardo si appuntava in quel momento sulla città cinese di Shanghai, per lui la New York del nuovo millennio –, sia composto di edifici che aboliscono la forma tradizionale del grattacielo pensato e realizzato nel corso del XX secolo.
Ora all’inizio del XXI secolo queste costruzioni, che hanno racchiuso nel bene e nel male tutta l’energia e lo spirito d’iniziativa che alimentava il sogno americano, cancellano i grandi piani che un tempo contenevano spazi pubblici e commerciali, a vantaggio di forme che all’inizio degli anni Novanta sorgono bruscamente dal marciapiede e si stagliano contro il cielo – rampicanti “a punta di matita” li definisce – i cui ingressi sono sorvegliati da guardie armate.
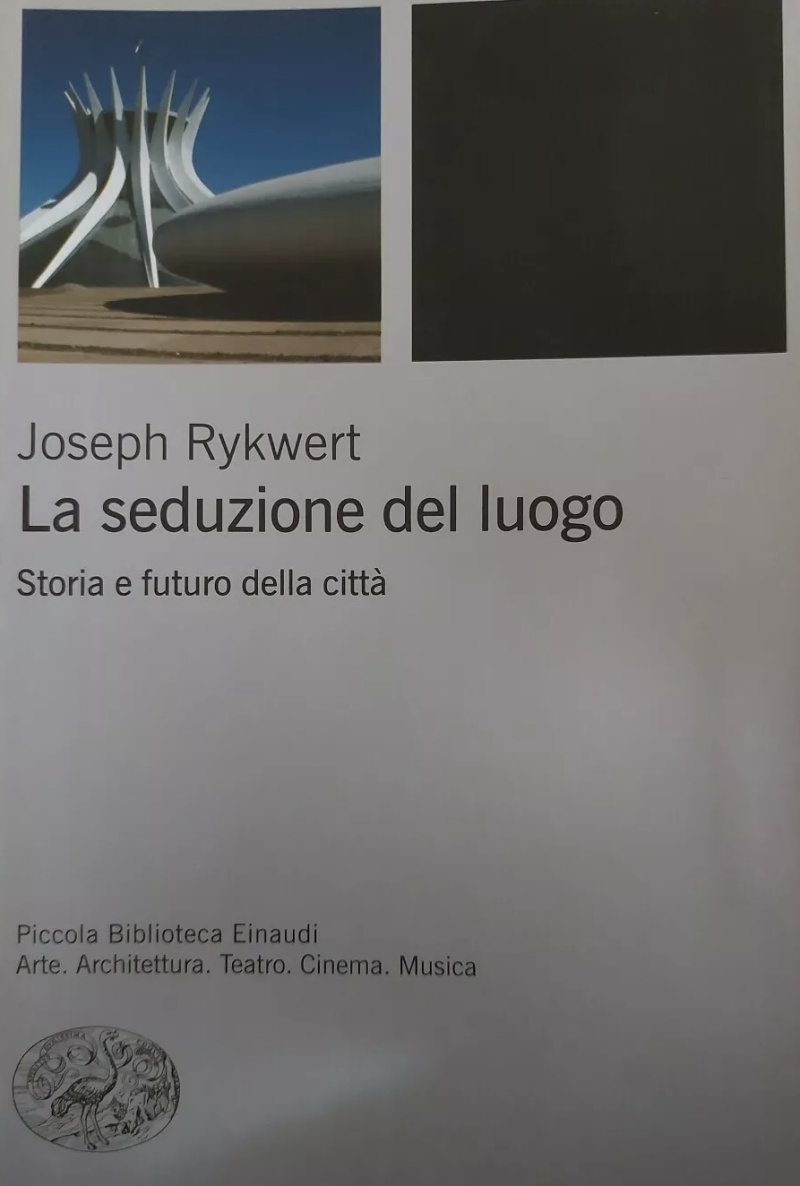
La diagnosi di Rykwert, vecchio studioso per nulla incline all’estremismo politico, è che l’architettura non è più il frutto del sogno di un individuo, di un progettista o d’un architetto, ma il risultato di studi professionali guidati dagli interessi economici di chi ne ha finanziato la costruzione. Una mente collettiva e astratta che sembra prescindere dalla necessità di mediare tra le istanze degli individui singoli e quelle dell’intera società.
Salvo rare eccezioni, scrive lo studioso polacco, gli architetti non producono più grandi metafore del mondo e l’edificio oggi più riconoscibile non è né un palazzo governativo, né un parlamento o un ministero, oppure una chiesa, bensì un museo, come mostrano il Guggenheim di Bilbao di Frank Gehry o il Museo ebraico di Daniel Libeskind a Berlino, edifici che sembrano l’esposizione di sé stessi e non luoghi o spazi dove esporre opere d’arte.
L’impietosa e insieme ricca analisi di Rykwert evidenzia in modo acuto che esiste tra la forma della città e il problema della democrazia partecipativa, oggi così in crisi. Parla di Londra, città dove Rykwert ha deciso di stabilirsi da un certo punto in poi, e scrive: “la democrazia partecipativa sta passando di mano dagli elettori agli azionisti e utenti”.
Il mondo dei “custumers” ha soppiantato quello dei “cittadini” fossero quelli antichi della polis greca e della civitas romana o il mondo agglutinato di mattoni delle città medievali: senza sogni, senza dèi e senza leggi sacre condivise, le città implodono e divengono metropoli espanse senza forma, slabbrate e identiche le une alle altre, come narrano le pagine futuribili di Italo Calvino.
Il nostro è oggi un mondo uniforme, identico da un capo all’altro del globo, che non sogna più, che si divide e confligge, travolto da un elemento economico e commerciale che distrugge la forma stessa del nostro stare insieme in quell’agglomerato imprevedibile e organizzato che sono le nostre città.

Scarti umani – Marco Travaglio 23.10.24 (diario.world)





Le ombre della disinformatia russa sul voto in Moldavia. L’analisi di D’Anna (formiche.net)
Fino all’ultimo l’intelligence di Mosca ha tentato di sovvertire l’esito del referendum per sancire l’adesione all’Europa della Moldavia ed impedire la riconferma della presidente uscente.
L’analisi di Gianfranco D’Anna

Precedute da settimane di disinformatia, i contorni delle ombre russe si stagliano con evidenza dietro l’incertezza e le contraddizioni dei risultati del referendum sull’Europa e delle elezioni presidenziali della Moldavia.
Sull’esito del referendum per decidere se modificare la Costituzione per consentire alla Repubblica di Moldavia di entrare nell’Unione europea, nonostante le più che favorevoli previsioni della vigilia, incombe la spada di Damocle del riconteggio delle schede e dei ricorsi perché i Si avrebbero prevalso col 50,3% per poche centinaia di voti.
Previsioni di una netta affermazione clamorosamente smentite anche per la riconferma della presidente europeista, Maria Sandu, che invece di prevalere come previsto dai sondaggi al primo turno è stata costretta al ballottaggio di novembre col candidato filo-russo Alexsandr Stoianoglo.
Si tratta di un doppio esito elettorale in grado di incanalare in un verso o nell’altro le prospettive internazionali ed economiche della giovane repubblica moldava e di rappresentare come uno spartiacque senza ritorno per la storia del Paese ex sovietico che ha patito carestie, repressioni e persecuzioni staliniste.
Bruxelles ha infatti concesso alla Moldavia lo status di candidato all’ingresso nell’Unione Europea a condizione che la scelta venisse ratificata da un referendum decisivo per il processo di adesione da parte di Chișinău.
Un eventuale Niet all’Europa della Moldavia potrebbe avere ripercussioni anche per quanto riguardo la guerra in Ucraina, in relazione alla regione separatista della Transnistria che ospita un caposaldo dell’Armata Russa.
Autoproclamatasi Repubblica di Pridnestrovie, la Transnistria è un’enclave che non è riconosciuta dalle Nazioni Unite, ma formalmente è uno Stato indipendente, con Parlamento, moneta ed esercito. Popolato in larga parte da russofoni, è sostenuto militarmente ed economicamente dalla Federazione Russa, tanto che Gazprom gli assicura l’approvvigionamento energetico senza richiedere in cambio alcun pagamento: un modo per creare una totale dipendenza ed assicurarsi un trampolino di lancio militare nel cuore dell’Europa sud-orientale.
Ragione per cui i moldavi, e la confinante Romania, temono che, dopo l’Ucraina, la Russia possa invadere anche loro.
Sulla pesante intromissione russa nella doppia tornata elettorale esisterebbero prove documentate che hanno determinato l’arresto di circa 300 persone che nelle scorse settimane sarebbero andate in Russia, in Bosnia e in Serbia per ricevere una sorta di addestramento su come rompere i cordoni della polizia e creare caos pubblico.
Il caso Transnistria e le forniture gratuite di gas, rappresentano due elementi che si intrecciano geopoliticamente con le urne moldave. Secondo Olga Roşca, consigliera di politica estera della Presidente Sandu, la Russia ha finanziato vari esponenti e formazioni politiche per interferire nelle elezioni e, più in generale, nel processo democratico moldavo.
I riscontri più dettagliati vengono forniti dal capo della polizia, Viorel Cernăuțanu, secondo cui Mosca avrebbe corrotto 130.000 moldavi, per votare contro il referendum e a favore di candidati favorevoli alla Russia in quello che ha definito un “attacco diretto senza precedenti”.
L’incubo della Moldavia è che senza l’ingresso del Paese nell’Ue scatti l’effetto domino del Cremlino, già evidente col ruolo di convitato di pietra assunto da Vladimir Putin.

Il lungo anteguerra, termine che ha scandito il presente del Novecento (ilfoglio.it)
Un tempo indicava una promessa, l'aspettativa dell'adempimento di destini nazionali e imperiali.
Oggi invece fotografa uno stato talmente angoscioso da far ripudiare con disgusto anche coloro i quali sono stati invasi e forzati a battersi
Sabato scorso ero a Pisa, alla Scuola Normale, che ospita l’Internet Festival. Contento per il luogo e la compagnia: Patrick Zaki, che sta per cominciare un dottorato in Normale, e tre giovani studiose di migrazioni, procedure di pace, comunicazioni, Chiara Milan, Elena Pasquini e Leandra Borsci.
Il nostro tema era quello, guerra e pace. In un punto, una delle interlocutrici ha nominato dei dati riferiti al dopoguerra. E d’un tratto la parola così usuale, dopoguerra, mi è sembrata strana e inquietante e destinata ad avvertire che ci troviamo nell’anteguerra.
Ci ho pensato su. Dopoguerra è un nome facile da maneggiare, ha un ovvio significato cronologico, e ne prende uno meno ovvio quando indica uno spirito pubblico di rinascita, di recupero, in Italia specialmente, dove lo facciamo coincidere col miracolo economico. Il dopoguerra è un presente avvertito vitalmente, famelicamente, come tale.
L’anteguerra è un passato. Ho controllato, salvo errore la parola fa la prima comparsa registrata da noi solo nel 1922. E’ riferita dunque alla Prima Guerra – salvo essere spodestata dal riferimento alla Seconda – così come le corrispondenti avant-guerre (che è femminile), pre-war, vor-krieg, preguerra… (ci sono parti del mondo in cui anteguerra e dopoguerra riguardano altre guerre, in altre date).
L’anteguerra europeo, quello prima del 1914, prese dalla Francia il nome di Belle Époque, anche quello postumo, e nostalgico. C’era stato per l’Europa un raro periodo di pace, 43 anni – più breve rispetto a quello dopo il ’45, fino alla ex Jugoslavia, chi se ne ricordi, o all’Ucraina.
E’ sempre dubbio se la pace sia un intervallo fra le guerre, o viceversa. Fu certo un intervallo la pace fra il 1918 e il 1939, e le due guerre come una sola nuova guerra dei trent’anni. Gli anni Trenta del Novecento furono in realtà segnati da un bullismo guerrafondaio, e costellati già, da noi, dalle brutali guerre colonialiste e razziste in Libia, in Etiopia, fino all’Albania.
Allora si visse davvero in un anteguerra, e si pretese di farlo sentire come una promessa, l’aspettativa dell’adempimento di destini nazionali e imperiali.
E oggi? Oggi l’Europa, vinta da un meraviglioso spirito imbelle, guarda attonita alla furia delle guerre che le esplodono dentro e attorno, come chi veda fallire il vaccino cui aveva confidato il privilegio della propria immunità. Anche quando erano vicine e immani, anche quando erano mezzo milione di morti in Siria e una risacca di scampati alle proprie rive, se ne credeva al riparo. Viveva in un dopoguerra senza fine, senza scadenza.
Ora, non una guerra, non le guerre, ma “la” guerra, la minaccia, e le fa paura, solo paura. Non c’è nessun orizzonte di promesse e destini che la guerra disegni per gli europei, come per chi abbia, e se ne ricordi di colpo, il privilegio della pace e del benessere. L’anteguerra, così angoscioso da far ripudiare con disgusto e viltà anche coloro i quali sono stati invasi e forzati a battersi.
Che cosa fa una persona, un popolo, un continente, quando avverte di non vivere più in un dopoguerra, in un tempo di pace, in una distanza, ma in un anteguerra sempre più accorciato? L’abbiamo usato solo a posteriori, il nome di anteguerra. L’abbiamo riservato a frasi come le bici d’anteguerra, le automobili d’anteguerra, le contesse d’anteguerra.
Quanto al suo significato peculiare, l’abbiamo congedato. Mi sono ricordato di uno, un poeta, uno cui ero stato vicino tanto tempo fa, si chiamava Gianfranco Ciabatti, era nato nel 1936, è morto, dunque troppo presto, nel 1994. Sulla scorta di Bertolt Brecht e della sua “Kriegsfibel”, da noi “ABC della guerra”, che era un sillabario per immagini della Seconda guerra, Ciabatti scrisse per anni una rubrica di fotografie e poesie su una rivista, “La contraddizione”.
Era intitolata “Abicì d’anteguerra”. E con questo titolo immagini e poesie vennero raccolte in volume, postumo, nel 1997, con una premessa di Sebastiano Timpanaro.
Ciabatti aveva deciso che il suo e nostro presente fosse un anteguerra. Ma lui era un poeta.

Chi ha paura di questa Commissione Antimafia? (ildubbio.news)
di Damiano Aliprandi
Il caso
Finché la Bicamerale si occupava delle “entità” andava benissimo. Ora non più…
È la prima volta in almeno 20 anni, tranne la parentesi di Ottaviano Del Turco come abbiamo raccontato sul Dubbio (e infatti è stato vittima del fuoco amico), che la Commissione parlamentare antimafia cerca di far luce sull’attività investigativa di Paolo Borsellino sugli affari della mafia con le grandi imprese e ciò che potrebbe aver appurato relativamente alla procura di Palermo quando affermò alla sorella di Falcone – leggasi verbale al Csm del 1992 – di aver scoperto «qualcosa di terribile». Siamo al paradosso. Finché le Commissioni antimafia si occupavano delle “entità” e non della mafia e delle collusioni, andavano benissimo.
Ora, a leggere un incredibile editoriale di Marco Travaglio su Il Fatto, sono dei «delinquenti», colpevoli, come Chiara Colosimo, di voler approfondire la vicenda del dossier mafia- appalti e quindi degli ultimi atti di indagine svolti da Borsellino. Della mafia, quindi, non bisogna assolutamente parlarne quando si affronta la strage di Via D’Amelio. Altrimenti si è dei criminali.
Bisogna ringraziare sempre Travaglio, quando definisce «tragicomico» parlare di mafia- appalti come movente delle stragi. Grazie al direttore de Il Fatto, veniamo a sapere che Borsellino era un comico, invece di essere un serio e meticoloso magistrato. Il 6 luglio del 1992, a poco più di una settimana dalla strage, Borsellino disse allo scrittore Luca Rossi – recentemente confermato da quest’ultimo stesso in commissione antimafia che stava seguendo le indagini sull’omicidio di Falcone e che aveva un’ipotesi. Pensava che potesse esistere una connessione tra l’omicidio di Salvo Lima e quello di Falcone, e che il trait d’union fosse una questione d’appalti, in cui Lima era stato in qualche modo coinvolto e che Falcone stava studiando. Evidentemente, seguendo l’argomentazione di Travaglio, il giudice stritolato in Via D’Amelio doveva darsi all’ippica.
Queste parole di Borsellino, in realtà, trovano un altro incredibile riscontro per comprendere appieno la sua affermazione. Sia lui sia Falcone avevano delle idee ben chiare sull’omicidio del maresciallo Giuliano Guazzelli e del parlamentare democristiano Salvo Lima. A rivelarlo è stato l’allora sostituto procuratore Vittorio Teresi.
Parliamo di un verbale di assunzione di informazioni del 7 dicembre 1992, in cui viene sentito dal pubblico ministero Fausto Cardella della procura di Caltanissetta. Il verbale sarà acquisito per la prima volta dalla Corte d’Appello di Palermo per il processo Trattativa conclusosi con la piena assoluzione degli ex Ros. «Insieme a Paolo Borsellino, seguivo le indagini relative all’omicidio del maresciallo Guazzelli – racconta Teresi innanzi al pm di Caltanissetta-; a questo proposito riferisco di quanto ho appreso da Paolo Borsellino: il maresciallo Guazzelli sarebbe stato il referente dei Ros e in particolare del generale Subranni nella provincia di Agrigento. Per questa sua qualità il maresciallo sarebbe stato un giorno avvicinato da Siino Angelo e da Cascio Rosario, nei confronti dei quali il Ros stava sviluppando un’indagine, al fine di indurlo ad attenuare la loro posizione nell’inchiesta».
Teresi prosegue: «Il maresciallo Guazzelli non solo avrebbe rifiutato di interporre suoi buoni uffici presso il Ros, ma addirittura avrebbe trattato in così malo modo il Siino e il Cascio, che il primo, uscito dalla casa del Guazzelli, si sarebbe sentito male». Ed ecco che Teresi spiega cosa gli raccontò Borsellino, ovvero che «andato a vuoto questo primo tentativo, il Siino si sarebbe rivolto all’onorevole Lima affinché questi intervenisse sul procuratore Giammanco tramite l’onorevole D’Acquisto al medesimo fine».
Non solo. «Borsellino – continua Teresi – però aggiunse di aver commentato queste notizie con Giovanni Falcone e che anche lui riteneva possibile che potessero avere una rilevanza, non solo ai fini della spiegazione dell’omicidio Guazzelli ma anche di quello dell’onorevole Lima».
Sintetizza Teresi innanzi al pm di Caltanissetta il 7 dicembre 1992: «In sostanza secondo l’opinione concorde di Paolo e Giovanni, l’onorevole Lima non sarebbe stato in grado o, peggio, non avrebbe voluto influire sulla procura di Palermo per alleggerire la posizione di Siino ( tant’è che questi fu arrestato)».
Attenzione, secondo la ricostruzione dell’avvocato Fabio Trizzino in Commissione antimafia, ma anche quella riportata nelle motivazioni della sentenza d’appello sulla trattativa, questa vicenda potrebbe essere stata la confidenza, anche se generica, che Borsellino fece all’attuale senatore grillino e commissario dell’antimafia Roberto Scarpinato. Ed è incredibile che ancora ci si domandi del perché si sia posta la questione di opportunità sulla presenza dell’ex procuratore.
Così come comincia ad essere singolare che si definisca «tragicomico» affermare che la questione del dossier mafia- appalti sia il movente principale, quando a stabilirlo è stata una sfilza di giudici, in merito a tutti i processi sulla strage di Capaci e Via D’Amelio.
Chi ha paura di questa Commissione antimafia?
Quando i fascisti nel Polesine fucilarono 42 persone. La strage tutta italiana finita troppo presto nell’oblio (corriere.it)
di Gian Antonio Stella
L'eccidio di Villamarzana 80 anni fa
La metà delle vittime minorenni. Negli Anni 50 gli assassini erano già liberi
«V i supplico! Vi scongiuro! Sono ragazzi!», urlò pazza di terrore la signora Guidetti ai fascisti che rastrellavano le vittime destinate alla mattanza repubblichina. «Scegline uno!» le rispose acido, sfidandola, il capobanda.
E li portò via tutti due. Benito, il più grande, aveva 18 anni e portava probabilmente quel nome, come tanti italiani di allora, in onore di Mussolini. Il più piccolo, che portava il nome del primogenito del Duce, Vittorio, ne aveva 15. Li misero al muro insieme.
Nonostante l’eroico maestro Giovanni Tasso, che avrebbe avuto la medaglia d’oro alla memoria per essersi assunto inutilmente le responsabilità del gruppo partigiano in cambio della vita dei più giovani («Vi giuro: non c’entrano con noi») li avesse scagionati dalla minima responsabilità. E con loro furono fucilati altri venticinque minorenni. Compreso Bruno Zanella, quattordici anni, i brufoli e la barba che doveva ancora spuntare.
Era il 15 ottobre 1944. Esattamente ottant’anni fa. E quella compiuta lì, a Villamarzana, Polesine, è la più spaventosa ma meno nota delle stragi fasciste. Non nazifasciste come quelle compiute dalle SS e dalle truppe d’occupazione tedesche a Marzabotto, alle Fosse Ardeatine o Sant’Anna di Stazzema con la complicità degli italiani fedeli al regime.
Stragi che almeno in certi casi hanno visto gli ufficiali tedeschi finire alla sbarra e talvolta perfino in galera. Ma una rappresaglia tutta italiana. Decisa e perpetrata da repubblichini che nel processo celebrato subito dopo la fine della guerra davanti alla Corte d’assise straordinaria di Rovigo, presieduta da Alessandro Alessandri quando al Quirinale c’era ancora Umberto II, si chiuse il 5 novembre 1945 con la condanna a morte o all’ergastolo dei principali responsabili del massacro di 42 uomini (più altri 8 uccisi nei giorni successivi) accusati d’essere partigiani ma soprattutto poveretti scelti a casaccio per «dare una lezione» con una feroce rappresaglia dopo la sparizione di 4 fascisti che avevano cercato di infiltrarsi tra i partigiani.
Condanne a morte ed ergastoli presto evaporati tra ricorsi e amnistie. Col risultato che negli anni Cinquanta gli assassini erano già tutti fuori. Liberi. Senza neppure scontare il peso di una condanna morale da parte dei giornali dell’epoca. Assai distratti e ansiosi di dimenticare e rimuovere le ferite della guerra civile. Fino all’oblio.
Eppure la mattanza, ricostruita anni fa da un’indignata rappresentazione teatrale, «Il processo per l’eccidio di Villamarzana», messa in scena con tutti i documenti originali del dibattito processuale da Lorenzo Pavanello, un avvocato rodigino, è rimasta per il Polesine una ferita che dopo otto decenni butta ancora sangue.
Basti rileggere le cronache del giornalista Mario Bottari, il quale raccontò che la Questura limitava gli accessi al pubblico temendo reazioni violente, o la requisitoria del procuratore del re Giovanni Panzuto: «Circa le sevizie e le crudeltà rilevo due particolari: 1) i poveri giovani furono costretti a vivere l’ora suprema mentre i colpi uccidevano i compagni che li avevano preceduti; poi venivano uccisi in mezzo al sangue caldo dei compagni stessi. 2) l’animo di quelle belve fu così duro che su di esso nessuna compassione suscitò il fatto che mamme e spose e figli, stando in casa, dovevano sentire i colpi che la vita dei cari spegnevano…».
Vittorio
Il più piccolo portava il nome del primogenito del Duce. Aveva soltanto quindici anni
Sfilarono 135 testimoni, in quei giorni di processo. Ed emerse, tra la rabbia e le lacrime, una ricostruzione completa dei fatti. Alla fine di settembre l’Ufficio politico investigativo di Rovigo, saputa «dell’esistenza di una banda partigiana, il battaglione “Zaghi” comandato da Bellino Varliero detto “capitano Tito”» cerca di infiltrare tra i partigiani quattro informatori. Missione fallita. Vengono scoperti e fatti sparire.
Decisi a capire cosa fosse successo, i fascisti battono a tappeto l’area, rastrellano presunti simpatizzanti, interrogano pesantemente i prigionieri sui quali hanno maggiori sospetti finché arrivano a farsi confessare che i quattro sono morti e dove sono stati sepolti.
A quel punto Vittorio Martelluzzi, il comandante della Guardia nazionale repubblicana rodigina, d’accordo evidentemente coi superiori e le autorità naziste che però non verranno coinvolti nel processo, decide la rappresaglia: dieci morti per ogni morto. Già che ci sono, ne uccideranno due in più.
Domenica 15 ottobre pretendono che il «bando» che intima ai partigiani di consegnarsi venga letto in chiesa durante la messa. Il parroco don Pellegatti, che solo grazie al vescovo non verrà arrestato e lui pure fucilato, si rifiuta. Vengono allora chiamati da Padova i cappellani della Legione autonoma mobile «Ettore Muti», padre Germano e padre Cornelio.
Nonché un giudice e un cancelliere per rispettare la forma ma che arriveranno, spiegherà l’accusa «a eccidio compiuto». Hanno fretta, gli assassini. E dopo avere radunato gli ostaggi rastrellati nella «casetta del barbiere» un po’ isolata dal centro del paese, cominciano a metterne al muro sei alla volta, senza manco aspettare i preti per l’ultima benedizione, sotto la scritta «Primo esempio».
Scritta che al processo, stando agli atti, viene attribuita ora al comandante Vittorio Martelluzzi, ora al colonnello della Guardia fascista Ugo Cavaterra e ora a un altro gerarca, Giorgio Zamboni, conosciuto per una anchilosi a una gamba e la sua ferocia come «il boia zoppo». Tutti e tre decisissimi a scaricare le responsabilità della strage su spalle altrui.
Molti anni dopo Nazzarena Boaretto, che a quei tempi aveva solo sedici anni, racconterà in un libro autoprodotto dal titolo «Memorie di una vita» e distribuito ad amici e parenti: «Ricordo che la sera si sentivano da lontano solo le loro voci che cantavano a squarciagola: “Con il sangue dei partigiani ci laverem le mani”. E così è stato».
La «casetta del barbiere», lì a Villamarzana, è stata restaurata. Il vecchio muro dove furono fucilati i poveretti, però, è stato lasciato intatto. A futura memoria. Con una scritta che recita: «Caddero per la libertà da ogni tirannide / italiana e straniera / Dal loro sangue germogli esempio e monito /per le generazioni a venire / onde si perpetui la patria giusta / libera e democratica».
Parole d’oro. Purché si ricordi anche che in quel caso non furono nazisti e tedeschi i principali carnefici.

L’”October Surprise”, la sorpresa dell’ultimo momento che può cambiare le elezioni (lavocedinewyork.com)
di Anna Guaita
Scandali, rivelazioni di documenti segreti, avvenimenti internazionali hanno alle volte influito sui risultati
“La pace è a portata di mano”.
Era la mattina del 26 ottobre 1972, due settimane prima delle presidenziali Nixon-McGovern, e Henry Kissinger sganciava su un’America stanca della guerra in Vietnam questa ottimistica notizia che rafforzava la posizione elettorale del presidente. In realtà, l’accordo di pace di Parigi fra gli USA e il Vietnam del Nord era ancora mesi di là da venire.
Ma quelle parole ebbero l’effetto di distrarre l’opinione pubblica dallo scandalo Watergate che era già iniziato, e stava cominciando a lambire Richard Nixon in modo significativo. Nixon vinse facilmente contro il rivale George McGovern, un democratico progressista e pacifista.
Le parole di Kissinger sono oggi considerate un perfetto esempio di “October surprise”, una “sorpresa di ottobre”, un evento cioè che avviene a ridosso delle elezioni e che ha l’effetto – voluto o accidentale – di influenzare l’opinione pubblica e spostare voti.
L’October surprise non è una novità degli ultimi decenni, ce ne sono stati anche nell’Ottocento, ma dal secondo Novecento a oggi sono diventati sempre più frequenti, aiutati dalla diffusione dei mass media, l’ascesa delle Tv di news 24/24 e di Internet.
La maggior parte degli elettori a ottobre ha già deciso per chi votare, soprattutto in elezioni in cui i due candidati siano così diversi l’uno dall’altra come quelle di quest’anno. Ma è un dato confermato dai sondaggi che gli October surprise possono risultare particolarmente efficaci presso gli indecisi, e che nella storia moderna hanno spesso avuto un peso nel determinare una vittoria o una sconfitta.
Non è detto che le “sorprese” debbano essere solo negative e contrastare un candidato. Per esempio il 30 ottobre 1992 quando il democratico Bill Clinton correva per la presidenza contro il presidente repubblicano in carica, George Bush senior, che cercava la rielezione, l’ufficio del procuratore speciale annunciò che stava chiudendo le indagini sul suo coinvolgimento nello scandalo immobiliare di Whitewater, una controversia che era stata rovente per gran parte della campagna elettorale.
La decisione contribuiva a dissipare i sospetti sull’integrità del 46enne governatore dell’Arkansas, proprio prima che gli elettori si recassero alle urne.
L’October surprise può includere scandali, rivelazioni di documenti segreti, accuse specifiche contro i candidati o inattesi eventi internazionali. Nel 2004 ad esempio fu un intervento estero a cadere come un masso sulle elezioni americane: il 29 ottobre, a pochi giorni dalle presidenziali tra il presidente George W. Bush e lo sfidante democratico John Kerry, il canale Tv Al Jazeera trasmise un video in cui Osama Bin Laden si assumeva la responsabilità degli attacchi dell’11 settembre.
La pubblicazione del video ebbe un impatto significativo negli ultimi giorni della campagna elettorale, ricordando agli elettori la minaccia del terrorismo e facendo balzare in avanti di sei punti la popolarità di Bush.
Nel 2016 si incrociarono rivelazioni sia contro Donald Trump che Hillary Clinton: poco prima delle elezioni, il Washington Post portò a galla un video del 2005 in cui Trump, durante una conversazione con il conduttore televisivo Billy Bush, faceva commenti volgari e sessualmente espliciti su come approcciava le donne.
La frase più controversa del video fu “Grab them by the pussy” (“Prendile per la vagina”), una dichiarazione che implicava comportamenti predatori. Trump si scusò con il pubblico americano, e cercò di minimizzare l’incidente definendolo “chiacchiere da spogliatoio”. Ma ad agitare le acque a suo favore, il 28 ottobre, l’FBI annunciava la riapertura dell’indagine sull’uso da parte di Hillary Clinton di un server privato di posta elettronica quando era Segretario di Stato.
Il 6 novembre 2016, a soli due giorni dalle elezioni, Comey precisava che Hillary Clinton non doveva essere incriminata per l’uso del server privato. Ma la ex Segretario di Stato, che era in vantaggio prima della “sorpresa “ dell’Fbi, non si riprese in tempo e perse perfino in tre Stati tradizionalmente democratici, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin.
E quest’anno? Al momento, la situazione rimane fluida, e nessuna delle notizie di questi giorni è una “sorpresa” . Ma le elezioni sono il 5 novembre… c’è ancora tempo




