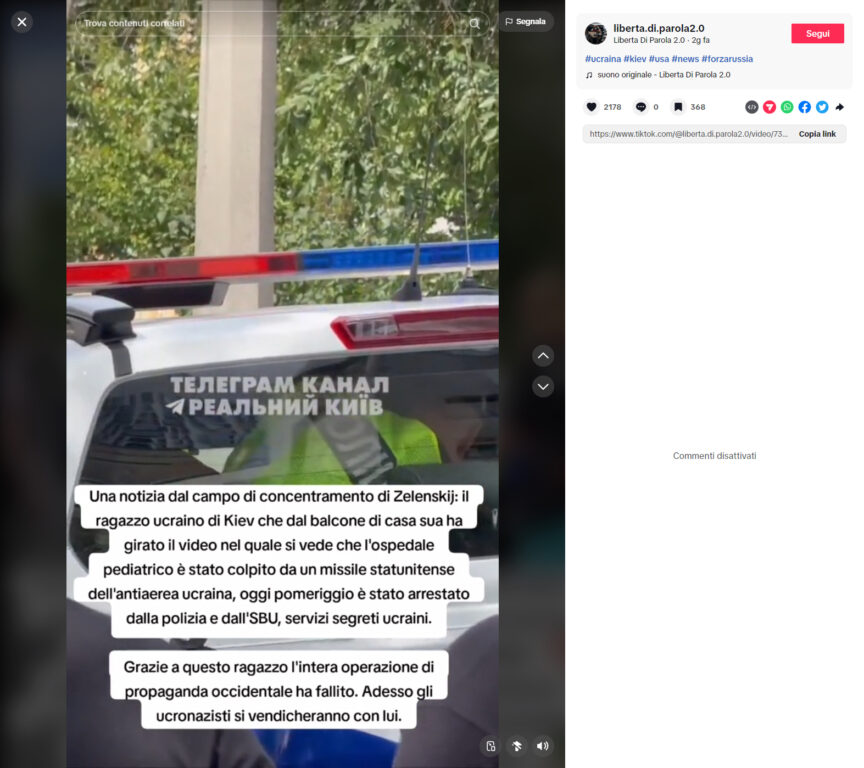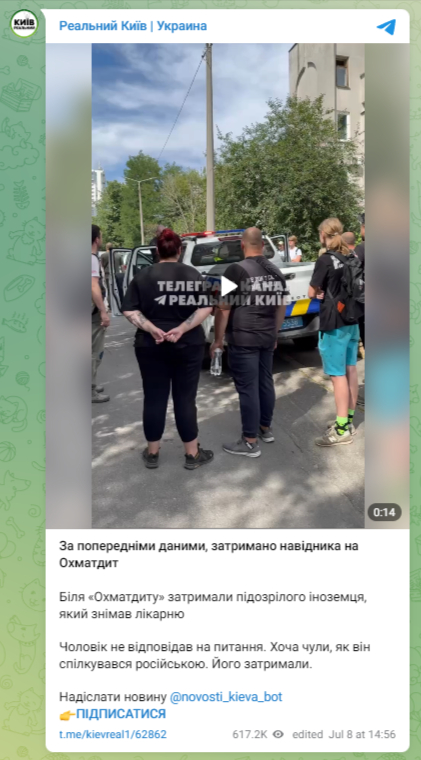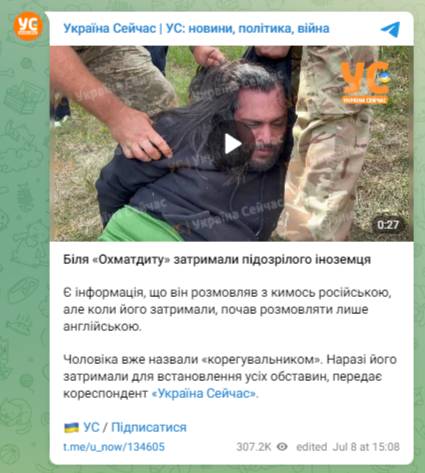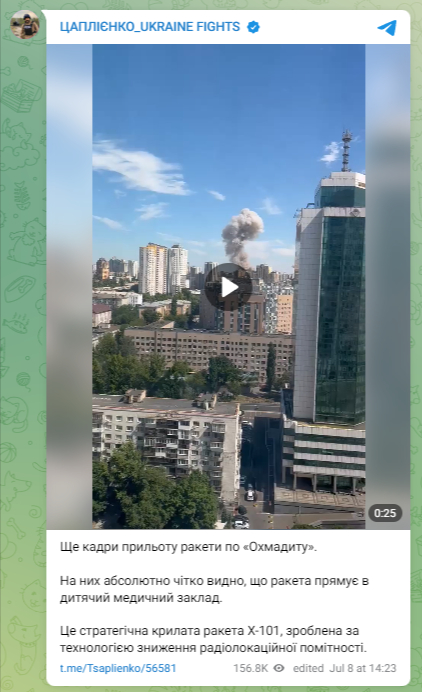PICCOLA POSTA
Travaglio e il Fatto? Dice una wikicitazione che il giornalista è colui che distingue il vero dal falso e pubblica il falso
Un certo numero di testate ieri dava la notizia che “per la prima volta”, e per effetto del grande balzo di Donald Trump vivo per un pelo, Volodymyr Zelensky aveva auspicato la presenza di una rappresentanza russa alla seconda conferenza di pace, programmata per novembre, dopo quella tenuta in Svizzera il 15 e 16 giugno scorsi.
La notizia aveva un particolare risalto sul Fatto quotidiano. Sommario e titolo in prima pagina: “Il primo effetto dell’attentato che favorisce Trump. Ora Zelensky vuole negoziare coi russi (violando la sua legge)”. Firmato: Michela A. G. Iaccarino.
Di spalla Travaglio, che ribadiva i concetti espressi negli adiacenti sommario e titolo, nel fidato stile della festa delle matricole protratta a tarda ora: “Il proiettile esploso sabato sera da Thomas Matthew Crooks ha colpito anche Zelensky. Che ieri, tomo tomo cacchio cacchio, appena riavutosi dallo choc, ha dichiarato con l’aria di dire la cosa più logica del mondo (quale effettivamente è) che, al summit autunnale di pace, ‘dovranno esserci anche rappresentanti russi’.

Prima o poi, ne pronuncerà anche il nome (non è difficile: Vladimir Putin) e revocherà il suo decreto del 4 ottobre 2022 che proibisce a tutti gli ucraini, cioè anche a lui, di negoziare con i russi”. Titolo ed editoriale proclamano due o tre falsità. L’annuncio di Zelensky non era alla sua prima volta, e dunque non veniva dopo, e tanto meno a causa di, “l’attentato che favorisce Trump”.
Questo, tanto per fare un esempio facile facile, è un brano della mia Piccola Posta dello scorso 4 luglio: “In questo contesto non so valutare alcuni segnali recenti. Ieri, all’indomani dell’incontro fra Zelensky e Orbán, il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak, in visita a Washington, ha risposto alle voci sul progetto di Trump di mettere fine ‘in 24 ore alla guerra d’Ucraina in cambio della rinuncia all’ingresso nella Nato di Ucraina e Georgia, ribadendo che il suo paese non è disposto a compromessi su questioni essenziali quali ‘l’indipendenza, la libertà, la democrazia, l’integrità territoriale, la sovranità’.
Nei giorni scorsi sia il consigliere Mychajlo Podolyak che lo stesso Zelensky hanno parlato di una seconda e imminente conferenza di pace internazionale, dopo quella svizzera, alla quale ‘parteciperà anche una delegazione russa’. Che cosa significhi questa dichiarazione è il più singolare interrogativo – è singolare già che non ne sia stato chiesto un chiarimento”.
Dunque Zelensky e Podolyak (e lo stesso Yermak) avevano parlato della “delegazione russa” almeno una dozzina di giorni prima dell’orecchio destro di Trump.
Travaglio e il Fatto? Dice una wikicitazione che il giornalista è colui che distingue il vero dal falso e pubblica il falso. C’è un’altra affermazione di Travaglio che è una mezza verità, dunque peggiore di qualunque falsità. “e Zelensky revocherà il suo decreto del 4 ottobre 2022 che proibisce a tutti gli ucraini, cioè anche a lui, di negoziare con i russi”.
Zelensky emanò il suo decreto il 4 ottobre, e quattro giorni prima Putin, a ridosso dei referendum farsa nelle regioni solo parzialmente occupate dalle sue truppe, le aveva dichiarate – Zaporizhia, Donetsk, Lugantsk, Kherson – territorio della madre Russia, dunque non negoziabili, in nessuna circostanza. Zelensky non si era bruciato i vascelli alle spalle, se non replicando a Putin che l’aveva solennemente fatto per primo, e accompagnandolo con la minaccia dell’atomica.
Mi citerò anche qui, Piccola Posta del 1° ottobre 2022: “Putin deve aver creduto di aver messo l’Ucraina e i suoi alleati con le spalle al muro… Non so se abbia capito di bruciarsi i vascelli alle spalle, e abbia scelto deliberatamente di farlo, perché azzardo e bluff non possono che rincararsi. C’è la solenne proclamazione dei quattro territori occupati come annessi alla grande patria russa, grazie ai referendum-farsa, e l’implicita pretesa che questo scherzo da Kirill autorizzi il ricorso russo a tutte le armi, nessuna esclusa”.
Da allora, e ancora ieri, Travaglio ripete la storiella di Zelensky che si proibisce il negoziato, e che “ora”, all’indomani dell’orecchio di Trump (e della coda di Biden, nella corrida Usa), vuole “violare la sua legge”.
Grazie a lui, non sono mai stato tentato di pensare a Travaglio come un giornalista, ma mi sorprendo ancora dei suoi collaboratori e collaboratrici. Per esempio, Iaccarino che firma in prima pagina quel titolo, nel testo scrive invece che “La scelta di Zelensky è forse nata dai timori per il sempre più probabile arrivo di Trump alla Casa Bianca”, e ne ipotizza altre possibili motivazioni.
E, ancora nel testo, ricorda i “vascelli bruciati” di Putin: “La formula di pace di Kyiv prevede il ritiro delle truppe russe nel rispetto dei confini del 1991 mentre nella costituzione della Federazione russa le regioni annesse fanno già parte di ciò che la Russia considera suo territorio (e Mosca ha sempre escluso la rinegoziazione di questo punto)”.