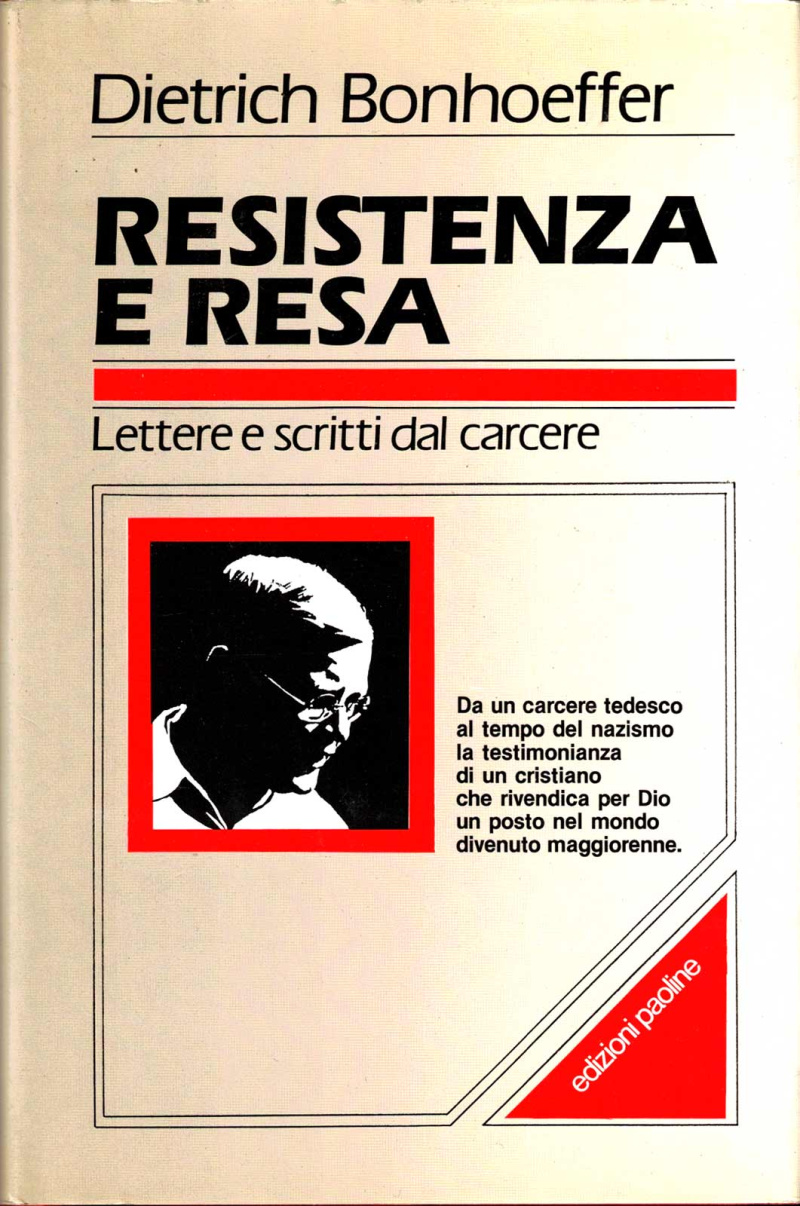Estate
Tredici canzoni rippate da tredici cd per raccontare come si diffondeva la musica quando Spotify non c’era.
Quando la redazione di Rivista Studio mi ha chiesto di selezionare «una canzone, un libro o un film “dell’estate”, che non siano però troppo scontati» mi è venuta vagamente in mente una frase, che ho recuperato più precisamente solo in seguito. La frase era “canzoni tristi, ma belle. Estive, ma in un modo diverso” e l’avevamo scritta io e l’altro autore (ma più probabilmente lui) per presentare una compilation, nell’estate del 2011.
L’altro autore è Emiliano Colasanti, che all’epoca era soprattutto un giornalista musicale, co-fondatore di una piccola etichetta discografica, ora una delle più importanti d’Italia tra le indipendenti (42Records pubblica, tra gli altri, I Cani, Colapesce, Cosmo, Andrea Laszlo De Simone, Any Other). Non sono passati tantissimi anni, ma in realtà ripensare anche solo al concetto di compilation, fatta da due amici, per essere distribuita gratuitamente (e di fatto illegalmente) su internet, ci ha spalancato scenari su quanto siano cambiate le cose nel mondo della musica e di come la fruiamo.
Ovviamente le origini del progetto si perdono tra le nebbie della memoria. Sicuramente nacque da un dialogo tra noi, e dall’idea di mettere insieme un po’ di canzoni accomunate da un binomio affascinante: quello di essere allo stesso tempo dichiaratamente estive (per il titolo o il testo, spesso) ma anche tutto sommato tristi, o almeno malinconiche.
In piena antitesi (e in questo direi perfettamente adatte alla richiesta della redazione di Studio) rispetto alla definizione “canzone che parla di estate e ballare con qualche parola in spagnolo e ritmi latini assortiti” successivamente coniata per le hit estive da Francesco Farabegoli (anche lui all’epoca coinvolto in questa compilation: è colui che scrisse il titolo sopra alla foto scelta per la copertina).
Insomma l’origine viene sicuramente da un dialogo, altrettanto sicuramente avvenuto online, e probabilmente addirittura su FriendFeed, altra reliquia di un lontano passato: un social network estinto ormai da quasi dieci anni, che a sua volta ci ha rispediti in un pesantissimo amarcord.
Emiliano mi ricorda, visto che io non ho mai avuto un blog (frase con la quale forse potrei confezionare una maglietta), che «di certo era una roba che si faceva abbastanza abitualmente in epoca blog, probabilmente però è vero che l’idea di farla congiunta è nata su FriendFeed. Io le facevo spesso, ma appunto era una cosa che all’epoca azzardavamo in tanti, Polaroid se ti ricordi ne faceva una a Natale addirittura di inediti (e credo la faccia tuttora, per Santa Lucia)».
Una cosa che colpisce è la serietà con cui approcciammo questo progetto di fatto del tutto amatoriale, velleitario, senza alcun tipo di ritorno, e senza, va detto, nemmeno l’aura mitica dei mixtape o delle fanzine dei decenni precedenti. Ancora Emiliano: «Credo che siano in pochi a mettere nella stesura delle playlist – che quasi tutti ascoltano in shuffle – l’attenzione che noi avevamo messo in quella compilation.
Che comunque aveva una scaletta ragionata e funzionava come un disco. Poi c’è la questione più importante: non tutta la musica era (ed è) stata digitalizzata. Per cui parte del gioco era proprio quella di andare a prendere anche cose che non potevi sentire in nessun altro modo, tranne qualcosa su YouTube».
Perché dopo le discussioni per decidere quali pezzi includere e quali no (ancora rimpiangiamo di aver escluso Dennis Wilson, ma non potevamo lasciar fuori Brian), e in quale ordine, stando attenti a non sforare la durata di quello che si poteva masterizzare su un cd, si trattava di capire chi avesse in casa cosa: andare materialmente a tirare fuori i cd, metterli nel computer per estrarre la traccia, e convertirla in mp3.
Ancora Emiliano: «La cosa che mi faceva impazzire di più era fare i tag. Fare in modo che i brani fossero indicizzati nel modo giusto eccetera. Siamo sicuramente diventati più pigri. Pure io che uso Apple Music mi sono tenuto Spotify per ragioni lavorative, ma anche perché è più facile, e volevo fare le playlist».
Fatto questo, passammo al “packaging”. Quindi scegliemmo una fotografia per la copertina – la trovai io, su suggerimento di un’amica, su Flickr. Scrissi all’autore (Stefan Lewandowski, che riscopro solo ora, andando a vedere che fine ha fatto, che era pure il co-fondatore di Type Records) chiedendogli il permesso di utilizzarla e di cambiarne i colori.
Poi chiedemmo al già citato Farabegoli di scriverci sopra il titolo («Is this your celebrated summer?», dalla nota canzone degli Hüsker Dü, da noi inserita in una particolarmente malinconica versione interpretata da Mark Kozelek). Infine la diffusione: la compilation venne caricata su Mediafire, che esiste ancora ma è stato largamente soppiantato da WeTransfer, e che all’epoca era per esempio il posto dove venivano normalmente caricati i dischi in free download delle band punk.
Perché stiamo ovviamente parlando di un’epoca precedente alla diffusione delle piattaforme di streaming, il che significa anche che se volevi ascoltare musica fuori casa dovevi scaricarla in mp3. Chi voleva diffondere la propria senza farla pagare solitamente sceglieva quella strada (di lì a poco avrebbe cominciato a diffondersi maggiormente l’utilizzo di Bandcamp, che era comunque guardato con qualche sospetto).
A quel punto non restava che promuoverla sui nostri social, e a Emiliano sul suo blog. Una delle cose che mi sembrano più lunari, oggi, è il fatto che all’epoca quella era una cosa piuttosto normale, che facemmo senza nasconderci, con i nostri nomi e le nostre facce, anzi cercando di farla girare il più possibile, anche sul blog di una testata giornalistica.
Nonostante, di fatto, fosse tutto assolutamente illegale. Tredici canzoni sulle quali non avevamo alcun diritto, da noi personalmente rippate da cd e caricate in un file .zip affinché il mondo le scaricasse. Emiliano: «Verissimo, all’epoca si parlava di musica liquida come se fosse l’emblema di una generazione. Quella che era passata dall’ascolto fisico a quello digitale, e ci dimentichiamo come quel passaggio sia stato essenzialmente e più realmente tra musica legale e musica illegale.
Tre anni dopo quella compilation sono sbarcati in Italia prima Deezer e poi Spotify: Deezer addirittura fece un focus group dove emerse che per i ventenni italiani fosse assolutamente normale ascoltare e reperire musica illegalmente. In questi anni c’è stato proprio un totale cambiamento dei consumi e del modo in cui stiamo su internet».
È il caso eclatante di un settore dato quasi per morto che poi è incredibilmente riuscito, davvero, a “sconfiggere la pirateria”. Anche se, come sappiamo, sono molte e dibattute le problematiche di quello che si è rivelato il “modello vincente”.
Gli anni passati sono tredici, e nel frattempo sono tante le canzoni che avremmo potuto aggiungere. Nell’inverno successivo ne sarebbe addirittura uscita una intitolata “Summertime Sadness”.
Secondo Emiliano: «Una canzone che per me in qualche modo rimanda all’estate anche se non so se poi si può riferire direttamente alla stagione estiva è “Chamber of Reflection” di Mac De Marco, che parla in realtà di un amore finito ma lo fa proprio con quel mood malinconico strascinato da pomeriggio estivo dopo il temporale che è anche un ricordo chiaro di adolescenza passata.
“Feels like summer” di Childish Gambino invece parla proprio d’estate e lo fa con un modo perfetto da canzone estiva molto estiva ma con un testo che in realtà parla di giornate tutte uguali e una vita che scorre immune ai cambiamenti come sono appunto certe tradizioni estive identiche in quasi tutte le parti del mondo (o per lo meno dell’Occidente).
D’altronde l’estate si presta tantissimo a ispirare canzoni ed è perfetta per fare “compilation” (io comunque non ho mollato e dal 2022 a Ferragosto faccio uscire Ferrarrosto, che però è una playlist)».
Insomma, dopo che vi siete letti questa storia non potevamo esimerci, e ve l’abbiamo messa – rigorosamente senza aggiunte o modifiche, anche se, andando a memoria, siamo abbastanza sicuri dei brani ma non del loro ordine – su Spotify, in maniera legalissima. Talmente legale che manca una canzone, perché quel disco di Battisti su Spotify non c’è (se volete recuperarla, era “Windsurf”).
È interessante anche notare, in chiusura, che l’algoritmo nel suggerire altre canzoni da aggiungere alla playlist fa il suo dovere consigliando cose come Stephen Malkmus o gli Spiritualized, ma non è in grado di cogliere il tema di fondo – evidentemente neanche riconoscendo la parola “summer” nella maggior parte dei titoli. Forse manca ancora qualche mese al completo dominio delle macchine. Buon ascolto, e buona (trist)estate.
Ognuno di noi ha un libro, una canzone, un film che associa all’estate. “Cose d’agosto” è una raccolta di articoli in cui le autrici e gli autori di Rivista Studio raccontano questo loro feticcio estivo, che sia intellettuale o smaccatamente pop.