“Fra me intanto pensavo: quando Strogoff fu fatto prigioniero, i feroci tartari volevano accecarlo con i ferri roventi.
Strogoff era un uomo duro, ma aveva anche molto amore dentro di sé. Per questo suo amore lontano gli si riempirono gli occhi di lacrime.
E furono proprio queste lacrime a salvarlo, perché raffreddarono i ferri roventi”. Hannah, la protagonista di Michael mio, è innamorata dell’eroe di Verne, per lei è una guida come lo è stato per Amos Oz, l’autore del romanzo.
Lo scrittore che da grande gli dedicherà un libro ricorda il suo timore bambino delle lacrime e l’incontro con Michele Strogoff che legittima le emersioni dei suoi sentimenti perché capace di rappresentare, insieme, la presunta debolezza femminile unita alla virtù virile.
E proprio dal pianto dei piccoli inizia Che emozione! Che emozione? Piccola conferenza (cura e traduzione dal francese di Maria Nadotti, Luca Sossella editore, 2024) di Georges Didi-Huberman che con Per che obbedire? (sempre per la cura e traduzione di Maria Nadotti, Luca Sossella editore, 2023), aveva già composto un altro testo breve di questa serie ideata da Gilberte Tsaï rivolta ai ragazzi dai dieci ai quindici anni e a coloro che li accompagnano.
Nei particolari di una sequenza di fotografie utilizzate da Darwin per L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali ecco bambini in lacrime, bambini che frignano, bambini che singhiozzano.
Per Darwin l’emozione era un fenomeno primitivo, presente in uccelli, cani e gatti e negli umani inferiori, o perché “razze umane che hanno poco a che fare con gli europei”, o perché bambini, donne, qualcosa di riscontrabile soprattutto nelle pazze e nei vecchi senili.
Insomma, gli inglesi e gli adulti non piangono e questa gerarchia positivista psico-valoriale non era lontana da alcuni aspetti delle idee di Freud: l’illusione religiosa appartiene a uno stadio infantile della personalità e colpisce soprattutto le donne, ma non si confaceva al maschio adulto. Sappiamo quanto “trattenere le lacrime” in pubblico sia stato un invito rivolto, fino a non molto tempo fa, a chi doveva dimostrare di riuscire a ricoprire un ruolo, svolgere una performance che mal si coniugava con l’esprimere la propria sensibilità.
Oggi anche i calciatori possono versare lacrime, ma il pianto spasmodico di un bambino può creare un vuoto in un ristorante.
E seppure ammesso e a volte anche invocato – “lacrime retoriche e artificiali” come accade in molti programmi televisivi –, il nostro pianto ci interroga, a volte ci inquieta per la sua imprevedibilità. Dirsi emozionati è diventato un po’ uno stereotipo in conversazioni pubbliche e private, ma non è mai facile governare la grammatica dei propri stati d’animo che assorbono una grande energia e la cui decifrabilità non è sempre immediata.
Forse, perché, scrive Didi-Huberman, “un’emozione non è forse una e–mozione, cioè un movimento, che consiste nel metterci fuori da (e-, ex), fuori da noi stessi? (…) Essa è in me, ma fuori di me”. Il punto esclamativo del titolo dice “una situazione di sorpresa: un’emozione mi cade addosso senza preavviso”, (…), ma questo primo gesto di stupore non sarebbe fino in fondo filosofico se non si prolungasse in “una serie infinita di punti di domanda; che cosa intendiamo per ‘emozione’? che genere di emozione? e perché l’emozione?”
Chi piange si espone all’altro, mostra qualcosa del vissuto interiore che in quel momento non riesce a nascondere. Il rischio, afferma Didi-Huberman, è che possa apparire ridicolo, venga considerato “patetico”. La storia del pathos contrapposto al logos, l’essere sopraffatti da un’emozione che impedisce di reagire, inibisce l’azione, è intrecciata alla storia della filosofia.
“Dopo Nietzsche i filosofi sono un po’ più emozionati”, ma nel senso comune rimane radicata la contrapposizione tra emotività e razionalità. L’emersione del velo di lacrime, ma anche del rossore, del sudore dice che nel corpo traspare qualcosa che nell’anima si muove; e non sono “parti basse”, ma sensazioni fondamentali per comprendere che cosa ci accade, indispensabili quando dobbiamo scegliere un orientamento.
Ma se l’emozione da cui siamo posseduti, se dissociata dal nostro sentire cosciente, conferma che l’Io “non è padrone a casa propria”, dall’altra offre la possibilità, il potere di essere visti. Rappresenta un io che si trasferisce dalla prima alla terza persona: piango diventa piange.
E un “pianto rituale”, come accade durante una cerimonia funebre, può toccare tutti, il lutto singolare diventa plurale, unisce la comunità: assume una dimensione etica. E gesti antichi “sono come fossili in movimento. Hanno una storia molto lunga – e molto inconscia. Sopravvivono in noi”.
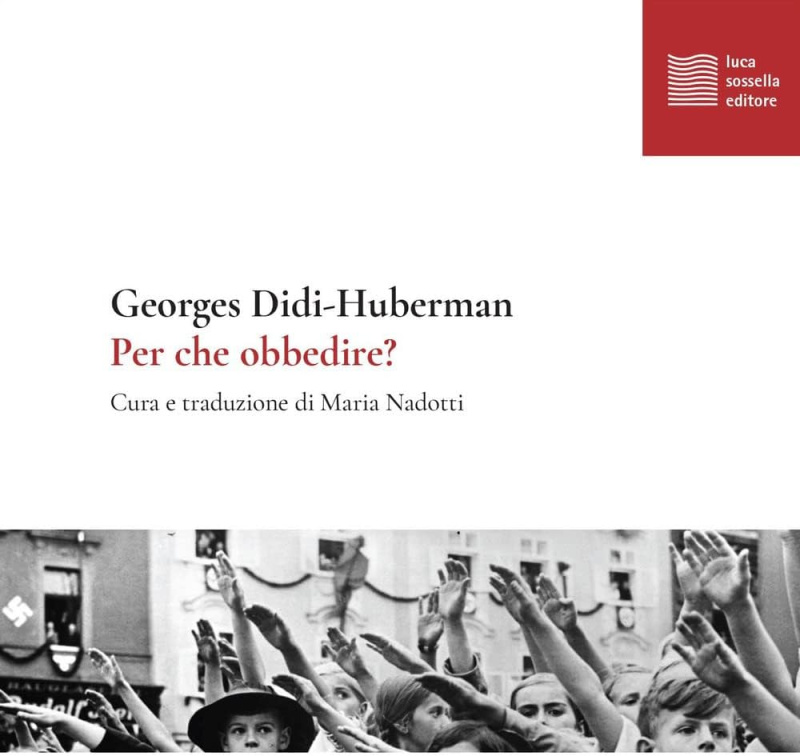
A questo punto, al suo giovane pubblico, Didi-Huberman cerca di rendere in modo semplice la sua complessa teoria delle immagini: l’idea di un rapporto dialettico tra visibile e invisibile, l’idea che le immagini hanno un pensiero, una storia e un destino, la costruzione di una “storia delle arti visive – della pittura e della scultura, ma anche della fotografia o del cinema – che possa essere letta come un’immensa storia delle emozioni figurate, quei gesti emotivi che Warburg chiamava “formule del pathos”.
E all’Atlante della memoria di Warburg Didi-Huberman collega quello, storicamente contemporaneo, delle sequenze nel film La corazzata Potëmkin dove i concetti di pathos, migrazioni, sopravvivenze appaiono il centro dell’antropologia di Ejzenštejn.
Nella sequenza della morte del marinaio, la figura carismatica che ha guidato la rivolta, si assiste al passaggio dalla tristezza e dalla commozione alla rabbia: “le mani dolenti diventano pugni chiusi”. Il popolo in lacrime diventa il popolo in armi. Il sentire diventa politica. Le emozioni hanno dimostrato la loro capacità di azione, rinsaldato “l’idea che l’emozione non può definirsi uno stato di pura e semplice passività”.
Nelle risposte al pubblico Didi-Huberman sottolinea la sua passione antropologica per l’espressività dell’immagine – sottoposta a un’indagine sintomatologica come aveva fatto nella ricerca sulla messa in scena del corpo delle isteriche. Ammette di essere più interessato alla trasformazione visibile delle lacrime, ai suoi effetti civili e sociali, piuttosto che alle conseguenze interiori che può produrre un pianto notturno.
Il suo scopo non è indagare l’aspetto psicologico del fenomeno, ed è forse questo a portarlo alla considerazione sconcertante secondo la quale le persone che non conoscono turbamenti sono pazze o psicotiche.
Che emozione! Che emozione? Piccola conferenza riprende alcune parti di un’opera che l’autore stava scrivendo, Popoli in lacrime, popoli in armi. L’occhio della storia 6 (a cura di Renato Boccali, Mimesis, 2020), un vero e proprio tomo dedicato alla rilevanza storica delle immagini, alla facoltà politica e critica necessaria per restituire potere alle emozioni.
È anche un invito rivolto al lettore – spettatore impotente e passivo davanti a immagini ed emozioni che perdono il loro potere reale – a una mobilitazione attiva. Per Didi-Huberman la politica dell’immaginazione rende leggibile la drammaticità dell’era contemporanea come affermava Susan Sontag in Davanti al dolore degli altri – la guerra che vediamo in ogni casa, l’incessante scorrere delle immagini sotto i nostri occhi fanno sì che non riusciamo a capire la nostra storia contemporanea.
Da qui un’inquietante dialettica di sopravvalutazione e antipatia, di rimpinzamento e di insensibilizzazione. Una spirale che immobilizza l’immagine, la paralizza. Da qui l’odio, un’indifferenza “difensiva” che può emergere dal fondo della pietà.
“Popoli in lacrime, popoli in armi, conclude il curatore Renato Boccali, si presenta quindi come la chiusura del periplo, con lo sguardo rivolto all’espressione dell’emozione collettiva di popoli marginali e generalmente silenziati dalla storia.
Un’emozione che si esprime attraverso lacrime, segno di impotenza e fragilità, ma che reclama visibilità (…). Se i popoli hanno un volto, da questo volto scendono lacrime. Lacrime private, certo, ma che ben presto diventano condivise. Il pianto si fa collettivo e spinge all’azione, alla rivolta, alla sollevazione.
Le lacrime, quindi, come massima manifestazione d’impotenza, si visibilizzano e si trasformano in potere: espressivo, estetico, politico. È l’intero corpo sociale a piangere, a com-muoversi e quindi ad agire”.
Leggi anche:
Valentina Manchia | Didi-Huberman, tavole e taccuini
Silvi Vizzardelli | Georges Didi-Huberman e la somiglianza sovversiva




 (
( (
(