Al 21 agosto il conto è di sessantasette morti,
gli ultimi sono a distanza ravvicinata.
Nel carcere di San Michele ad Alessandria, Ciro di trentacinque anni si è tolto la vita avvolgendosi la testa in una busta di plastica riempita con il gas. Si è impiccato un tunisino di trentasei anni mentre era in isolamento. Un uomo si è tolto la vita nel bagno di una camera di sicurezza del Tribunale di Salerno, era in attesa dell’udienza per cui era stato tradotto e poche ore prima nel carcere di Biella si è ammazzato un detenuto albanese di cinquantun’anni.
Nei giorni scorsi un uomo di trentun’anni si è tolto la vita impiccandosi alle grate della prigione di Regina Coeli, dopo poche ore un ragazzo di venticinque anni si è ammazzato nel carcere di Rieti sempre in cella di isolamento. Non riusciamo a stare dietro al conto.
Sembrerebbe un morbo, una specie di peste nera che corre veloce negli spazi di prigionia. Invece sono i costi di una lenta guerra di logoramento, un’esecuzione ufficiosa del “principio di neutralizzazione” che colpisce gli animali ristretti più deboli.
Dentro si resiste alla meglio al “morbo”, sfruttando le risorse emotive disponibili e i legami esterni – quando la detenzione non li ha divorati –, si stringono i denti quando si aspettano mesi per avere risposta alle istanze, quando si devono fronteggiare i rigetti della magistratura, quando si aspettano anni per avere un colloquio con un magistrato di sorveglianza (in alcuni istituti come quello di Sant’Angelo dei Lombardi l’ultimo accesso in istituto del magistrato di sorveglianza risale al 17 settembre 2020) o con un educatore, quando si impatta con il vuoto di prospettiva e con la miseria che non permette di comprare allo spaccio neanche un pacco di pasta.
Il sistema si sgretola, perde pezzi, non riesce a stare dietro agli ingressi in aumento progressivo e la classe dirigente ignora questa polveriera pronta a esplodere. Tagliando fuori le vuote retoriche progressiste, i piagnistei riformisti e i tweet forcaioli di qualche politico, dal punto di vista amministrativo la visuale più lucida emerge dalle divise poste al fronte, che pur sposando l’idea del “contenimento totale” e della “guerra interna ed esterna” sono coscienti che il mondo penitenziario necessita di una ristrutturazione e di un “reset tattico”.
La sofferenza rimane sospesa, come gli impiccati alla corda, non trova spazi di mediazione ma non riesce neanche a essere repressa totalmente e in questo scenario si iscrivono le proteste degli ultimi giorni. Il 5 luglio Firenze, il 6 Casal del Marmo, il 12 Trieste, tra il 28 e il 29 le carceri di Velletri e Terni entrano in agitazione, il 30 Cuneo, il primo agosto gli istituti torinesi di Lorusso e Cotugno e Ferrante Aporti.
Alcuni giornali pur di schivare la descrizione del problema reale che affligge il settore dell’esecuzione penale, continuano a paventare l’esistenza di una regia delinquenziale dietro le proteste.
Tale scenario riproduce alcuni schemi che abbiamo osservato durante l’emergenza pandemica e richiama la riflessione centrale sul tema dell’esercizio della forza e della tenuta materiale e istituzionale dei “contenitori”. Ci riporta con immediatezza alla rappresaglia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, quando la classe dirigente dell’amministrazione penitenziaria campana e il corpo di guardia scelsero congiuntamente di conservare l’ordine con la violenza.
* * *
Le udienze si sono ripetute senza grandi variazioni. La Procura attraverso le testimonianze delle persone offese continua il lento lavoro di saldatura degli elementi fattuali, riguardanti principalmente la sequenza delle violenze e le identificazioni. Il prelevamento dalle celle, la divisione in due gruppi dei detenuti dei quattro piani del reparto Nilo (alcuni condotti nella socialità, altri nei passeggi), la ricerca dei quindici “facinorosi” trascinati in isolamento, la falsificazione delle contestazioni disciplinari per giustificare la misura di rigore, le tremende mazzate che si ripetono per ore e ore durante le udienze nei televisori dell’aula bunker…
Sono dati ormai acquisiti dalla Corte di Assise. Invece, sentiamo di dover evidenziare alcuni elementi rappresentativi dei rapporti di forza processuali che si stanno ormai definendo con maggiore sensibilità. Sono questioni che emergono dal contrattacco continuo sferrato dai legali degli imputati contro ogni punto della costruzione processuale e giuridica della Procura. Devono indebolire le argomentazioni, creare vuoti di senso e/o contraddizioni tra le prove offerte dagli inquirenti, generare disordine.
Riguardo alla ricostruzione dei fatti, il terreno di scontro principale verte sulle testimonianze delle persone offese. Quell’universo discorsivo, a tratti brevissimo, in altri punti invece un’alluvione di parole, viene a ogni udienza aggredito, sfilacciato, decomposto in piccole particelle e rimesso insieme con altro ordine. L’obiettivo è far emergere le incoerenze tra quanto dichiarato in sede di indagini e quanto invece detto in udienza.
Nel controesame, quindi, si cerca di smontare parole, aggettivi, tempi di azione, numero delle persone coinvolte, identificazioni, numero e specie dei colpi subiti. Generalmente prima di questa schermaglia, si assiste alla squallida attività dei difensori che tentano di imbarazzare i testimoni chiedendo i precedenti penali (nonostante la corte abbia acquisito tutti i casellari giudiziali).
Questi primi scambi contribuiscono a screditare le persone offese, soprattutto agli occhi dei giudici popolari che presiedono l’aula senza un retroterra giuridico funzionale alle valutazioni processuali. Tali tentativi denotano la povertà culturale dei difensori che si prestano a questa attività: il processo verte sulle torture subite da detenuti comuni, uomini che provengono quasi tutti dal mondo dei reietti e tale dato dovrebbe rimanere escluso dalle valutazioni.
Il pressing è snervante, quando il controesame non sortisce l’effetto desiderato perché il testimone riesce a reggere alla raffica di domande cristallizzando il dato dichiarativo con estrema chiarezza, i legali finiscono con un telegrafico e minaccioso: «Va bene, faremo verifiche successive».
Il più delle volte a controesami aggressivi i detenuti rispondono anche con violenza, l’effetto è prodotto volontariamente per capovolgere il ruolo di vittima e in questo gioco di parole la differenza culturale tra le parti (avvocati e imputati) costituisce il principale materiale incendiario per montare le provocazioni.
La strategia del rovesciamento si è svelata nettamente quando i difensori con due eccezioni distinte hanno tentato di incriminare le persone offese, minando la loro posizione processuale. La prima è stata esaminata in occasione dell’escussione di un detenuto che ha raccontato di aver partecipato alla protesta del 5 aprile 2020 (quindi alla battitura e al cd. “barricamento”):
Difensore: Presidente, siete voi che dovrete decidere, io prospetto, quello è il compito del difensore, prospetto una tesi, la mia tesi è che il signore ha ammesso di avere fatto un [reato ex art.] 336 [violenza o minaccia al pubblico ufficiale] o 337 [resistenza a pubblico ufficiale]; rispetto a questo io penso che abbia il diritto di essere avvertito, poi non lo fate, io vado avanti lo stesso.
Se la Corte avesse ravvisato gli estremi di reato avrebbe dovuto interrompere il teste leggendo gli avvisi di garanzia e questo avrebbe trasformato la posizione del testimone, riducendone la valenza probatoria.
Presidente: Per quanto riguarda strettamente il discorso brande e sulla parte della resistenza avevamo considerato che fino a questo punto c’è un atteggiamento più passivo che non attivo, quindi non c’è una vera e propria manifestazione di violenza nei confronti, c’è un barricamento, c’è una esclusione, ma non è violenta nei confronti degli agenti e soprattutto – almeno per quanto sia stato dato sinora modo di capire a questa Corte – spontaneamente rimosse anche se in ora tarda, quindi consentendo poi l’accesso libero agli agenti. Dovendosi verificare l’esistenza di indizi in rapporto a tale reato… certo, se le ulteriori contestazioni evidenziavano profili diversi di partecipazione attiva ad attività diversamente violente, allora si configurava l’ipotesi della sospensione dell’esame e dell’avviso al soggetto. Questo era l’atteggiamento della Corte su quello che è il contesto.
La seconda eccezione è stata invece presentata in occasione dell’escussione dei testimoni che si sono rifiutati di rispondere in fase di indagine all’autorità giudiziaria. Secondo le difese, i detenuti avendo commesso il reato di favoreggiamento dovevano essere ascoltati come indagati di reato connesso, altra posizione processuale complicata. La questione si teneva in piedi solo sotto il profilo astratto e irrazionale: perché i detenuti picchiati il 6 aprile avrebbero dovuto favorire i propri aguzzini?
A ogni modo, la Corte anche sulla base dell’esimente di cui all’art. 384 c.p. [casi di non punibilità] proposta dai pochi e soliti avvocati di parte civili che imperterriti continuano a presidiare l’aula processuale, rappresentando le associazioni, il garante nazionale e qualche persona offesa, rigettava la questione.
Queste raffiche di contrattacco sono scagliate da poche punte di diamante, cecchini preparati in anni di battaglie processuali, che con la medesima frequenza e intensità cercano di indebolire l’accusa in giudizio. Tuttavia, tra gli avvocati si coagulano le medesime spaccature strategiche in parte già manifestate in udienza preliminare: agenti, comando penitenziario e comando amministrativo non interpretano ugualmente gli eventi del 5 e 6 aprile individuando responsabilità reciproche diverse.
Nonostante la controffensiva in parte efficace, le fragilità connaturate a un un’indagine complessa e le contraddizioni inevitabili di alcune testimonianze, le emersioni fattuali raccolte finora sembrerebbero confermare la tesi secondo cui serviva un pretesto per entrare e realizzare una spedizione punitiva. Tutti i partecipanti avrebbero compreso cosa bisognasse fare il pomeriggio del 6 aprile. L’ordine era chiaro e condiviso, doveva essere solo eseguito.
P.M.: E c’era qualche agente che lei conosceva tra quelli che sono entrati?
Teste 1: No, perché erano pochi mesi che ero entrato nella casa circondariale, non conosco quasi a nessuno, ci hanno messo solo vicino alle finestre, poi ci hanno chiamato.
P.M.: Un attimo solo. Quando sono entrati questi agenti all’interno della cella, vi hanno fatto mettere con la faccia rivolta verso la finestra e che vi hanno detto?
Teste: Poi dopo ci hanno chiamato ognuno.
P.M.: Sì, ma che cosa vi hanno detto? Che cosa dovevate fare voi o loro che cosa dovevano fare?
Teste: Niente, niente, solo vicino alla finestra ci hanno messo.
P.M.: E nel frattempo loro che hanno fatto?
Teste: Nel frattempo hanno detto… abbiamo fatto delle domande normali, “state zitti, state zitti”, pensavamo che avevamo fatto noi qualcosa in genere, qualche punizione, hanno detto: “non parlare, state zitti, non vi girate indietro, mettete sempre la faccia vicino alla finestra”.
– – –
P.M.: 6 aprile mattina, ricostruiamo quella giornata.
Teste 2: Alle due, due e dieci io stavo vicino alla stanza che vedo le scale, vedo salire tutti gli agenti con manganelli, caschi, mascherine, dissi io: “non penso che è una perquisizione, che sta succedendo?”. La verità quel giorno mi sono messo anche una maglia in più perché temevo… dissi: “una perquisizione così non l’ho mai vista”.
– – –
P.M.: Nella stanza sua cosa disse quest’agente?
Teste 3: “Spogliatevi, perquisizione”, non lo sapevamo. Non ci diedero nemmeno il tempo di spogliarci. Figuratevi che al mio amico non gli fecero nemmeno mettere la tuta addosso, scese giù con le mutande, con il boxer. […]
Teste 3: Entrarono questi qua, “perquisizione”, con la scusa della perquisizione già iniziarono a malmenarci, calci, schiaffi, cazzotti, poi uno alla volta ci prendevano e ci buttavano fuori dalla cella; fuori dalla cella così c’era tutta la sezione, centomila poliziotti di qua centomila poliziotti di là, tu dovevi passare in mezzo a loro e loro ti scamazzavano, manganellate, cazzotti, di tutto e di più; se cadevi a terra perché si mettevano tutti addosso: Bunghete banghete bunghete banghete. Questo è successo…
La legittima perquisizione rimane nel retroscena, è un argomento difensivo troppo debole, perché finora, invece, emerge (sarà interessante capire in dibattimento la prospettiva degli agenti quando si sottoporranno a esame) una rappresaglia compiuta a freddo: “nuje simm stati acchiappati pe de reto”.
* * *
Un ultimo aspetto ci preme segnalare e riguarda il secondo troncone processuale. Agli inizi di agosto la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto al Gip di emettere ventinove misure cautelari per gli altri agenti indentificati nell’ambito di un secondo procedimento che ha come oggetto i medesimi fatti di violenze. Infatti, è ormai noto che alla rappresaglia del 6 aprile hanno partecipato circa trecento agenti ma sono stati portati a processo soltanto cento e otto. Rimangono fuori dall’inchiesta un numero cospicuo di poliziotti e per tali ragioni i pubblici ministeri hanno continuato a indagare per perfezionare le identificazioni.
La richiesta della Procura è stata rigettata, risultato prevedibile perché a distanza di tempo le ragioni che dovrebbero sorreggere processualmente la misura cautelare (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione dei reati) sono fragili e/o inesistenti. Immediatamente, l’organo inquirente ha impugnato il rigetto e si dovrà pronunciare il 26 settembre il Tribunale del riesame di Napoli sulla fondatezza delle argomentazioni. Tuttavia, se il Tribunale delle libertà dovesse confermare il rigetto e se i magistrati inquirenti dovessero intestardirsi ricorrendo in Cassazione si potrebbe generare un nucleo argomentativo solidificato che remerebbe in direzione contraria. In sostanza, un effetto opposto rispetto a quanto abbiamo registrato nella fase cautelare del primo filone processuale, quando la Corte di Cassazione, giudicando il ricorso delle difese degli imputati, confermò l’ordinanza cautelare del Gip richiamando la gravità delle condotte di tortura (S. Bernardi, Carcere e tortura: la Cassazione sui fatti di SMCV)
L’esigenza di identificare ancora un numero considerevole di agenti evidenzia la fragilità più grande dell’inchiesta che riguarda proprio i riconoscimenti. Da un punto di vista processuale è necessario comporre l’equazione tra le condotte e i responsabili. Gli inquirenti hanno incrociato le immagini di videosorveglianza con quanto riferito dalle persone offese e dagli indagati in sede di interrogatorio di garanzia. È il punto nevralgico. Tuttavia, le immagini spesso non sono nitide e chi ha vissuto la “mattanza” spesso non ha dei ricordi precisi rispetto ai volti. Il 6 aprile 2020 in quel carcere c’era una marea di gente. Pertanto, le zone d’ombra che inevitabilmente si creano nelle ore di udienza e tra le pagine dei verbali costituiscono la principale insidia.
Torneremo a breve in aula bunker, i lavori ricominceranno il 9 settembre, continueranno a deporre le persone offese (non è terminato il nucleo dei quindici, divenuti quattordici per la morte di Hakimi), e questa volta oltre al fetore della discarica e dei pesticidi che inondano i terreni agricoli, al lavoro interminabile dei corrieri, al rumore dei cancelli e dei tir gonfi di merci, ci accompagnerà il silenzio degli impiccati sospesi alle grate delle prigioni.
<<< PUNTATA PRECEDENTE

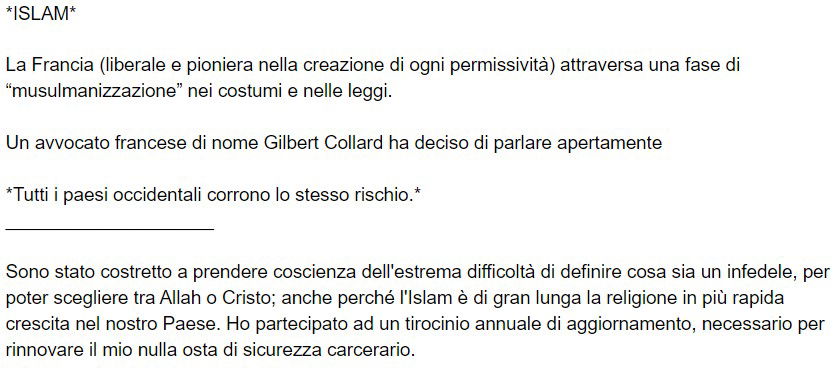
Su internet circolano due testi VIOLENTI e ISLAMOFOBICI che mi vengono falsamente attribuiti. Non sono in alcun modo l’autore. Verrà presentata una denuncia.

