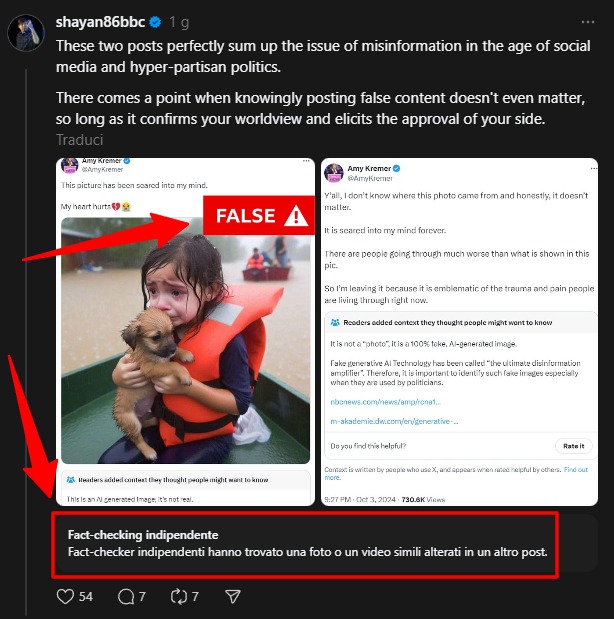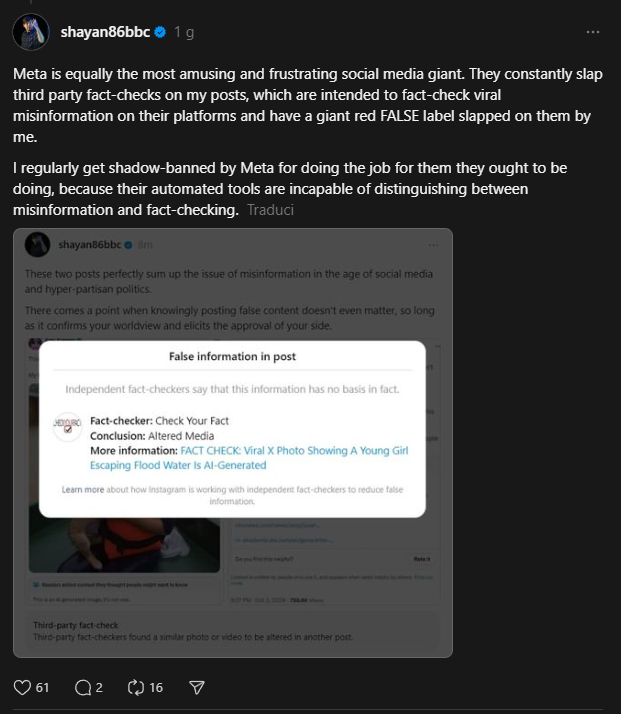di Umberto De Giovannangeli
Saggista e nipote di Carlo Levi
«L’opposizione che si era sollevata contro il governo di destra e le sue leggi volte a stravolgere la democrazia in democratura e in etnocrazia, ha aggirato il punto centrale: la questione palestinese e del regime di apartheid coloniale»
Stefano Levi Della Torre, saggista, critico d’arte, nipote di Carlo Levi, è tra le figure più autorevoli, sul piano culturale e per il coraggio delle sue posizioni, dell’ebraismo italiano.
Tra i suoi numerosi saggi, ricordiamo, per la sua acutezza e stringente attualità, Essere fuori luogo. Il dilemma ebraico tra diaspora e ritorno (Donzelli Editore). Stefano Della Torre è uno dei promotori dell’appello “Mai indifferenti. Voci ebraiche per la pace”, in cui c’è scritto, tra l’altro: “Il 7 ottobre, non solo gli israeliani ma anche noi che viviamo qui siamo stati scioccati dall’attacco terroristico di Hamas e abbiamo provato dolore, rabbia e sconcerto. E la risposta del governo israeliano ci ha sconvolti: Netanyahu, pur di restare al potere, ha iniziato un’azione militare che ha già ucciso oltre 28.000 palestinesi e molti soldati israeliani, mentre a tutt’oggi non ha un piano per uscire dalla guerra e la sorte della maggior parte degli ostaggi è ancora incerta.
Purtroppo, sembra che una parte della popolazione israeliana e molti ebrei della diaspora non riescano a cogliere la drammaticità del presente e le sue conseguenze per il futuro. I massacri di civili perpetrati a Gaza dall’esercito israeliano sono sicuramente crimini di guerra: sono inaccettabili e ci fanno inorridire. Si può ragionare per ore sul significato della parola “genocidio”, ma non sembra che questo dibattito serva a interrompere il massacro in corso e la sofferenza di tutte le vittime, compresi gli ostaggi e le loro famiglie.
Molti di noi hanno avuto modo di ascoltare voci critiche e allarmate provenienti da Israele: ci dicono che il paese è attraversato da una sorta di guerra tra tribù – ebrei ultraortodossi, laici, coloni – in cui ognuno tira l’acqua al proprio mulino senza nessuna idea di progetto condiviso. Quello che succede in Israele ci riguarda personalmente: per la presenza di parenti o amici, per il significato storico dello Stato di Israele nato dopo la Shoah, per tante altre ragioni. Per questo non vogliamo restare in silenzio.
Ci sembra urgente spezzare un circolo vizioso: aver subito un genocidio non fornisce nessun vaccino capace di renderci esenti da sentimenti d’indifferenza verso il dolore degli altri, di disumanizzazione e violenza sui più deboli. Per combattere l’odio e l’antisemitismo crescenti in questo preciso momento, pensiamo che l’unica possibilità sia provare a interrogarci nel profondo per aprire un dialogo di pace costruendo ponti anche tra posizioni che sembrano distanti”. L’Unità lo ha intervistato.
Gaza, Libano. Iran. Non c’è pace in Medio Oriente. È un destino ineluttabile?
La guerra è in corso. Le guerre tendono a protrarsi per interessi combinati, a cominciare dall’economia delle armi e delle loro sperimentazioni. Più in generale, si protraggono per una perversa inerzia di azione e reazione fino al punto in cui i superstiti si inventano di tutto pur di uscirne.
Come siamo creativi nell’inventare ordigni di distruzione, così, costretti dalla necessità da noi stessi prodotta, lo siamo nell’inventare sbocchi prima impensabili. Le guerre di religione che hanno devastato l’Europa l’hanno poi riconfigurata e dalla loro terrificante esperienza regressiva sono nati nuovi criteri nei rapporti tra popoli e poteri, istanze di tolleranza pluralista e inclusiva attraverso Grozio o Locke o Montesquieu, fino all’illuminismo.
Per poi magari ricadere nella regressione dei fondamentalismi nazionalistici e religiosi e nella guerra, come oggi. Purtroppo, è questo l’andamento della storia che non sappiamo evitare, in cui le vittime, o meglio i vittimisti, si fanno carnefici. Il nuovo nasce dalle necessità imposte dalle catastrofi. Ciò vale per l’ambiente come per la politica. Non sappiamo anticipare gli esiti delle crisi, ma nelle crisi non possiamo né dobbiamo rinunciare ad elaborare prospettive del futuro.
Da quel tragico 7 ottobre 2023 Israele è un paese in guerra. Una guerra “per sempre”.
Israele vincerà militarmente e perderà politicamente. L’ossessione di una deterrenza stragista in sostituzione di una politica propositiva produce il suo isolamento, il crollo del suo prestigio e del suo consenso internazionale. Mentre lungo i secoli le potenze salivano e scendevano, la durata degli ebrei è un fenomeno anomalo che non si è mai basato sulla forza. L’affidarsi alla forza come fa adesso Israele contraddice la storia ebraica e le sue strategie di durata.
Quanto più la destra, di governo e anche nel senso comune, condurrà Israele da un lato a insistere, nei territori occupati, secondo i modi desueti di un colonialismo d’altri tempi; quanto più il nazionalismo e il fondamentalismo ebraico si spingerà ad assimilarsi ai modi e alle mentalità dei fondamentalismi islamisti da cui Israele deve difendersi, tanto più Israele si troverà isolato, corpo estraneo nella sua regione e nel mondo. In una china da cui dovrà risalire per vivere e sopravvivere.
Avendo vissuto nei secoli nel mondo dei vinti, dopo la Shoah il mondo ebraico si è trovato inscritto nel mondo dei vincitori e se ne è valso. Ma ora sono appunto i “vincitori” della Seconda guerra mondiale e della guerra fredda a veder declinare la loro centralità nel mondo, ad essere contestati e sotto attacco. Proporsi come baluardo di un mondo in declino (finché non saprà rinnovarsi) non è promettente per Israele.
C’è ancora spazio per realizzare una pace fra Israeliani e Palestinesi fondata sul principio “due popoli, due Stati”?
La prospettiva “due popoli due Stati” (proprio quella che portò la destra estrema ad assassinare Rabin, con la complicità di personaggi ora al governo) è attuale come orientamento, non lo è per l’oggi: implicherebbe una guerra civile in Israele ad opera dei coloni e della destra che li sostiene, li incoraggia e li arma.
La loro missione è esattamente quella di impedire la prospettiva di un’indipendenza palestinese. C’è chi dice che Israele non ha una politica. Effettivamente solo la destra estrema ha un programma chiaro, ed è quello di risolvere definitivamente la questione palestinese, facendone strage e cacciando in massa i palestinesi dalla loro terra, e quello di risolvere con la guerra la minaccia iraniana.
Sotto il prevalere della destra, e anzi fin dall’assassinio di Rabin nel 1995, Israele era già in una guerra, latente ma sistemica, con i palestinesi in Cisgiordania e nell’accerchiamento di Gaza. L’aggressione e il massacro compiuto da Hamas e Jihad il 7 ottobre 2023, ha traumatizzato profondamente Israele, ha travolto l’illusione in una sicurezza raggiunta, e ha trasformato la guerra da implicita in esplicita E ha attivato i nemici di Israele dal Libano e dallo Yemen.
Con l’uccisione, il primo aprile 2024, di funzionari iraniani a Damasco, Netanyahu ha voluto aprire direttamente il fronte con l’Iran, per internazionalizzare la crisi, proponendosi come risolutore per conto dello schieramento geo-politico in cui si inscrive, del disordine mediorientale, per guadagnare un consenso logorato dai crimini contro l’umanità, dalla palude di sangue e sofferenza su cui insiste a Gaza in cui si è impantanato, non solo contro Hamas ma contro il popolo palestinese.
Israele è anche, sempre più, un paese lacerato tra le sue due anime. Una spaccatura che spesso è sottaciuta o sottovalutata dalla stampa di casa nostra.
Israele è certamente spaccato in due. Da un lato, un Israele in prevalenza laico e liberale; dall’altro un Israele nazionalistico e fondamentalista che agita i miti “messianici” della terra promessa, la religione ebraica e l’etnocrazia come vessilli idolatrici. Quando si invoca l’unità nella solidarietà con Israele aggredito da Hamas, per quale Israele la si invoca? D’altra parte, l’opposizione che si era potentemente sollevata contro il governo di destra e le sue leggi volte a stravolgere la democrazia in democratura e in etnocrazia, ha aggirato il punto centrale: la questione palestinese lasciata suppurare senza prospettive, la questione del regime di apartheid coloniale nei territori occupati, da cui promana un inquinamento ideologico e razzistico nel senso comune e nelle stesse istituzioni di Israele.
Come muoversi, anche da parte della diaspora ebraica, in questo scenario?
Certamente occorre contare ed appoggiare in tutti i modi quella parte di Israele che resiste alla mutazione negativa di Israele e dello stesso sionismo. Il quale era partito per rivendicare il diritto degli ebrei di farsi Stato ed ora si presenta come pretesa di negare ad altri quello stesso diritto. Anche se ridotta dalla guerra che chiama all’unità nazionale, è in quella opposizione che stanno le possibilità di risalire, forse in un’altra generazione, da questa catastrofe.
E certo l’antisemitismo riattivato, a destra e a sinistra, dalla conduzione di Israele, e quel palestinismo che inneggia a Hamas e al suo fondamentalismo come rappresentante del riscatto palestinese e alla distruzione di Israele non aiutano, anzi sono nemici radicali. Essi alimentano la destra oltranzista ebraica e il suo vittimismo secondo cui “sono tutti contro di noi e solo ci resta la deterrenza militare”; e offrono alla destra non ebraica e magari di tradizione fascista, l’occasione di velare le sue responsabilità antisemite ponendosi a “difesa degli ebrei contro l’antisemitismo”. Ma con l’antisemitismo occorre confrontarsi.
In che modo?
A differenza di quella destra, in Israele e in diaspora, che considera l’antisemitismo un male metafisico e fatale, per cui non mette conto di confrontarsi con esso, per cui solo la forza e la deterrenza militare ce ne salva. Israele non se la caverà da solo. Ha bisogno della diaspora se in essa non rimarrà solo l’incanto subordinato allo “Stato guida”, ma si farà strada una critica solidale.
E mentre la destra scava la solitudine di Israele accusando l’opinione e il diritto internazionale e l’Onu di antisemitismo, Israele si salverà solo con l’aiuto critico del mondo, in appoggio alle sue forze democratiche e progressiste interne.