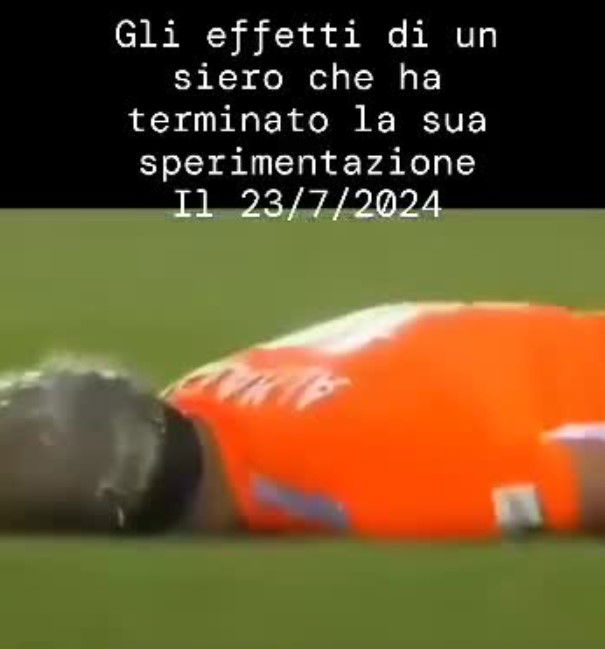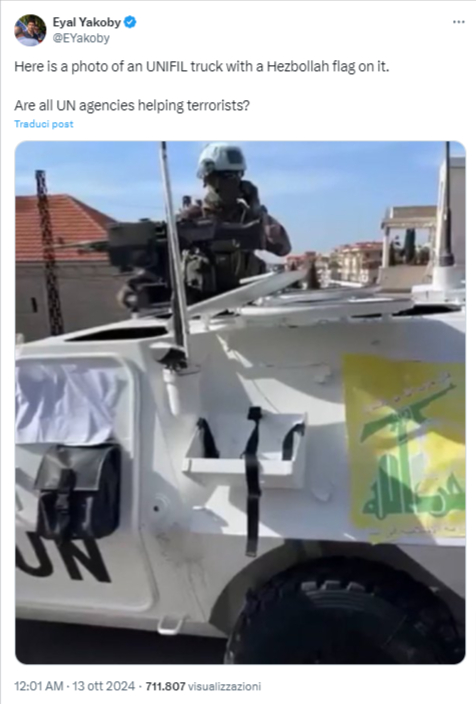di Anita Likmeta
Terra di scarto
Tirana accoglie (a pagamento) i migranti respinti dall’Italia e i detenuti dal Regno Unito e pensa di creare un micro-Stato islamico dentro i suoi confini, grazie a un premier abile e controverso che ha compreso che, per mantenere a galla il Paese, è necessario farlo apparire utile agli occhi dei potenti
L’Albania di Edi Rama è un Paese sospeso, un luogo dove la storia non è mai solo il passato e la modernità non è mai davvero il presente. È un teatro dove il dramma dell’esistenza balcanica si compie tra la nostalgia e il disincanto, tra l’aspirazione alla libertà e il perpetuarsi della schiavitù invisibile della propria storia.
Per dirla con le parole di Pier Paolo Pasolini, qui la realtà è più complessa di quanto la si voglia raccontare. L’Albania non è solo un Paese dei Balcani, è una metafora dell’Europa stessa, con le sue contraddizioni più profonde, con quel suo oscillare costante tra la promessa della democrazia e il ritorno all’autoritarismo. L’accordo con Giorgia Meloni per accogliere i migranti respinti dall’Italia non è solo una mossa politica, ma il simbolo di un Paese che si offre come discarica delle colpe europee.
Rama, abile come un regista, ha compreso che, per mantenere a galla il Paese, è necessario farlo apparire utile agli occhi dei potenti. Non è un gioco di potere, ma un compromesso necessario: l’Albania non può permettersi il lusso di essere irrilevante.
Non si tratta solo di una questione umanitaria: accogliere i migranti è anche, e soprattutto, una strategia per ottenere fondi, per lavare i panni sporchi altrui affinché si mischino con i suoi, con la consapevolezza che l’Albania, piccola e fragile, deve sopravvivere in un contesto ostile. Ma, al tempo stesso, la manovra riflette la realtà di una nazione che si fa complice di un’Europa incapace di risolvere i propri drammi.
La recente idea proposta dalla maggioranza al governo per la creazione di un micro-stato islamico all’interno dell’Albania, governato da un baba dell’ordine Sufi, ci offre un’ulteriore finestra su questa strategia. Rama sembra voler fare per l’islam ciò che il Papa fa per il cattolicesimo, mitigando l’islamofobia con un’autorità spirituale che dia un volto accettabile alla religione nella zona dei Balcani.
Eppure, dietro questa facciata di dialogo, potrebbe celarsi una verità più dura: l’islam è un pretesto, uno specchio in cui si riflettono le paure europee. Questo «Vaticano dei musulmani» non simboleggia tanto un atto di riconciliazione quanto un gioco di potere, una forma sottile di controllo che sfrutta l’emarginazione per capitalizzare sull’angoscia.
La proposta di accogliere i detenuti britannici nelle carceri albanesi si iscrive nella stessa logica: l’Albania si trasforma in una terra di scarto, in una prigione per le ombre del mondo occidentale. È la logica dei margini, in cui i Paesi periferici si fanno carico del peso che il centro si rifiuta di sostenere. Rama, in questo, è un maestro: sa che l’Albania non può competere con i giganti, e allora adotta una politica di mediazione, diventando un mercante che accetta di vendere qualcosa di sé pur di rimanere nel gioco.
Ma dietro questa apparente astuzia si nasconde una domanda: che prezzo sta pagando l’Albania per non scomparire? E a cosa deve rinunciare per restare visibile agli occhi del mondo? Questo evidenzia un aspetto fondamentale della politica albanese contemporanea: il Paese è incapace di sviluppare un proprio tessuto economico capace di stare sul mercato.
Eppure, nonostante tutte le critiche che si possono muovere nei confronti di Rama, è innegabile che sia l’unico leader capace di tenere insieme uno Stato in transizione, ancora traumatizzato dal lungo incubo del regime comunista di Enver Hoxha. La sua figura, sebbene controversa, è al centro di una democrazia fragile, dove l’opposizione appare quasi inesistente.
Sali Berisha, il leader del Partito democratico, visto dagli Stati Uniti come persona ingrata, non può essere considerato un vero rivale politico. E i giovani albanesi? Fuggono, emigrano e non credono nella politica, perché l’Albania non offre loro futuro.
Questa fuga di cervelli – che anche noi in Italia conosciamo bene – è la vera tragedia del Paese: una democrazia senza cittadini giovani è fragilissima. Vista da fuori, questa emigrazione sembra quasi una forma di auto-esilio, una denuncia silenziosa contro un sistema che non riesce a offrire nessuna speranza.
Rama è, in fin dei conti, l’ultimo baluardo di una democrazia fragile, che esiste solo perché non c’è nessuno abbastanza forte da opporvisi. Ma attenzione: non si può scambiare la stabilità con il progresso. Quella di Rama è la stabilità di un Paese immobile, che non sa dove andare.
La democrazia non è solo un sistema di governo, ma una forma di vita, un ethos che richiede partecipazione, critica, dissenso. E l’Albania non ha ancora sviluppato quel tessuto civile che rende la democrazia vitale. Quella albanese è una scenografia, e Rama ne è il regista, il protagonista e lo spettatore.
Il vero nodo è che l’Albania è ancora prigioniera della propria storia. Il regime di Hoxha ha lasciato cicatrici profonde, e la transizione verso la democrazia è ancora incompleta. La nazione vive così un dramma epico, dove il passato si aggrappa al presente, impedendo al futuro di nascere. Il popolo albanese è disilluso, diviso tra la nostalgia per un passato mitizzato e ormai quasi sconosciuto e il desiderio di fuggire da un presente che non mantiene le sue promesse.
Edi Rama, con il suo pragmatismo e la sua indiscutibile abilità comunicativa, è riuscito a mantenere il Paese a galla. La sua leadership, però, non è la soluzione, ma solo un palliativo, ed egli stesso è contemporaneamente parte del problema e parte della soluzione. Il premier albanese tiene per mano un Paese che non ha ancora imparato a camminare da solo, ma non è in grado di farlo crescere davvero.
La vera sfida dunque non è solo quella di mantenere il potere, ma anche quella di creare una democrazia che sia viva e capace di dare voce a chi non ce l’ha. Le vicissitudini della politica albanese contemporanea dovrebbero essere un monito per l’Europa intera: una democrazia senza popolo è una farsa.
E l’Albania, in questo senso, rappresenta la tragedia di un continente che non sa più distinguere libertà e sopravvivenza.