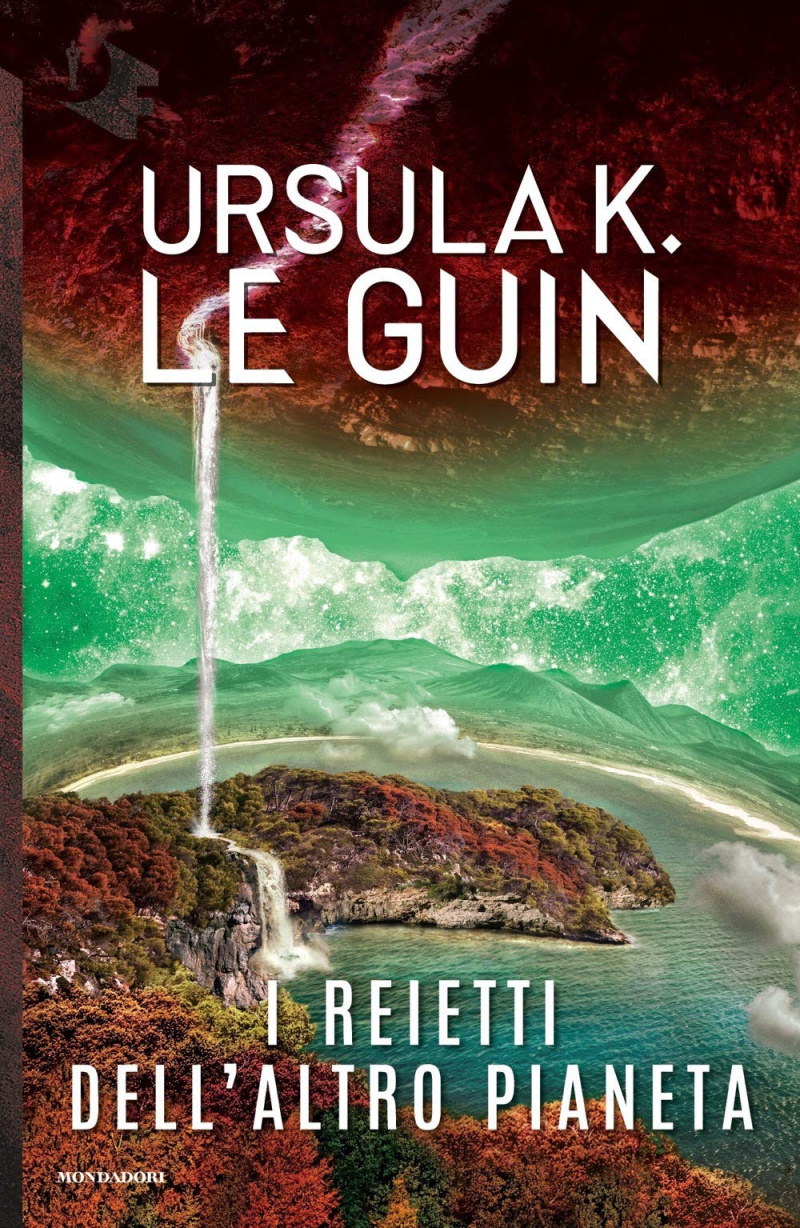di Gian Antonio Stella
L'eccidio di Villamarzana 80 anni fa
La metà delle vittime minorenni. Negli Anni 50 gli assassini erano già liberi
«V i supplico! Vi scongiuro! Sono ragazzi!», urlò pazza di terrore la signora Guidetti ai fascisti che rastrellavano le vittime destinate alla mattanza repubblichina. «Scegline uno!» le rispose acido, sfidandola, il capobanda.
E li portò via tutti due. Benito, il più grande, aveva 18 anni e portava probabilmente quel nome, come tanti italiani di allora, in onore di Mussolini. Il più piccolo, che portava il nome del primogenito del Duce, Vittorio, ne aveva 15. Li misero al muro insieme.
Nonostante l’eroico maestro Giovanni Tasso, che avrebbe avuto la medaglia d’oro alla memoria per essersi assunto inutilmente le responsabilità del gruppo partigiano in cambio della vita dei più giovani («Vi giuro: non c’entrano con noi») li avesse scagionati dalla minima responsabilità. E con loro furono fucilati altri venticinque minorenni. Compreso Bruno Zanella, quattordici anni, i brufoli e la barba che doveva ancora spuntare.
Era il 15 ottobre 1944. Esattamente ottant’anni fa. E quella compiuta lì, a Villamarzana, Polesine, è la più spaventosa ma meno nota delle stragi fasciste. Non nazifasciste come quelle compiute dalle SS e dalle truppe d’occupazione tedesche a Marzabotto, alle Fosse Ardeatine o Sant’Anna di Stazzema con la complicità degli italiani fedeli al regime.
Stragi che almeno in certi casi hanno visto gli ufficiali tedeschi finire alla sbarra e talvolta perfino in galera. Ma una rappresaglia tutta italiana. Decisa e perpetrata da repubblichini che nel processo celebrato subito dopo la fine della guerra davanti alla Corte d’assise straordinaria di Rovigo, presieduta da Alessandro Alessandri quando al Quirinale c’era ancora Umberto II, si chiuse il 5 novembre 1945 con la condanna a morte o all’ergastolo dei principali responsabili del massacro di 42 uomini (più altri 8 uccisi nei giorni successivi) accusati d’essere partigiani ma soprattutto poveretti scelti a casaccio per «dare una lezione» con una feroce rappresaglia dopo la sparizione di 4 fascisti che avevano cercato di infiltrarsi tra i partigiani.
Condanne a morte ed ergastoli presto evaporati tra ricorsi e amnistie. Col risultato che negli anni Cinquanta gli assassini erano già tutti fuori. Liberi. Senza neppure scontare il peso di una condanna morale da parte dei giornali dell’epoca. Assai distratti e ansiosi di dimenticare e rimuovere le ferite della guerra civile. Fino all’oblio.
Eppure la mattanza, ricostruita anni fa da un’indignata rappresentazione teatrale, «Il processo per l’eccidio di Villamarzana», messa in scena con tutti i documenti originali del dibattito processuale da Lorenzo Pavanello, un avvocato rodigino, è rimasta per il Polesine una ferita che dopo otto decenni butta ancora sangue.
Basti rileggere le cronache del giornalista Mario Bottari, il quale raccontò che la Questura limitava gli accessi al pubblico temendo reazioni violente, o la requisitoria del procuratore del re Giovanni Panzuto: «Circa le sevizie e le crudeltà rilevo due particolari: 1) i poveri giovani furono costretti a vivere l’ora suprema mentre i colpi uccidevano i compagni che li avevano preceduti; poi venivano uccisi in mezzo al sangue caldo dei compagni stessi. 2) l’animo di quelle belve fu così duro che su di esso nessuna compassione suscitò il fatto che mamme e spose e figli, stando in casa, dovevano sentire i colpi che la vita dei cari spegnevano…».
Vittorio
Il più piccolo portava il nome del primogenito del Duce. Aveva soltanto quindici anni
Sfilarono 135 testimoni, in quei giorni di processo. Ed emerse, tra la rabbia e le lacrime, una ricostruzione completa dei fatti. Alla fine di settembre l’Ufficio politico investigativo di Rovigo, saputa «dell’esistenza di una banda partigiana, il battaglione “Zaghi” comandato da Bellino Varliero detto “capitano Tito”» cerca di infiltrare tra i partigiani quattro informatori. Missione fallita. Vengono scoperti e fatti sparire.
Decisi a capire cosa fosse successo, i fascisti battono a tappeto l’area, rastrellano presunti simpatizzanti, interrogano pesantemente i prigionieri sui quali hanno maggiori sospetti finché arrivano a farsi confessare che i quattro sono morti e dove sono stati sepolti.
A quel punto Vittorio Martelluzzi, il comandante della Guardia nazionale repubblicana rodigina, d’accordo evidentemente coi superiori e le autorità naziste che però non verranno coinvolti nel processo, decide la rappresaglia: dieci morti per ogni morto. Già che ci sono, ne uccideranno due in più.
Domenica 15 ottobre pretendono che il «bando» che intima ai partigiani di consegnarsi venga letto in chiesa durante la messa. Il parroco don Pellegatti, che solo grazie al vescovo non verrà arrestato e lui pure fucilato, si rifiuta. Vengono allora chiamati da Padova i cappellani della Legione autonoma mobile «Ettore Muti», padre Germano e padre Cornelio.
Nonché un giudice e un cancelliere per rispettare la forma ma che arriveranno, spiegherà l’accusa «a eccidio compiuto». Hanno fretta, gli assassini. E dopo avere radunato gli ostaggi rastrellati nella «casetta del barbiere» un po’ isolata dal centro del paese, cominciano a metterne al muro sei alla volta, senza manco aspettare i preti per l’ultima benedizione, sotto la scritta «Primo esempio».
Scritta che al processo, stando agli atti, viene attribuita ora al comandante Vittorio Martelluzzi, ora al colonnello della Guardia fascista Ugo Cavaterra e ora a un altro gerarca, Giorgio Zamboni, conosciuto per una anchilosi a una gamba e la sua ferocia come «il boia zoppo». Tutti e tre decisissimi a scaricare le responsabilità della strage su spalle altrui.
Molti anni dopo Nazzarena Boaretto, che a quei tempi aveva solo sedici anni, racconterà in un libro autoprodotto dal titolo «Memorie di una vita» e distribuito ad amici e parenti: «Ricordo che la sera si sentivano da lontano solo le loro voci che cantavano a squarciagola: “Con il sangue dei partigiani ci laverem le mani”. E così è stato».
La «casetta del barbiere», lì a Villamarzana, è stata restaurata. Il vecchio muro dove furono fucilati i poveretti, però, è stato lasciato intatto. A futura memoria. Con una scritta che recita: «Caddero per la libertà da ogni tirannide / italiana e straniera / Dal loro sangue germogli esempio e monito /per le generazioni a venire / onde si perpetui la patria giusta / libera e democratica».
Parole d’oro. Purché si ricordi anche che in quel caso non furono nazisti e tedeschi i principali carnefici.