Libri
“Lo sforzo per comprendere ciò che il dettaglio significa per colui che lo esibisce e lo lascia vedere può dare adito tanto all’analisi di un etnologo quanto alla creazione di un romanziere. Esiste una specie di solidarietà oggettiva tra un percorso individuale qualsiasi e colui che vuol restituirlo o immaginarlo”. Il mondo brulica di segni, spesso minimi, lasciati là per caso da persone qualsiasi: spetta all’etnologo, che ne cerca le ragioni profonde, o al romanziere, che ne ricostruisce il piano immaginario, riprendere questi segni e articolarli in un qualche sistema, facendoli significare ancora di più.
Così, per esempio, il mondo della metropolitana parigina, che sta lì per scopi funzionali di natura urbanistica, diviene un universo ricco di linguaggi e di pratiche comunitarie, un fatto sociale totale che, più resta inconsapevole all’individuo singolo, più val la pena di interrogare.
Riprendo queste riflessioni dalle due ultime due pagine del Metrò rivisitato (2008) di Marc Augé, il grande intellettuale francese appena scomparso, che nella metropolitana della ville lumière sguazzava felice come un paperotto, mescolando con curiosa felicità indagine etnografica e vita vissuta, immaginazione letteraria e ritualità diffusa. Tempo prima aveva scritto uno straordinario volumetto intitolato Un etnologo nel metrò (1986), ma non gli era bastato: occorreva tornarci, in quei sotterranei, per riprendere – rivisitare – l’esplorazione, per principio mai definitiva.
Riflessioni che ben si attagliano, in generale, al lavoro di questo studioso sui generis, sempre pronto a fuoriuscire dalle frontiere del sapere istituzionale (e sulle frontiere ha scritto cose egregie) per mescolare, con furbizia e intelligenza, scrupolo scientifico e produzione mitologica, ricostruzione documentaria e proliferazione leggendaria. Il tutto grazie a una costante attenzione al dettaglio – entro cui, come diceva travisando Flaubert, si nasconde ogni forma di divinità. Riconosciuta o meno.
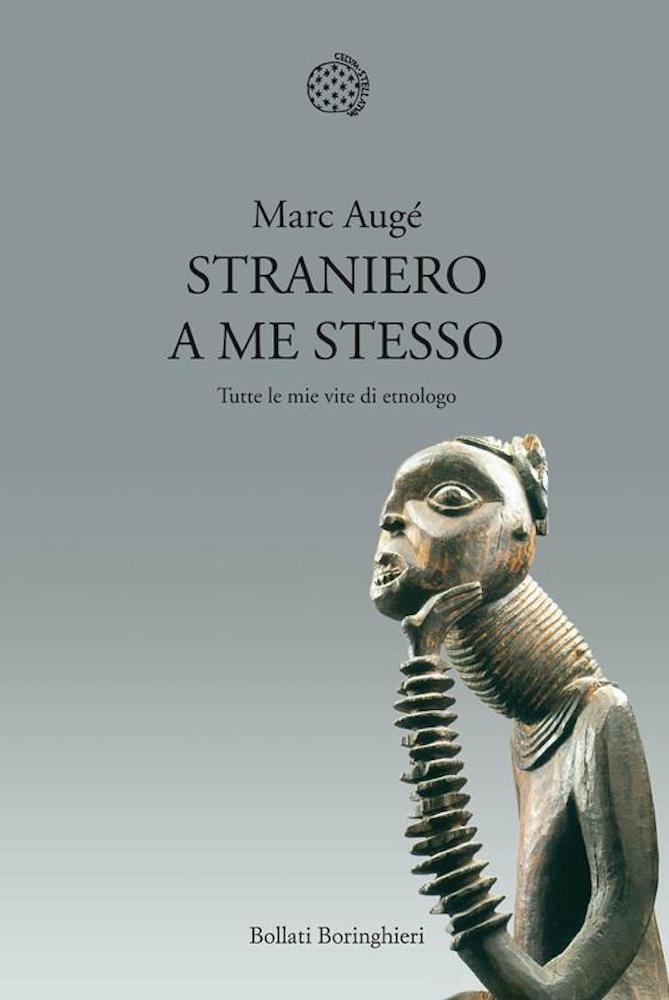
Marc Augé era un antropologo a tutto tondo. Da una parte – come si dice in gergo nella tribù accademica di cui, per disposizione ministeriale, faceva parte: quella appunto degli antropologi – aveva i suoi propri selvaggi, come dire il suo terreno privilegiato di indagine etnografica e di riflessione etnologica, tale per cui poteva ben essere definito e identificato come un africanista. Da cui i suoi lunghi soggiorni in Costa d’Avorio, Mali e Togo, dove s’era occupato soprattutto del nesso fra malattia, morte e sistemi religiosi – di cui sono testimoni libri come Le Rivage alladian (1969), Théorie des pouvoirs et idéologie (1975), Pouvoirs de vie, pouvoirs de mort (1977) o anche, in parte, Génie du paganisme (1982).
D’altra parte sapeva bene, e mostrava coi suoi ulteriori molteplici interessi, che un antropologo non è tale se non riflette sull’uomo in generale, e su ciò con cui questo oggetto misterioso chiamato così, l’uomo, entra in relazione: altri esseri viventi, il cosmo, la cosiddetta natura, l’immaginario socio-culturale nel suo complesso. Era la lezione che il suo grande maestro, Claude Lévi-Strauss, americanista per marchio professionale e instancabile interprete d’ogni dato umano (macro o micro che sia), gli aveva ben impartito: il famigerato sguardo da lontano verso mondi altri ha senso e valore se, e solo se, lo si punta anche verso di noi, verso quel che crediamo essere noi stessi.
E trovano qui collocazione i suoi innumerevoli scritti su centri commerciali e ville in vendita, bistrot parigini e servizi di trasporti urbani, biciclette e resti archeologici, Disneyland, torri gemelle, cinema d’antan etc., ossia su quella che egli stesso ha definito – inaugurando un filone saggistico oggi assai frequentato – antropologia dei mondi contemporanei o, a volte, delle società complesse.
“Non ho mai smesso di essere parigino”, ha scritto una volta, e ripetuto cento volte in colloqui e interviste. Cosa che faceva innervosire un po’ tutti: i parigini innanzitutto, stufi d’esser trattati come uomini primitivi tutti stupore e ferocia; gli altri etnologi, altrettanto, sempre pronti a separare i suoi studi puri e duri, quelli sull’Africa centrale, dagli altri scritti, considerati banale divulgazione.
Non senza una punta d’invidia da parte di entrambi i gruppi sociali, verosimilmente causata del grande successo che Augé, proprio grazie a questo suo potente sguardo binoculare, aveva avuto, a partire dal celebre saggio sui non luoghi in poi.

Difficile trovare una sintesi del suo pensiero. Quel che è certo è che, a differenza dell’opinione comune, Augé non ha ‘prima’ lavorato in Africa e ‘poi’ in Europa, abdicando dal duro mestiere dell’antropologo per farsi generico saggista. S’è piuttosto posto il problema, assai profondo, di riportare le meditazioni metafisiche provocate dall’indagine sulle culture altre a una società e una cultura che, per il fatto di essere le nostre, non sono per questo meno cariche di mitologie, di credenze, di ideologie sottese.
Da questo punto di vista, ribaltando la questione, tutte le società sono complesse: complessità differenti, forse, ma comunque tali. Schematizzando molto, l’interrogazione antropologica su alcune etnie africane gli ha suggerito che nulla va dato per scontato, soprattutto l’evidenza. Riguardando in particolare tre gigantesche questioni – l’individuo, il tempo, lo spazio – le quali, nel loro intreccio, costruiscono ogni volta in modo diverso quella cosa che, in mancanza di meglio, continuiamo a chiamare soggettività.
Così in molte culture altre l’idea stessa di individuo non ha ragion d’essere: ad assumere la dignità di persona sono entità collettive, famiglie variegate, gruppi clanici, tribù, quasi mai entità singole (si veda la voce “Persona”, da lui scritta per l’Enciclopedia Einaudi). Non a caso il corpo non è mai proprietà individuale ma entità collettiva, corpo sociale che non trascende l’individuo singolo ma piuttosto lo fonda, lo gestisce, decretandone nascita e morte, salute e malattia.
Cosa che, per contraccolpo, porta a chiedersi se nelle nostre società occidentali moderne esistano per davvero gli individui, e se il famigerato conflitto fra singolo e collettività non sia piuttosto una forma di negoziazione continua o, per dirla difficile, una morfogenesi dinamica che costituisce singolarità molteplici. L’io è un altro: lo sanno i poeti, lo confermano gli antropologi. Leggere un libro come Perché viviamo? (2003) significa farsi investire da tali questioni.
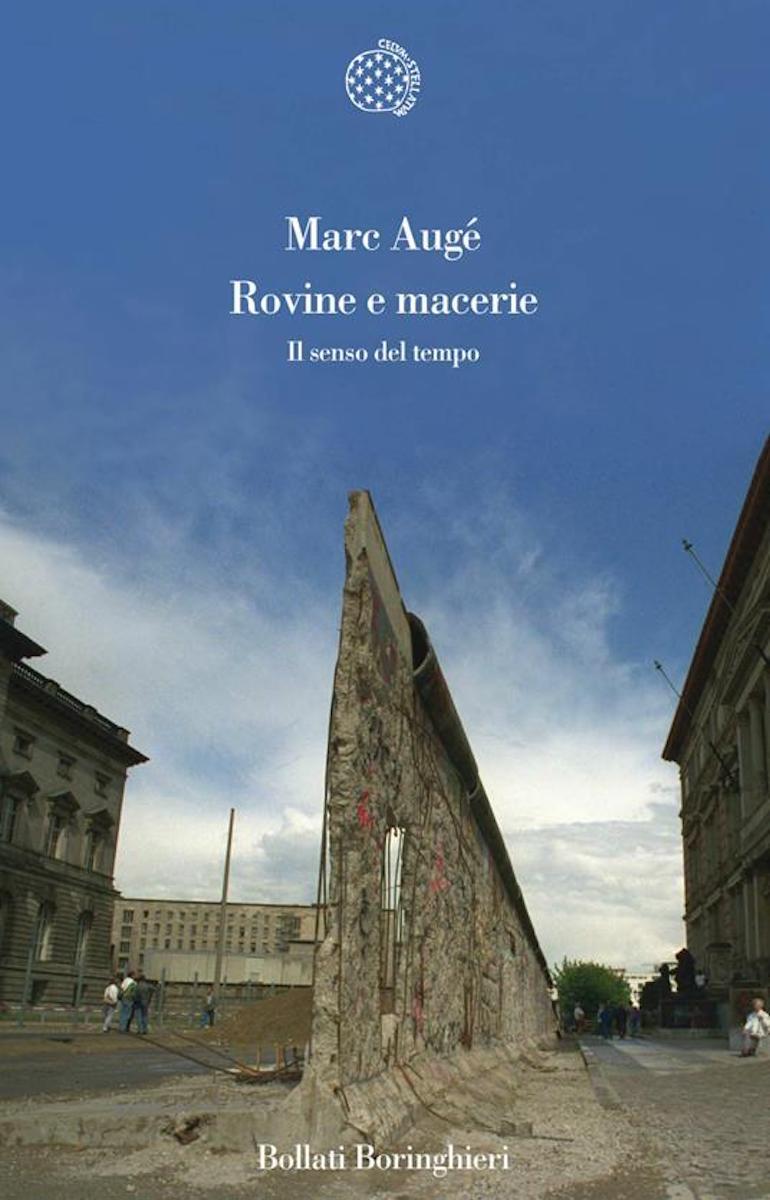
Non da meno la questione del tempo, del senso del tempo, esplorato, fra gli altri, in uno straordinario volumetto intitolato Rovine e macerie (anch’esso del 2003), ma anche in testi come Le forme dell’oblio (2001) e Che fine ha fatto il futuro? (2008), dove ci si interroga su cosa significhi passato, presente e futuro nella nostra cultura.
E se abbia ancora un significato conservare questa triade sbilenca, oggi sempre più spesso pendente dal lato del presente, anzi, per dirla con François Hartog, del presentismo. Anche qui, lo specchio deformante dell’alterità aiuta parecchio: altrove il tempo non esiste, o per meglio dire il suo scorrere ha tutt’altri ritmi, assai più lenti, e tutt’altro orizzonte, decisamente più ampio. È a partire dall’eternità, forse, che riesce possibile articolare le scansioni temporali.
Così, tornando all’Occidente, qualcosa del genere si ritrova secondo Augé nelle rovine, entità che oltrepassano il tempo storico per entrare in un regime dove il tempo non ha più cronologia, di modo che un presente stiracchiatissimo trascina entro di sé il passato che le ha generate e il futuro a cui vengono per principio consegnate.
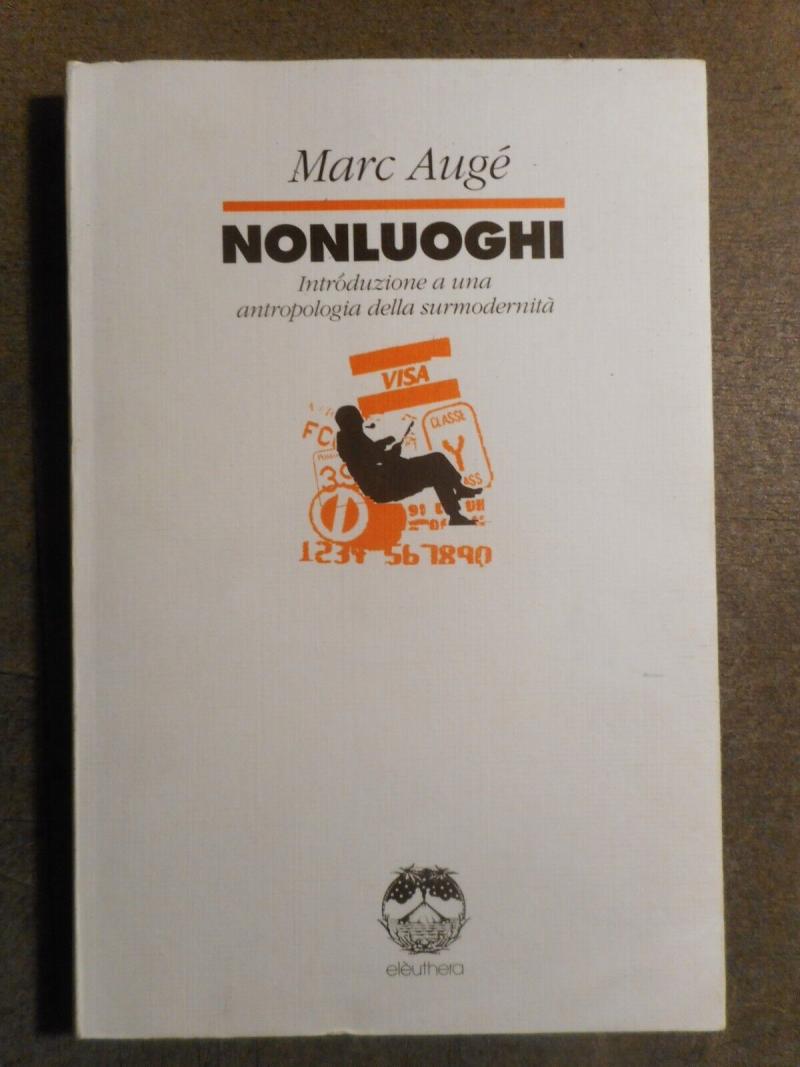
E, lot least, lo spazio. A cui sicuramente Augé dedica particolare attenzione, in quanto, a suo avviso, è solo in situazione, o se si preferisce in situ, che si costituisce e ricostituisce, si dà e si trasforma, la soggettività. È così che, oltre al celeberrimo testo sui Non-luoghi (1992) Augé torna sul tema occupandosi di velocipedi (Il bello della bicicletta, 2008), di trasporti urbani (i due libri sul metrò), di siti archeologici (il già citato libro sulle rovine), come anche, lo si è accennato, di confini e frontiere (Per una antropologia della mobilità, 2007).
Dei non luoghi sappiamo tutto? Forse: sappiamo che in essi – centri commerciali, autogrill, aeroporti, stazioni… – Augé vedeva la cifra di quella che chiamava surmodernità, un’epoca che, secondo lui, oltrepassa il postmoderno per condurre l’individuo verso la solitudine del consumismo. E sappiamo altresì che l’opposizione fra luogo antropologico (identitario) e non luogo (anonimo) è assai rigida, data l’esistenza di innumerevoli spazi intermedi o, che è lo stesso, di tattiche diffuse, silenti, pervasive di resistenza e di risemantizzazione. Così, per dirne una, Augé non poteva prevedere, forse per sua fortuna, che l’irrompere clamoroso del telefonino (e oggi dello smartphone) avrebbe dato ai suoi non luoghi tutt’altro senso e tutt’altro valore. Un centro commerciale, come anche una sosta in autostrada, non producono solitudine ma socializzazione.
Per non parlare dei social media, che, mettendo i non luoghi in soffitta, se li stanno ritrovando in stanza da letto. Appare inoltre abbastanza chiaro come oggi siano proprio quelli che Augé considerava perfetti luoghi antropologici (centri storici, villaggi di campagna, monumenti) a farsi impressionanti non luoghi, a causa dei flussi turistici sempre più pressanti e presenti che li consumano in tutti i sensi.
Oggi che Augé non c’è più ci consegna insomma, al di là delle diatribe di scuola, una gran quantità di interrogativi cui provare a rispondere. Come dire: un altro autore da ripensare, un’altra bibliografia da rivisitare, un’altra eredità da gestire.
Leggi anche:
Marc Augé | Della città e del tempo / Basilico: un fotografo
Ugo Morelli | Legami sociali / Gratuità e prendersi cura
Matteo Bianchi | Riti e miti del pallone / Augé e la religione del calcio
Giacomo Giossi | Dueruote. Intervista a Marc Augé
Mauro Portello | L’interluogo di Augé. La vecchiaia non esiste
